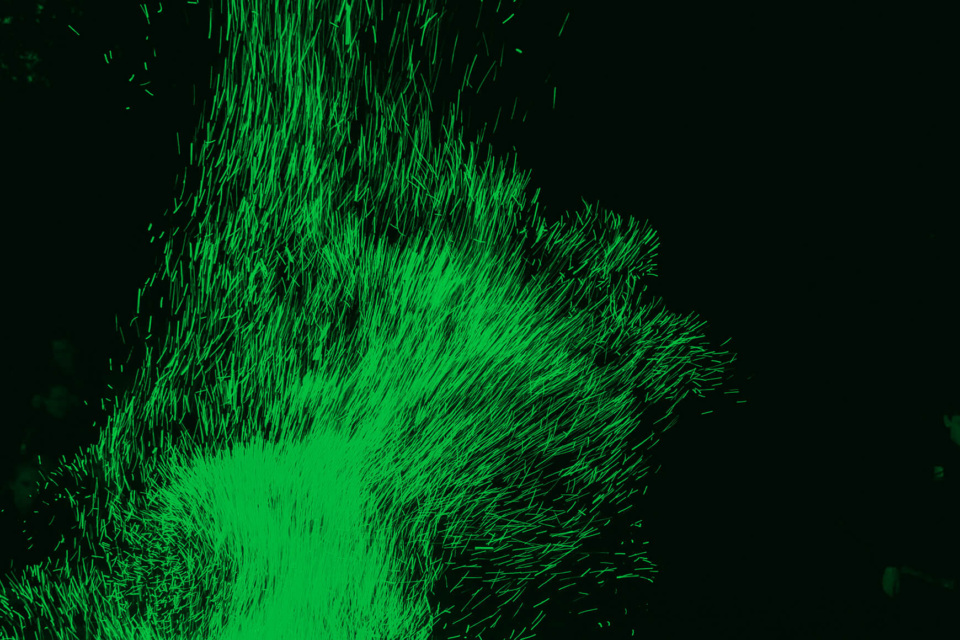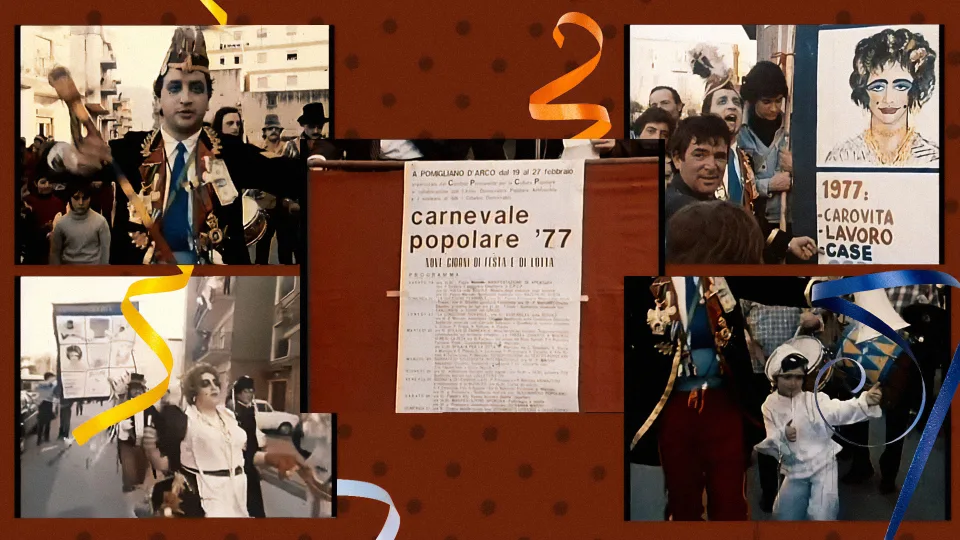L’ambiente accademico e militante filo-palestinese si sta dividendo attorno ai concetti di posizionalità, colonialismo e identità. Ma quali sono le posizioni in campo? E come fare a ritrovare l’unità di fronte a una tragedia umanitaria?
Le manifestazioni per la Palestina sono partecipate ma potrebbero esserlo di più. È il narcisismo delle piccole differenze a dividere? La società italiana (e occidentale) è anestetizzata alla violenza in Palestina e Libano? O è la repressione del governo postfascista guidato da Giorgia Meloni a far desistere le persone?
Ognuna di queste risposte contiene un elemento di verità, ma c’è forse un altro elemento nel discorso critico – intellettuale e politico – che merita attenzione: una torsione identitaria che favorisce la frammentazione invece che le alleanze. Alcuni parlano di intersezionalità ma intendono identità.
Il problema è presto detto: a fronte di quello che secondo la Corte Internazionale di Giustizia può configurare un genocidio e che per vice presidente della Commissione Europea Joseph Borrel è una pulizia etnica, le piazze italiane sono oggettivamente tiepide. Una delle ragioni è che le parole d’ordine che le hanno convocate a volte – e non di rado – sono percepite come discutibili. Negli ultimi mesi ci sono stati dei tentativi da parte di alcuni movimenti di contestare alcuni di questi presupposti. Davanti a questa confusione, c’è stato anche chi ha tentato di spiegare che stare con i palestinesi massacrati non significa approvare il massacro di Hamas del 7 ottobre – che ha tanto una dimensione anti-coloniale quanto pogromica – così come denunciare il colonialismo israeliano non può voler dire stare con la “resistenza” di Iran e Houthi.
Una delle risposte che sono arrivate è che tra sinistra e Hamas il problema sia la sinistra. In alcuni contesti militanti e accademici, la reazione più comune alle posizioni critiche sopra elencate recita: se non sei lì o di lì non puoi parlare. Chi non è oppresso in prima persona, tacesse. Questa strategia retorica si legittima attraverso dubbi ricorsi alla questione della posizionalità – la consapevolezza dei propri privilegi e del luogo da cui si parla. Tuttavia, quando la filosofa Gayatri C. Spivak introdusse questo concetto non intendeva certo dire che l’identità vittimaria potesse fungere da lasciapassare per ogni cosa.
Al cattivo uso della “posizionalità” si somma inoltre il prevalere della lente decoloniale su quella postcoloniale. Può sembrare un problema accademico, di lana caprina ma non è così.
Se si stabilisce il principio per cui qualunque cosa faccia un soggetto oppresso è giusta in virtù della sua identità, la discussione non può che terminare. Il problema pratico è che senza discussione non si dà possibilità di alleanza e azione. Trincerati nell’indiscutibilità assertiva della propria ragione, refrattari al ripensamento, si resta soli. In questo arroccamento, il prevalere della lente identitaria decoloniale su quella universalista postcoloniale ha giocato un ruolo importante.
Postcoloniale vs decoloniale
Gli studi postcoloniali hanno cercato di creare un “universalismo concreto”, un universalismo critico delle gerarchie razziali moderne che lo segnavano, ma pur sempre collocato su un piano non identitario. Un universalismo concreto rimanda ad un’universalità non selettiva, non deformata dalla supremazia razziale. È un progetto politico che non camuffa volontà coloniali – il fardello dell’uomo bianco, l’esportazione della democrazia, l’uso dei diritti umani per fini di egemonia regionale. Varie sono le possibili genealogie delle scuole di pensiero postcoloniale e decoloniale. La prima ha confini mobili, vi rientrano tanto l’Edward Said di Orientalismo quanto Gayatri Spivak e la scuola dei Subaltern Studies (di Ranajit Guha e Partha Chatterjee e Dipesh Chakrabarty) nonché l’antropologia di Arjun Appadurai.
Solidali con questa declinazione del postcolonialismo sono anche, a diverso titolo – e talvolta contesi dai decoloniali –, i marxismi eterodossi di Stuart Hall e Paul Gilroy, il trotskismo di C.L.R. James, il radicalismo abolizionista di Angela Davis o, volendo, il pensiero anticoloniale di Frantz Fanon (molto usato e abusato nell’ultimo anno), o le riflessioni sulla doppia coscienza di W.E.B. Du Bois.
Ad ogni modo, comune a questi punti di vista è il fatto che i suoi aderenti siano collocati, in modo certamente critico, dentro la tradizione dell’Illuminismo. Questa è la prospettiva dalla quale scrive ad esempio Chakrabarty in Provincializzare l’Europa: “La ricerca postcoloniale è impegnata, quasi per definizione, ad affrontare criticamente quegli universali – come le figure astratte dell’‘umano’ e della Ragione – che, perfezionatesi nell’Europa del Settecento, costituiscono il fondamento delle scienze umane”. E ancora: “La battaglia di Frantz Fanon a sostegno dell’idea di umanità dell’Illuminismo – anche quando sapeva che l’imperialismo europeo l’aveva ristretta alla figura del colono bianco – fa oggi parte dell’eredità intellettuale globale di tutti i pensatori postcoloniali. (…) non è facile fare a meno di tali universali”.
In modo certamente schematico si può dire che questo insieme di pensatori si sono occupati di compiere anzitutto una critica del soggetto politico moderno occidentale e della società che ne emerge: una società segnata dalla linea del colore, dalla “razza”. Intorno a questa si struttura la distribuzione delle risorse materiali e simboliche. Tanto negli Stati Uniti dell’apartheid, quanto nella colonia algerina, o nelle democrazie nazionali occidentali, imperiali o meno che siano, il razzismo, a diverse intensità, continua a strutturare il discorso politico e culturale. La violenza razziale varia ma la segmentazione della società resta.
“Le manifestazioni per la Palestina sono partecipate ma potrebbero esserlo di più. È il narcisismo delle piccole differenze a dividere? La società italiana (e occidentale) è anestetizzata alla violenza in Palestina e Libano?”
L’obiettivo postcoloniale è quello di costruire democrazie veramente universalistiche, dove non ci siano soggetti meno umani di altri. L’identità, in questo caso, è declinata in termini di ibridazione e, quando viene essenzializzata, ciò avviene in termini temporanei e volti alla loro abolizione. Spivak sosteneva che l’identitarismo fosse accettabile in modo politico e temporaneo in quello che chiamava “essenzialismo strategico”. Oltre a dire che molte nazioni usano il riferimento alla propria cultura per violare i diritti umani, Spivak si disse a favore di un “regionalismo critico”, ossia di una politica che superasse lo spazio angusto dello stato-nazione e che si ponesse il compito della redistribuzione delle risorse.
Il principale punto di discussione tra le tradizioni intellettuali decoloniali e postcoloniali ruota intorno ad un’accusa degli esponenti della seconda scuola ai primi. Secondo gli studiosi decoloniali, quelli postcoloniali sarebbero troppo implicati nel pensiero occidentale. Sia per i riferimenti – troppo francesi, troppo marxisti –, sia per la posizione geografica – troppa accademia anglofona –, sia per le implicazioni – troppo universaliste. Il punto di vista decoloniale, al contrario, insiste sul nesso potere-sapere (che pure è di marca foucaultiana) e trasla sul piano culturale il delinking – lo scollamento, la separazione – che l’economista Samir Amin pensava per i rapporti economici tra paesi decolonizzati e paesi capitalistici.
La scuola decoloniale ha un’origine più recente rispetto a quella postcoloniale, è di marca più sociologica, emerge in dialogo con la tradizione dei sistemi-mondo dello storico Immanuel Wallerstein e delle teorie sullo sviluppo ineguale e dello “sviluppo del sottosviluppo” di Andrè Gunder Frank, e viene dal Sudamerica. Il progenitore, per così dire, del decolonialismo, è l’argentino Raul Prebisch, economista e poi segretario del dipartimento dedicato allo sviluppo e al commercio delle Nazioni Unite (UNCTAD), che introdusse la teoria dello scambio ineguale: se i paesi colonizzati si concentrano solo sull’esportazione di beni a basso contenuto tecnologico non potranno mai emanciparsi e rimarranno sempre subordinati nella divisione internazionale del lavoro. Gli esponenti più noti del pensiero decoloniale sono Anibal Quijano, Rafael Grosfoguel e Walter Mignolo.
La principale lezione di questa scuola è la riscoperta dei saperi indigeni, delle culture native, delle tradizioni ancestrali e non moderne. Talvolta questi propositi, come nel caso degli ultimi lavori di Mignolo, sfociano in un sostanziale supporto di regimi autoritari (Cina, Russia e Iran) in quanto stati-civiltà non occidentali. Mignolo coniuga un culturalismo reazionario con il campismo antimperialista per cui tutto ciò che non è occidentale è buono. In quest’ottica, Cina, Iran e Russia sono gli alfieri di un modello positivo in quanto stati-civiltà capitalisti (ma non neoliberali) che “disubbidiscono” all’ordine internazionale guidato dall’Occidente. Secondo lui, con ogni probabilità, questi paesi possono aprire a un nuovo ordine internazionale migliore di quello attuale. L’esito però è il rafforzamento delle identità dei due campi.
Se i postcoloniali mostravano la presenza della colonia nella metropoli e la persistenza della metropoli nella postcolonia, i decoloniali astraggono le due zone e le contrappongono in modo manicheo. In questo modo, il nemico diventa un astratto potere “coloniale-moderno-eteropatriarcale-capitalista”, senza che il rapporto tra queste categorie venga articolato. Così, sempre più si preferisce l’identitarismo decoloniale che restaura in modo nostalgico categorie profondamente dubbie come quella di autenticità, origine, tradizione. Invece che contestarle, abolirle e ridefinirle, buona parte del pensiero decoloniale le purifica cambiando il soggetto a cui le riferisce. L’esito di questo processo è un rinnovato essenzialismo che si presenta come benevolo in virtù del diverso soggetto – non bianco, “nativo” e oppresso – che lo reclama e del mutamento del contesto in cui si colloca.
Un altro uso del termine decoloniale è prettamente politico. Si sono infatti moltiplicati negli ultimi anni gli appelli a decolonizzare i curricula universitari, le istituzioni museali e più in generale il dibattito pubblico – e il successo in questo campo è rivendicato esplicitamente da Mignolo. Bisogna inoltre dire che in Sudamerica il pensiero decoloniale ha anche avuto una produttiva dimensione politica, di ispirazione di movimenti reali contro le politiche sviluppiste e neoliberali lì dispiegate.
Inoltre, anche in Francia il termine circola ampliamente nei movimenti antirazzisti – che non necessariamente aderiscono al discutibile punto di vista “decoloniale” di Houria Bouteldja. L’uso del vocabolario decoloniale serve ad articolare critiche alla condizione dei cittadini postcoloniali nelle banlieue sempre più trattati come nemici interni. Bouteldja, con il suo partito degli Indigènes de la République, ama le provocazioni – anche perché così non può esser criticata per quello che scrive: “scherzavo!”. Le critiche che pone sono giustamente rivolte alla doppia morale di molti politici e intellettuali francesi che usano l’universalismo repubblicano per reprimere e disciplinare le masse di cittadini postcoloniali escluse del paese.
Tra le provocazioni meno divertenti si può annoverare il suo elogio dell’ex presidente iraniano Maḥmūd Ahmadinejad, capace di dire che non ci fossero omosessuali in Iran a fronte della domanda capziosa sulla loro condizione rivoltagli in occasione di una seduta delle Nazioni Unite a New York. Per Bouteldja la sua risposta fu un “potente” schiaffo agli esportatori della democrazia, complici del sionismo e responsabili di Abu Ghraib ma interessati a esportare femminismo e diritti per gli omosessuali. Bouteldja, a buon diritto, critica le ipocrisie e il razzismo occidentali ma finisce per costruire nuove identità astratte e pericolosamente definite – e legittima, in nome dell’identità subalterna, il maschilismo. Inoltre, nella sua lettura, gli ebrei (che pure non sono affatto tutti bianchi) diventano un monolite alleato aggressivamente con tutti i bianchi in nome, ovviamente, del sionismo – termine proxy di colonialismo occidentale.
Come è forse evidente, c’è quindi un forte scarto tra le due prospettive, ossia tra l’universalismo ridefinito del postcolonialismo e l’identitarismo nostalgico dei decoloniali. Ma la consapevolezza di questo scarto rimane spesso confinata all’accademia, peraltro costretta a difendersi, negli Stati Uniti, dall’accusa di wokismo e cancel culture, in Francia di islamogauchisme.
Israele-Palestina, contro l’identitarismo
Questo è altrettanto visibile nel dibattito su Israele-Palestina, in particolare nel mondo anglosassone, ma in misura minore anche in Italia. Il richiamo a decolonizzare la Palestina, oltre a riferirsi all’opposizione all’occupazione della Cisgiordania, rimanda all’opposizione a qualunque presenza ebraico-israeliana nella regione. La lente anticoloniale serve a comprendere le caratteristiche di una colonia di insediamento che, costruendo un dominio razziale di una certa popolazione su un’altra, tende a espellere, sterminare e assorbire la seconda. E serve a lottare contro di essa.

Alcuni argomenti però ruotano intorno alla precedenza della popolazione palestinese in Palestina rispetto a quella ebraica. Gli ebrei non avrebbero diritto a rivendicare una loro sovranità lì perché si basano su fonti bibliche non attendibili e vengono da altrove, non sono quindi “nativi”.
Credo che questo dibattito sia deleterio – infatti, oltre al movimento di estrema destra messianico, vi prende parte anche l’ideologo Bernard-Henry Lèvy affermando la presenza ebraica da prima del ‘900. La questione di cui bisogna occuparsi è invece della violenza della Nakba, dell’espulsione di 750.000 persone dal luogo dove vivevano e dell’oppressione settantancinquennale dei palestinesi e del diritto al ritorno negato ai profughi palestinesi. Così come bisogna riconoscere la pretesa di una sovranità palestinese non fittizia. Nessuno stato può sorgere in una Cisgiordania con 700.000 coloni ebrei e senza continuità territoriale con Gaza. Altrettanto fermamente bisogna dire che i 7.7 milioni di ebrei che vivono in Israele non hanno nessuna Brooklyn a cui tornare (se non una minoranza). E che la sovrapposizione tra ebrei ed israeliani non porta a nulla di buono (vedi il caso di Amsterdam).
Alcune letture semplificate hanno permesso di accusare i critici di Israele di avere un pregiudizio anti-israeliano. Effettivamente sembrerebbe che il nazionalismo degli oppressi abbia una qualità radicalmente diversa da quello degli oppressori. E in parte è così: è infatti improprio condannare il nazionalismo di chi vive sotto occupazione ed è stato espulso da dove viveva. “La patria è un’idea stupida, a parte per chi ancora non ne ha una” disse il poeta palestinese Mahmud Darwish. Tuttavia bisogna sempre diffidare dal mito delle radici e delle origini. Se si vuole provare a pensare a un futuro dopo il massacro, bisogna quanto meno intendersi sulle implicazioni di un armamentario ideologico simile.
Così come il tema della posizionalità non può essere usato come ricatto. Certo bisogna essere consapevoli da dove si parla e chi si pretende di rappresentare, a chi ci si rivolge. E bisogna rispondere con forza all’indegna disumanizzazione dei palestinesi favorita da molti media e politici. Ma la condizione di oppressione non può essere un lasciapassare per qualunque cosa. Anche perché così facendo si cancellano le differenze, le lotte, gli scontri che pure esistono tra gli oppressi. Che strategicamente vengano messi da parte è comprensibile. Che si critichi aprioristicamente chiunque non sposa la linea dell’asse della resistenza lo è meno.
A tal fine è meglio dismettere le lenti decoloniali e nativiste fondate su legami autentici e originari con la terra e indossare gli occhiali postcoloniali che permettono di abolire (o quantomeno ridefinire) le identità etniche e religiose per fondare una nuova comunità che prescinda da sangue, suolo e radici.