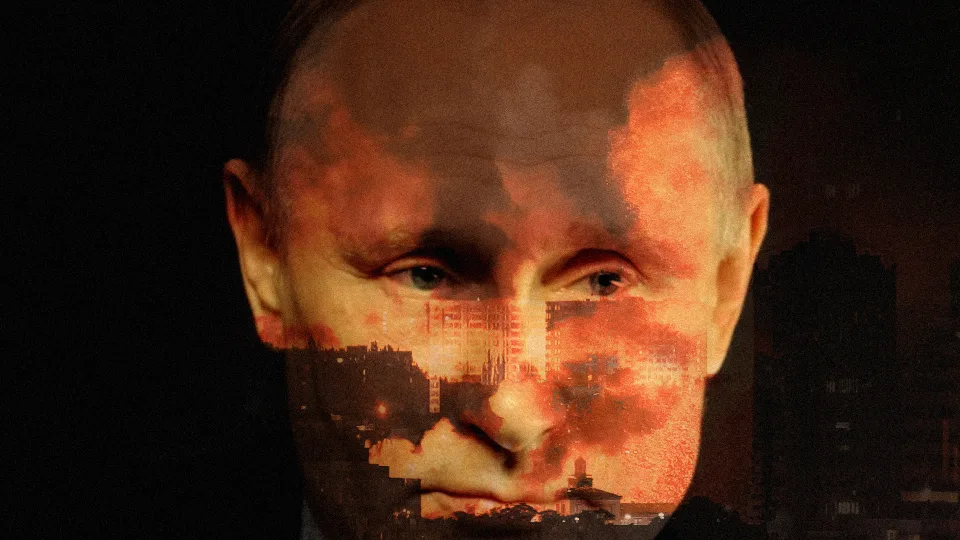Una conversazione con il giornalista Arash Azizi sulle correnti di potere e le reti di opposizione sotterranea al regime di Teheran.
Arash Azizi è un giornalista e storico iraniano americano. Scrive per «The Atlantic», «New York Times» e «Washington Post». Azizi, che è nato a Teheran, è una delle persone che in assoluto conoscono meglio il sistema giudiziario e politico della Repubblica Islamica e i movimenti di dissenso che, in modi più o meno clandestini, si oppongono al regime. Abbiamo iniziato la nostra conversazione parlando di Sala e del suo rilascio, per poi approfondire le dinamiche politiche che regolano un Paese complesso come l’Iran.
“A volte situazioni come quella di Sala rimangono in stallo per anni”, racconta Azizi. “Penso a Siamak Namazi, che ha passato nel carcere di Evin otto anni, dal 2015 al 2023. È entrato in carcere durante l’amministrazione Obama ed è uscito verso la fine dell’amministrazione Biden. O a Nazanin Zaghari-Ratcliffe, britannico-iraniana, che ha passato sei anni in prigione. È una grande felicità che Sala sia stata rilasciata, ma centinaia di prigionieri iraniani sono ancora lì, compresi molti cittadini con doppia nazionalità”.
Vale la pena ricordare, tra le moltissime storie di persone ancora detenute, la vicenda del ricercatore svedese-iraniano Ahmadreza Djalali, che ha anche lavorato a lungo in Italia, dove vivono sua moglie e i suoi due figli. Ahmadreza è nel carcere di Evin dall’aprile del 2016. E non si troverebbe in un settore qualsiasi, ma nel braccio delle morte, dato che su di lui pende dal 2017 una condanna alla pena capitale per spionaggio a favore di Israele. Quella condanna, che l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha definito arbitraria e scioccante, potrebbe essere eseguita in qualsiasi momento.
Stando al report 2023 di Amnesty International, l’Iran da solo pesava per il 74% di tutte le esecuzioni di cui si avesse notizia nell’anno solare: si parla di almeno 853 persone uccise. Va detto che il dato percentuale è falsato dal fatto che non abbiamo modo di conoscere il numero di persone giustiziate in Cina, e potrebbero essere migliaia. Non c’è dubbio, però, che sia l’Iran il secondo paese al mondo per numero di sentenze totali eseguite. Stando ai dati delle Nazioni Unite, il numero di giustiziati del 2024 sarebbe ancora più alto di quello dell’anno precedente: 901. Almeno otto di loro nel 2023 sarebbero stati uccisi per aver partecipato, a vario titolo, alle proteste del 2022. La condanna per i manifestanti è il reato che la Sharia iraniana codifica come Moharebeh, e che si può tradurre come “fare guerra all’ordine delle cose voluto da Dio”. Tra loro Milad Zohrevand, che aveva vent’anni.
L’ultimo libro di Arash Azizi, What Iranians Want, tradotto in italiano da Raffaele Cardone e pubblicato da Solferino col titolo L’Iran in fiamme, racconta quello che è successo dopo il 13 Settembre 2022, quando una ragazza di ventidue anni di nome Masha Amini è stata arrestata per “hijab non conforme” da agenti della Polizia Morale iraniana, che l’hanno poi picchiata a morte. Quella che seguì fu la più grande e tenace sollevazione contro il regime che la Repubblica Islamica avesse mai visto. L’Iran in fiamme di Arash Azizi, a cui Marino Sinibaldi ha di recente dedicato una puntata del suo podcast “Timbuctu”, comincia proprio raccontando le storie di alcune attiviste detenute nel carcere di Evin. Anche il padre di Arash, lo scrittore e produttore televisivo Mostafa Azizi, è stato in carcere a Evin, passandovi più di un anno prima di ricevere un’amnistia nel 2016.
“Stando al report 2023 di Amnesty International, l’Iran da solo pesava per il 74% di tutte le esecuzioni di cui si avesse notizia nell’anno solare: si parla di almeno 853 persone uccise”.
Ho chiesto ad Arash Azizi cos’è Evin, e perché è diverso dalle altre carceri iraniane: “Se non fosse tragico, sarebbe quasi ironico: i media parlano spesso della famigerata prigione di Evin, e non fraintendermi, è famigerata davvero, perché è gestita da un regime che viola i diritti umani e non ha alcun riguardo per la vita delle persone, lì si pratica la tortura, si vive in solitudine, si negano le cure ai prigionieri. Una particolarità di Evin è che esiste una sezione all’interno del carcere, la sezione 2A, che è gestita direttamente dal Dipartimento di Intelligence dell’IRGC (in italiano Guardie Rivoluzionarie, o Pasdaran), una milizia paramilitare che ha un enorme potere politico e che rappresenta la fazione più zelantemente conservatrice del regime. Eppure, e qui sta l’ironia a cui accennavo, in quanto a condizioni dei prigionieri Evin è molto meglio di altre carceri iraniane. La verità è che in Iran ci sono carceri molto peggiori e molto meno raccontate, come la prigione di Fashafouyeh, sempre a Teheran, per nominarne una”.
C’è un portale prezioso per chiunque sia interessato a conoscere le storie delle persone che sono ancora in carcere nella Repubblica Islamica: è l’Iran Prison Atlas, che dal 2011 ex prigionieri politici compilano e aggiornano. Le loro vicende sono ordinate per capo d’accusa, per anno di arresto, per etnia e per genere. Ricostruirle con chiarezza, però, non è per nulla semplice.
Questo perché dai racconti di chi è stato in carcere o ha seguito da vicino il sistema giudiziario iraniano emerge uno spaventoso quadro di arbitrarietà. Il regime colpisce in un modo imprevedibile, la durata della pena e le ragioni della detenzione sono spesso un mistero per le stesse persone imprigionate. Le giornaliste e i giornalisti sono tra le categorie in assoluto più colpite. Racconta Arash Azizi: “Noi giornalisti che abbiamo lasciato l’Iran siamo relativamente più al sicuro, ma penso ai miei amici, Pouria Zeraati, Farhad Farahzad, Sima Sabit: il regime ha cercato di rapirli o assassinarli all’estero, da Londra a New York. A volte ci è riuscito, a volte ha escogitato delle vere e proprie trappole. Vorrei che non dimenticassimo Ruhollah Zam, che era un grande giornalista iraniano, e che è stato attirato in Iraq, in un paese estero, rapito, spedito in Iran e giustiziato. Il regime iraniano ha già fatto cose come questa in passato. Certo, anche per noi all’estero è difficile: non possiamo visitare il nostro paese, forse non rivedremo più i nostri cari. Ma la vera lotta, sai, è quella dei giornalisti che sono rimasti in Iran. Loro pagano un prezzo altissimo, e io sono pieno di rispetto e ammirazione per il lavoro che fanno, nonostante tutto, resistendo a ogni pressione. In questo senso, mi sembra particolarmente significativo il caso di Hossein Yazdi, un giornalista molto patriottico, uno che chiaramente ama il suo paese. Non è nemmeno una figura ideologicamente vicina all’opposizione all’estero. È una voce critica, sì, ma ti faccio un esempio: quando Israele stava attaccando l’Iran, è stato il primo a condannare gli attacchi, a dichiarare che era pronto a combattere per l’Iran e a difendere il paese dagli attacchi israeliani. Eppure, anche lui è stato condannato al carcere. Penso che stia facendo ricorso, quindi non è ancora in prigione, l’appello è in corso. Ma è un esempio di come in Iran possa finire in galera una persona che non è nemmeno una vera minaccia per il regime: il suo crimine è stato condividere la propria opinione. Le prigioni iraniane sono piene di persone così”.
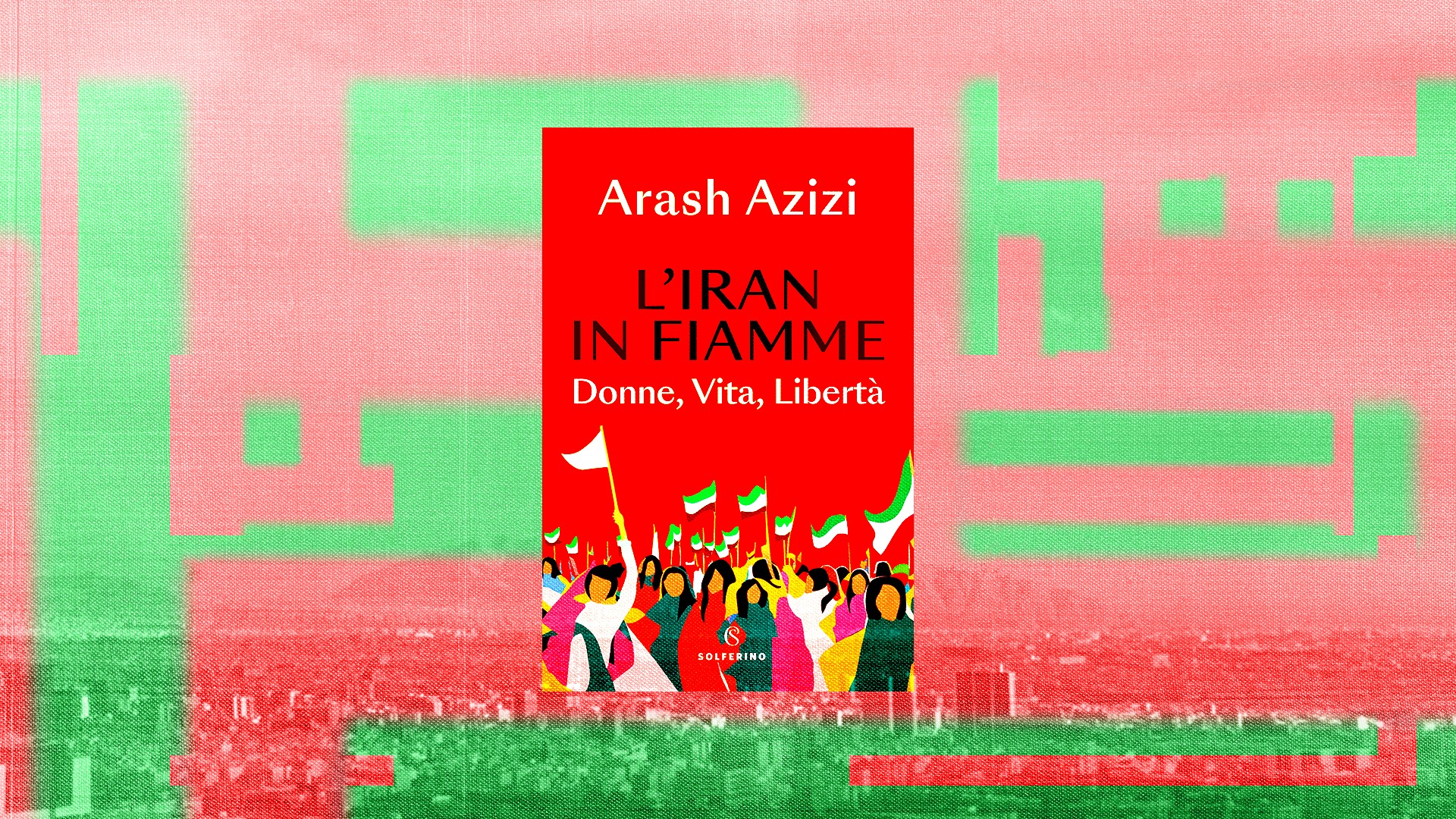
L’idea stessa che un condannato possa fare ricorso, in attesa di giustizia in un Paese che ha un concetto di giustizia ideologico e deforme, è una delle tante contraddizioni di un sistema politico che è molto più complesso di quanto sembri a noi occidentali. Il fatto è che in Occidente, mi spiegava Azizi, tendiamo a vedere il sistema politico iraniano come una sorta di monolite, molto compatto: non è così. L’equilibrio del potere nel regime è costantemente percorso da lotte tra correnti e fazioni, ma non c’è solo questo. C’è anche, nella coscienza degli iraniani, un modo molto più attivo e politico di intendere la cittadinanza rispetto ad altri paesi dell’area, anche rigidamente musulmani: vale la pena riportare, in tal senso, un passaggio di Leggere Lolita a Teheran (Adelphi, 2003), il romanzo-memoir di grande successo della scrittrice e accademica iraniana Azar Nafisi:
“Dissi che la mia integrità di insegnante e di donna era compromessa dall’imposizione ricattatoria del velo, in cambio di qualche migliaio di tuman di stipendio. Il problema non era il velo in quanto tale, ma la libertà di scelta. Mia nonna si era rifiutata di uscire di casa per tre mesi, quando altre leggi l’avevano costretta a toglierselo. Io sarei stata altrettanto tenace nel rifiuto di portarlo”.
Una delle ragioni della tenacia dei movimenti di protesta iraniani, di questa naturale spinta alla cittadinanza attiva, è che la Repubblica Islamica non è, come l’Arabia Saudita o il Qatar, una monarchia con a capo una casa reale le cui origini si possono far risalire almeno fino al quindicesimo secolo se non, ripercorrendo le dinastie tribali, fino a Maometto. La Repubblica Islamica dell’Iran è figlia di una rivoluzione compiuta nel 1979, durante quella che, probabilmente, è stata la stagione più politicizzata della storia umana: questo le cittadine e i cittadini iraniani lo ricordano bene.
Dice Azizi: “Una cosa che forse i media occidentali faticano a comprendere è quanto sia estesa e varia la rete delle organizzazioni iraniane che lottano contro il regime: esistono una miriade di movimenti sindacali, movimenti femministi, movimenti ambientalisti, movimenti per la libertà artistica, movimenti di registi, movimenti di lavoratori in pensione: è una coalizione varia e colorata quella che lotta contro la Repubblica islamica, e non ha cominciato a esistere nel 2022: è semplicemente uscita allo scoperto. Ma esisteva da prima e continua a esistere oggi”.
“Una delle ragioni della tenacia dei movimenti di protesta iraniani è che la Repubblica Islamica non è non è una monarchia le cui origini si possono far risalire fino a Maometto, ma è figlia di una rivoluzione compiuta nel 1979”.
Il sociologo Juan José Linz descrisse il sistema di governo iraniano come una forma statale “che ha la piega ideologica del totalitarismo e il pluralismo limitato dell’autoritarismo”. Forse la definizione è addirittura riduttiva: c’è un’asincronia sorprendente tra la repressività della “piega ideologica” e il livello di coinvolgimento civico della cittadinanza, e un altro elemento in apparenza contraddittorio ci aiuta a comprendere meglio di cosa stiamo parlando: in Iran si vota. Le elezioni iraniane sono partecipate e vi concorrono uomini politici (le donne non sarebbero, per legge, escluse dalla candidatura alla presidenza. Almeno, non formalmente. È complicato, ma se ne discute) appartenenti a correnti ideologiche diverse e persino contrapposte, entro certi (rigidi) limiti. A dettare questi limiti è un leader supremo non eletto, l’Ayatollah, attraverso un Consiglio dei Guardiani composto per metà da giuristi islamici. È il Consiglio dei Guardiani a decidere chi può e chi non può concorrere alle elezioni per il Presidente, che resta però una figura elettiva, come sono elettivi tutti gli organi di rappresentanza locale. Anche da elezioni così controllate e manipolate emerge chiaramente che esistono, nella Repubblica Islamica, una molteplicità di correnti e di fazioni che hanno bisogno del sostegno popolare per guadagnare posizioni di potere. Le ultime elezioni presidenziali, che si sono tenute nel luglio 2024, sono state vinte da un “riformista”. Massoud Pezeshkian ha battuto l’ultraconservatore Saeed Jalili, e non è una cosa da poco: non succedeva dal 2005. È possibile che, in piccolo, la vicenda di Sala rispecchi questo cambio negli equilibri di potere del regime.
“È molto probabile che sulla liberazione di Cecilia Sala si sia combattuta un’invisibile battaglia politica interna”, dice Azizi. “Esiste una frattura tra coloro che vogliono che l’Iran negozi con l’Occidente e coloro che, invece, sono decisi a preservare a ogni costo l’eredità rivoluzionaria e antioccidentale dell’Iran. È un segno di speranza, quindi, che Sala sia stata rilasciata relativamente presto. Significa che gli estremisti (hardliners) stanno perdendo delle battaglie. Dopodiché, non bisogna essere ingenui: l’Ayatollah Khamenei ha preso spesso posizione al fianco degli intransigenti. E, si sa, la Guida Suprema continua ad essere l’uomo più potente in Iran”.
“Dice Azizi: ‘I media occidentali forse faticano a comprendere è quanto sia estesa e varia la rete delle organizzazioni iraniane che lottano contro il regime: movimenti sindacali, femministi, ambientalisti, per la libertà artistica, di registi, di lavoratori in pensione…'”.
Arash Azizi parla spesso di speranza, ed è pieno di speranza anche il suo libro. Sembrerebbe un controsenso. Il movimento “Donna, vita, libertà” (era questo slogan delle manifestanti del 2022) è stato silenziato da un’ondata di repressione di una durezza sproporzionata. Le forze di sicurezza iraniane sarebbero direttamente responsabili dell’uccisione di almeno 537 manifestanti soltanto negli scontri dei primi mesi. Gli arresti sarebbero stati almeno ventimila. Oltretutto, nei due anni trascorsi dallo scoppio delle proteste, le posizioni internazionali della Repubblica Islamica si sono fatte ancora più oltranziste, la retorica dei capi politici ancora più paranoica, e sono più frequenti che mai i riferimenti a nemici invisibili (a volte più, a volte meno immaginari) che provano a infiltrarsi nello Stato per minare dall’interno la stabilità. E poi: le catastrofiche sconfitte militari e di intelligence dell’ultimo anno, lo smantellamento di Hamas ed Hezbollah, completamente impotenti di fronte all’avanzata feroce dell’esercito Israeliano, e la caduta dell’alleato Assad in Siria, rendono ancora più isolati, sul piano internazionale e su quello interno, gli apparati statali iraniani più legati alle fazioni conservatrici. Se possibile, questi ultimi sono ancora meno aperti al dialogo oggi di quanto non lo fossero allora. Eppure, Azizi non crede che le proteste del 2022 siano state inutili. Di più, non crede nemmeno che quel movimento abbia smesso di esistere.
“L’Iran è cambiato molto. Una prova piccola ma tangibile di questo è che milioni di donne iraniane continuano a compiere l’atto di resistenza di non indossare l’hijab, e lo fanno correndo enormi rischi. Ma anche il fatto che a un riformista sia stato permesso di candidarsi e vincere la presidenza, il fatto che molti dei sostenitori della linea dura siano stati emarginati, sono la prova del successo di quella protesta popolare. Anche il dato dell’affluenza alle scorse elezioni manda un segnale fortissimo: il 60% degli aventi diritto non ha votato al primo turno, il 50% non ha votato al secondo turno. Si tratta dell’affluenza più bassa nella storia delle elezioni presidenziali in Iran. Anche questo è un segnale che il dissenso è ancora vivo. Il movimento del 2022 ha lanciato forte e chiaro il messaggio che gli iraniani rifiutano lo status quo. E quel messaggio non può essere ignorato”.
Dice così l’epilogo di Leggere Lolita a Teheran: “Ho lasciato l’Iran, ma l’Iran non ha lasciato me. Da quando io e Bijan siamo partiti sembra che siano cambiate molte cose. Manna e tutte le altre donne camminano a testa alta, o quasi; il velo è sempre più colorato, la veste sempre più corta; adesso si truccano e passeggiano liberamente con altri-uomini che non siano i fratelli, i padri o i mariti. Le retate, gli arresti e le esecuzioni pubbliche, invece, continuano. Eppure, c’è una richiesta sempre più forte di libertà”.
Il libro è del 2003, e forse è meno ingenuo di quanto sembri immaginare che siano state le stesse donne di questo finale, o le loro sorelle, figlie, amiche o amanti, a prendersi le piazze poco più di vent’anni dopo. Chissà, magari, tra altri vent’anni, non leggeremo più di attiviste e giornaliste detenute nelle carceri di Teheran.