Ne "La pietra della strega", edito da Bompiani, la scrittrice Sinéad Gleeson si immagina un'isola remota che accoglie e guida la vita dell'artista Nell e di coloro che la circondano, avvolgendo chi legge in un'atmosfera misteriosa e inquietante che evoca scenari onirici e svela qualcosa del mistero del processo creativo.
Un’isola “fottuta” dalle onde lungo la costa occidentale dell’Irlanda, senza nome ma con una geografia precisa: la spiaggia di Banshla, quella di Greenawn e di Cloughkeel, Dodder Bay, il faro, il paese con l’immancabile pub e il supermercato-emporio, e Rathglas, un antico convento-fortezza dove vive una comunità di recluse, le Iníon, in irlandese “Figlie”. Un’isola su cui periodicamente e in modo imprevedibile si abbatte un suono misterioso che non tutti riescono a sentire, e dove vive Nell, un’artista che si interroga sulla sua identità e sopravvivenza (si arrangia facendo la guida turistica) e che con l’isola ha un legame indissolubile.
“L’isola è parte del mio corpo. Come se i sassi della spiaggia fossero incorporati nei miei piedi… o come se in un angolo dei miei polmoni ci fossero anche l’aria e l’acqua di mare”.
Sono le coordinate su cui Sinéad Gleeson ha costruito il suo primo romanzo: La pietra della strega (Bompiani, traduzione di Patrizia Managò), dopo due raccolte di saggi: Constellations, Reflections from Life (2019) e Un lavoro da donne, Saggi sulla musica (Sur, 2023) con Kim Gordon.
Qualsiasi sito wicca vi dirà che le hagstone, le pietre forate o pietre della strega, sono usate negli incantesimi per favorire la guarigione, la fortuna, la protezione, il contatto con gli spiriti. In Irlanda, Cailleach è una megera con un solo occhio, come il foro scavato nella pietra, ma hagstone giganti sono anche molte delle sculture di Barbara Hepworth, create nello studio-giardino di St Ives. Mentre parliamo su zoom, alle spalle di Sinéad Gleeson si intravede un poster della prima edizione di To the lighthouse di Virginia Woolf: anche se il romanzo è ambientato sull’isola di Skye, il faro a cui si ispirò è quello nella baia della cittadina della Cornovaglia.
Gleeson collabora molto spesso con artisti visivi e per La pietra della strega si è divertita a inventare opere immaginarie. Alla fine del romanzo c’è un lungo elenco di fonti e ispirazioni, da Maggi Hambling a Hilma af Klint, riferimenti alla land art di Beverly Buchanan e Agnes Denes e ad artisti performativi che confluiscono nel fanta-portfolio di Nell.
Si entra nella storia come i turisti sbarcano da un traghetto appena attraccato al porticciolo di un lembo di terra battuto dall’Atlantico, aspettandosi viste mozzafiato, angoli pittoreschi, il sublime creato dalla furia degli elementi. Ma appena messo piede a terra, o iniziato il libro, il turista/lettore sente che è necessario procedere con cautela: l’isola non ti accoglie con i colori psichedelici di villaggi leziosi come Kinsale, nella contea di Cork, una sfilata di sale da tè, negozi di specialità e souvenir. Il supermercato dell’isola vende ciarpame di plastica a tema marinaresco, il piccolo albergo è desolato e quando li porta a fare un giro, ai turisti Nell racconta di naufragi e marinai fantasma, di ponti stregati, dei trecento giorni di pioggia all’anno. E del suono.
In che mondo stiamo entrando? È un luogo distopico? Il tempo è presente o fuori dalla storia? Sull’isola senza nome aleggia un presagio minaccioso, su cui ancora prima dell’incipit getta un’ombra la citazione da Peter Grimes di Benjamin Britten (“Sento quelle voci che non si lasceranno mai sommergere”), un’opera ambientata anch’essa in una piccola comunità, a tratti claustrofobica, su cui incombe un mistero che porterà alla rovina del protagonista. Anche nel romanzo di Gleeson i temi sono l’isolamento, il pregiudizio, il potere corrosivo del gossip, ma l’enfasi è sull’artista come outsider, sulla necessità e la difficoltà della creazione, sul credere nella propria vocazione a dispetto delle avversità. Anziché “le voci”, c’è il suono che fa sanguinare le donne, uccide gli uccelli e spinge alla pazzia qualche isolano. Nell lo sente, lascia che la attraversi ma non ne viene travolta come accade a Cleary, il suo amante, che lo percepisce per la prima volta proprio quando il rapporto tra loro si fa più stretto. L’atmosfera è inquietante, unsettling.
“Unsettling è la parola perfetta, la prendo come un complimento”, dice Sinéad Gleeson. “Il luogo e l’atmosfera certamente lo sono. Ho cominciato a scrivere il libro molto tempo fa, prima di Constellations, e fin dall’inizio c’è sempre stato il suono. Ero ossessionata da questo ronzio che non è inventato: ci sono molti posti al mondo dove la gente sente un suono che non sa descrivere né spiegare, e che non tutti riescono a sentire. Mi interessava indagare chi lo avverte e chi no, e quale può esserne la causa. Volevo creare un’atmosfera di tensione, avvolgere il luogo nel mistero, e il suono è un modo molto interessante per farlo. Nel folklore irlandese ci sono molte storie su suoni misteriosi, spesso radicati nel paesaggio, potrebbero perfino emanare dal suolo, perciò per me non era strano includere quel fenomeno acustico”.
Lo sapeva bene W.B. Yeats, che andava nella contea di Sligo per entrare in contatto con le forze mistiche dell’isola, e insieme all’amata Maud Gonne poggiava l’orecchio a terra per ascoltare la musica delle fate. Una delle trentadue parole per “campo” di cui scrive Manchán Magan in 32 Words for Field, è cathairín, un campo in cui vive una fata. L’irlandese, scrive Magan, è una lingua che trasmette una visione magica del mondo naturale e soprannaturale, in cui le parole non solo descrivono le cose, ma hanno il potere di renderle reali.
“Si entra nella storia come i turisti sbarcano da un traghetto appena attraccato al porticciolo di un lembo di terra battuto dall’Atlantico, aspettandosi viste mozzafiato, angoli pittoreschi, il sublime creato dalla furia degli elementi”.
“Fa parte dell’irlandesità il fatto di non poter spiegare tutto”, prosegue Gleeson. “Eravamo un paese molto celtico e pagano prima dell’avvento del cristianesimo, con molte credenze soprannaturali. Se la storia fosse stata ambientata in città, non sarebbe stato altrettanto efficace, ma le isole sono luoghi misteriosi e remoti: per arrivarci devi prendere un traghetto o un aereo, e non sempre te ne puoi andare quando vorresti. È importante soprattutto per Nell, che usa l’isola come se fosse la sua tela. Una delle domande centrali del romanzo è: se andrà via, continuerà a fare arte, visto lo stretto legame con il luogo dove vive?”.
Ambientare la storia su un’isola al largo di un’isola più grande crea un effetto specchio: è un microcosmo che replica le dinamiche, i pregi e i difetti della terraferma – un’Irlanda in miniatura – resi più visibili dallo spazio ristretto che accentua la dimensione spirituale ed esaspera quella esistenziale.
“Le isole sono luoghi claustrofobici, dove tutti si conoscono e sanno tutto di te”, dice Gleeson. “Se lavori o sei disoccupata, con chi esci, se bevi troppo. Su un’isola non ti puoi nascondere, tutto è in piena vista ed è intensificato a causa della totale visibilità: è impossibile tenere segreti. Nell ha uno stile di vita non convenzionale e per questo viene giudicata: è doppiamente outsider in quanto donna che non vuole sposarsi e avere figli e artista. È weird, strana, per i ragazzi del posto non è wife material, da sposare, una definizione che lei trova confortante. Le isole sono scenari interessanti dove far agire i personaggi perché sono luoghi chiusi in cui è difficile vivere. C’è il ciclo delle stagioni, i flussi turistici che condizionano l’economia locale, i rifornimenti dalla terraferma possono essere irregolari. Ma c’è anche un forte senso di comunità: devi essere unito, altrimenti non ce la fai, il contratto sociale è molto forte. Una mia amica vive a Inishmore, nelle isole Aran, e per i primi due anni nessuno le ha rivolto la parola perché erano convinti che non avrebbe resistito e sarebbe andata via. Devi scegliere di vivere su un’isola. Per la mia storia era fondamentale”.
“Chi ha scritto che le isole per loro stessa definizione spingono a interrogarsi sulle origini?”, si chiede Nell quando decide di accettare la proposta di lavoro che le è arrivata da Rathglas, il convento dove vivono le Iníon. Nell ha un orto che la sfama, le piace cucinare con le spezie, ha una vita sessuale disinibita e preferisce incutere timore che compassione. A un certo punto viene chiamata strega. Anche sulle Iníon ci sono dicerie – che sono una congrega o una specie di culto survivalista – e su di loro cadono gli stessi sospetti. “Non ci vuole molto per scatenare le malelingue. Molte persone contemplano un solo modo di vivere, il loro”, dice Maman, che da trent’anni guida la comunità e che a Nell chiede di scrivere la storia delle Iníon.
“Le persone che non si conformano suscitano sempre paura e vengono giudicate, soprattutto se sono donne in una società eteronormativa”, commenta Gleeson. “Spinster (zitella), old bag (vecchiaccia), così vengono chiamate le donne nubili, senza figli. Negli anni Quaranta in Irlanda se aspettavi un figlio senza essere sposata finivi in un istituto per madri single o il bambino ti veniva tolto. La punizione era spietata. Per Nell non si tratta solo di libertà sessuale: è consapevole che una famiglia, un marito, dei figli renderebbero impossibile il suo lavoro di artista. Un aspetto centrale del libro è la difficoltà di realizzare il tipo di opere che le interessano. Non sono quadri o sculture da esporre in una galleria, sono realizzate su una spiaggia, o sono durational performance: materialmente difficili da realizzare, richiedono molto tempo, non sono remunerative. Se dipingesse ad acquerello sarebbe diverso, invece usa la terra, il paesaggio e il suo corpo, come l’artista cubana Ana Mendieta. Nell ha dovuto lavorare molto per diventare un’artista apprezzata, una famiglia e il lavoro domestico interferirebbero con la sua pratica. Per questo preferisce avere relazioni passeggere senza essere moglie e madre.
Nell’antichità le donne che vivevano nei boschi e preparavano pozioni curative erano guardate con sospetto, non tanto perché potevano essere streghe, ma perché erano sole, vivevano fuori della società, avevano strumenti propri di sussistenza, usavano la natura e curavano le persone senza farsi pagare. Come scrivono Barbara Ehrenreich e Deirdre English in Witches, Midwives and Nurses: A History of Women Healers, il mondo della medicina maschile decise che, facendone delle streghe, avrebbe potuto estrometterle dalla pratica medica, istituzionalizzare la medicina attraverso le scuole – da cui le donne erano escluse – e renderla una professione remunerativa”.
Rathglas potrebbe essere un beghinaggio, le donne che ci vivono indossano perfino delle tuniche e, quando Nell accetta la commissione di Maman, diventa il centro su cui convergono non solo sospetti e diffidenza, ma anche desiderio e curiosità. In un gioco concentrico di scatole cinesi sempre più piccole, come i turisti sull’isola e noi con il romanzo, anche Nell entra nella comunità di recluse con circospezione e rispetto.
“In irlandese rath significa forte e glas verde, quindi può essere una fortezza, un castello, un luogo protetto. I libri sono creature wild, selvatiche. Pensavo di avere la storia sotto controllo – l’isola, il suono, Nell, Cleary – poi un giorno mentre stendevo il bucato in giardino, all’improvviso ho avuto la visione di un gruppo di donne in fila, immerse nel mare fino alle ginocchia, le braccia intrecciate mentre cantavano. Non so da dove mi sia arrivata quell’immagine. Chi sono?, mi sono chiesta. La prima reazione è stata di scoraggiamento: oh no, devo scrivere altri personaggi! Ho dovuto capire chi fossero, trovare la strada per arrivare a loro, perché erano andate sull’isola, come si sarebbero intersecate con Nell. Sono molto affascinata da chi non vuole vivere nel mondo e preferisce starne fuori. Le Iníon sono delle anacorete moderne, donne stanche di una società in cui vige il patriarcato, il sessismo, l’ineguaglianza nel lavoro, nei salari, nei compiti domestici. Chi non vorrebbe vivere con un gruppo di donne che la pensano allo stesso modo, su un’isola, rifiutando il capitalismo? Forse in futuro ci saranno più comunità come quella delle Iníon perché è sempre più difficile vivere in un mondo così ostile alle donne. Meglio andare a vivere in un organismo basato sulla sorellanza”.
A Rathglas si lavora molto ma non si crea arte. È una micro-società ma non è democratica. Maman, che ha lo stesso nome dei ragni giganti di Louise Bourgeois, diventa sempre più dispotica e crudele. La leadership femminile a un certo punto va in crisi.
“La madre di Louise Bourgeois era una tessitrice e i ragni Maman sono figure protettive, alcune sculture hanno anche una sacca con le uova. La Maman del romanzo ha lavorato molto per mantenere in piedi la comunità, è molto protettiva delle Iníon. Ma anche nello spazio più democratico – che sia un club del libro o una chat di Whatsapp – c’è sempre qualcuno che si erge a capo. Maman teme che l’esperienza delle Iníon venga dimenticata, vuole preservare l’importanza del loro lavoro agli occhi del mondo, così affida a Nell il compito di raccontare la loro storia in un libro. Mentre scrivevo non conoscevo tutta la portata del suo agire, ma poi riflettendoci ho capito che nel libro sono disseminati vari indizi. Maman considera le Iníon il suo progetto, la sua proprietà, e come succede spesso nella storia, dal fascismo a Donald Trump, anche lei è intossicata dal potere”.
Ci sono due personaggi maschili nel romanzo. Alla spiaggia di Bansha, dove lavora a un’installazione, Nell incontra Cleary: lui non sa che è una nuotatrice esperta e teme che stia per affogare, non si accorge dell’opera che sta realizzando nella sabbia. Nell è diffidente e curiosa nei confronti di quello sconosciuto alto e affascinante, segnato da una piccola cicatrice sotto l’occhio. Da quello scarto, dalla diversità, nascerà qualcosa. L’altro è Nick, l’attore americano che ha affittato un castello sull’isola, il primo uomo a entrare a Rathglas e a profanare il gineceo, nonostante incarni un sistema di valori inconciliabile con quello delle Iníon.
“È ironico che Maman sia così rigida e intransigente, ma poi apra subito la porta al primo uomo e al patriarcato quando bussano alla sua porta. Nick è l’opposto di Cleary, un isolano con un vissuto molto complesso, che non riesce a elaborare i suoi traumi, mentre l’americano è molto sicuro di sé. Probabilmente per Maman il documentario che l’attore vuole realizzare è un altro modo di preservare l’eredità delle Iníon”, osserva Gleeson.
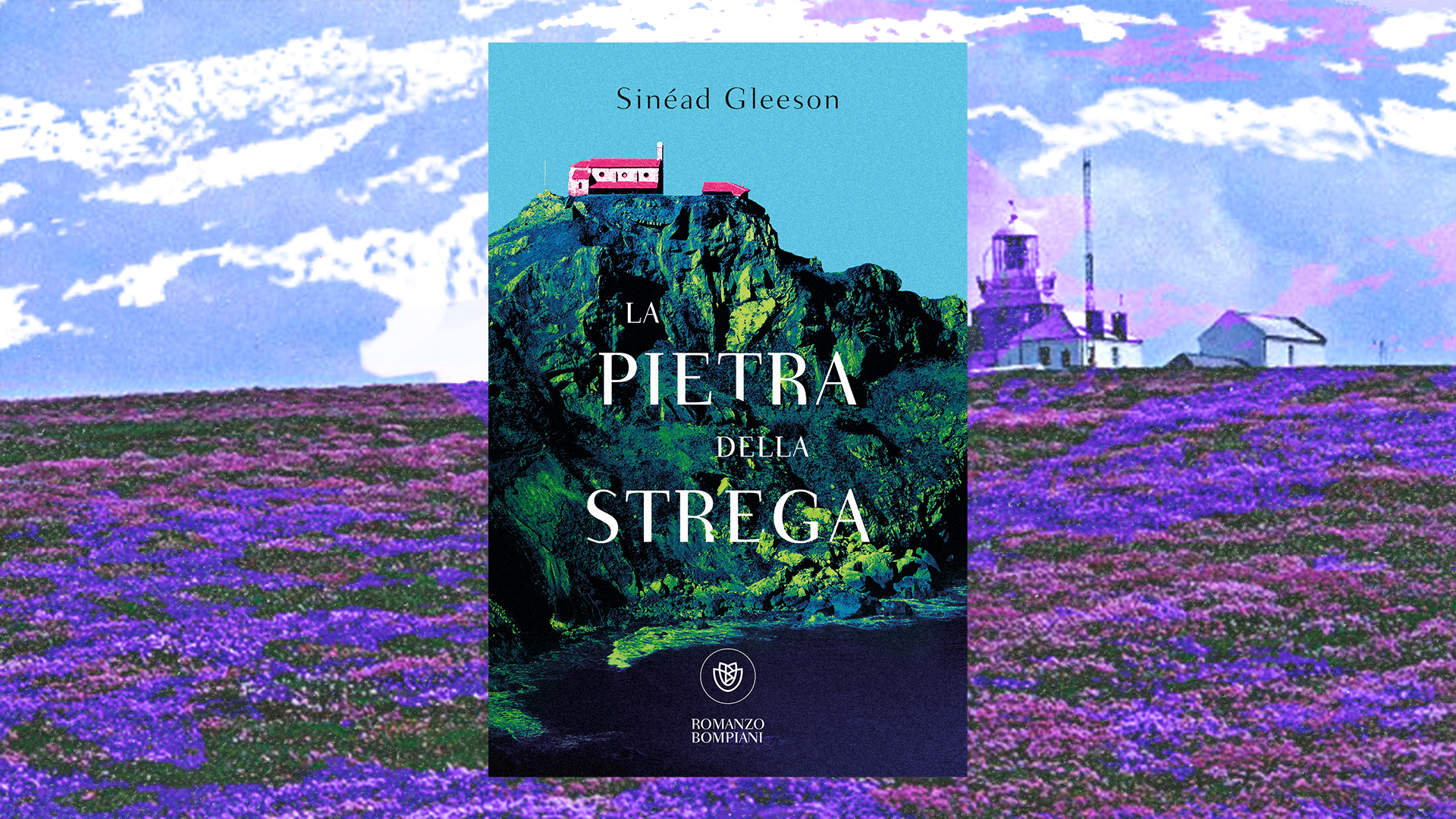
A un certo punto, durante la celebrazione di Samhain, la festa celtica che segna la fine della stagione del raccolto e l’inizio dell’inverno, la storia sembra precipitare nella tragedia con uno spaventoso supplizio medievale. Il mare che circonda l’isola è una presenza immanente, dispensatore di vita e di morte. Nell sfida le onde e le correnti nuotando in ogni angolo e insenatura, tra squali elefante, foche e meduse. A volte rischia di non tornare a riva. Il wild swimming, che abbiamo visto fare alle sorelle Garvey nella serie Bad Sisters, è una pratica diffusa in Irlanda. Nell’album You and i are earth, Anna B Savage dedica una canzone al Donegal e descrive una scena che sembra uscita dalle pagine di La pietra della strega:
The day I arrived
I dove into the sea
and pleaded “Donegal, please look after me”
I broke the surface, and the cold water shocked me
It brought me to, I said “I’ll look after you, too”.
Il giorno in cui sono arrivata
Mi sono tuffata in mare
E ho supplicato “Donegal, per favore prenditi cura di me”
Ho rotto la superficie e l’acqua gelida è stata uno shock
Mi ha fatto tornare in me e ho detto “Anch’io mi prenderò cura di te”.
“Sono consapevole del simbolismo del battesimo, ma fare il bagno nell’acqua gelida ti guarisce, ti purifica, ti distrae da tutto ciò che ti fa stare male. A Nell piace, la connette ancora di più all’isola e alla natura, ha realizzato un’opera con le maree, ne progetta una sottomarina con delle statue, vuole proiettare la sua silhouette sull’oceano usando la luce del faro. La presenza del mare nel romanzo è talmente forte che alcuni lettori mi hanno detto che alla fine del libro hanno dovuto togliersi il salmastro dalla pelle!”
Come la vita sull’isola, ruvida e spartana, anche la lingua del romanzo è essenziale, scarna ma efficace – “L’acqua color inchiostro si muove a pieghe”, “Il mattino esordisce arancio e azzurro”, “In un luogo remoto il desiderio è complicato” – e chiama il lettore a fare la sua parte: “Non penso mai a chi legge quando scrivo perché sarebbe paralizzante, ma il lettore ha un ruolo enorme nel libro. Molti sono convinti che si tratti di un’isola specifica, oppure estrapolano delle conclusioni sui personaggi di cui io sono all’oscuro. Alcuni artisti mi hanno addirittura detto di aver visto le opere che d’arte che ho inventato. Chi legge compie grandi atti di immaginazione. La lingua riflette il luogo, il fatto che Nell è un’artista, e lascia al lettore margine di azione, per questo ho deciso di correre qualche rischio”.
L’ultima artista citata nella nota sulle fonti di ispirazione è Sinéad O’Connor – “coraggiosa, unica e compianta” – ma sul finire della nostra conversazione Gleeson aggiunge un altro nome: “Una delle mie scrittrici preferite è Natalia Ginzburg: è raro che qualcuno riesca a scrivere così bene saggi e narrativa”.
Non sorprende, a pensarci: le sue piccole virtù sono anche quelle di Nell.






