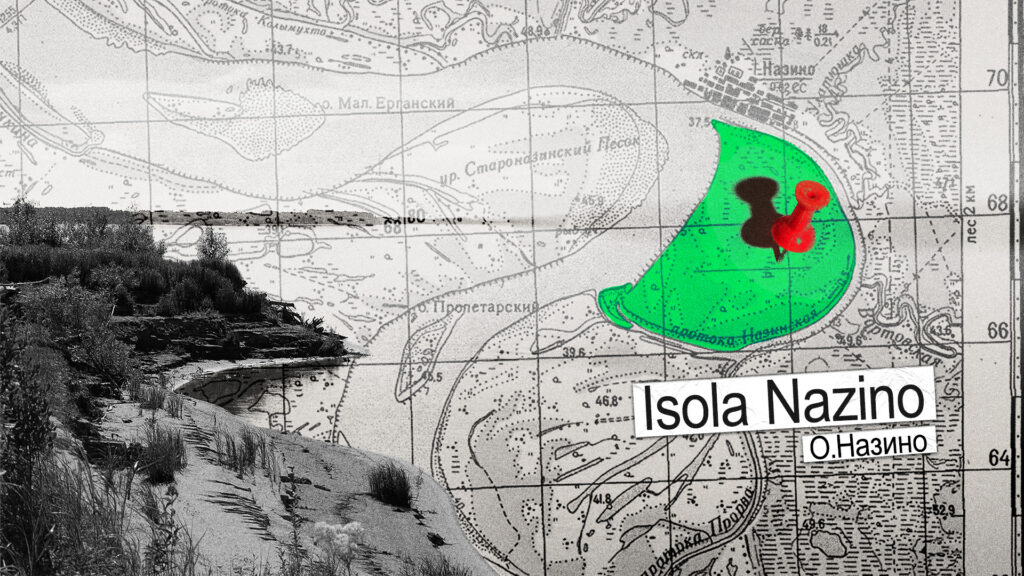Letizia Muratori
Lottare con tenerezza: l’autunno caldo a Torino nel racconto dei suoi artisti

24 Ottobre 2023
Cosa rimane dell’utopia degli anni Sessanta? Le foto e i racconti degli artisti che hanno vissuto quel periodo movimentato a Torino raccontano la classe operaia in gesti piccoli, quotidiani e lontani dalle solite narrazioni.
Letizia Muratori
Letizia Muratori è scrittrice e giornalista. Il suo ultimo libro è Una vita da donna (La Nave di Teseo, 2022).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati