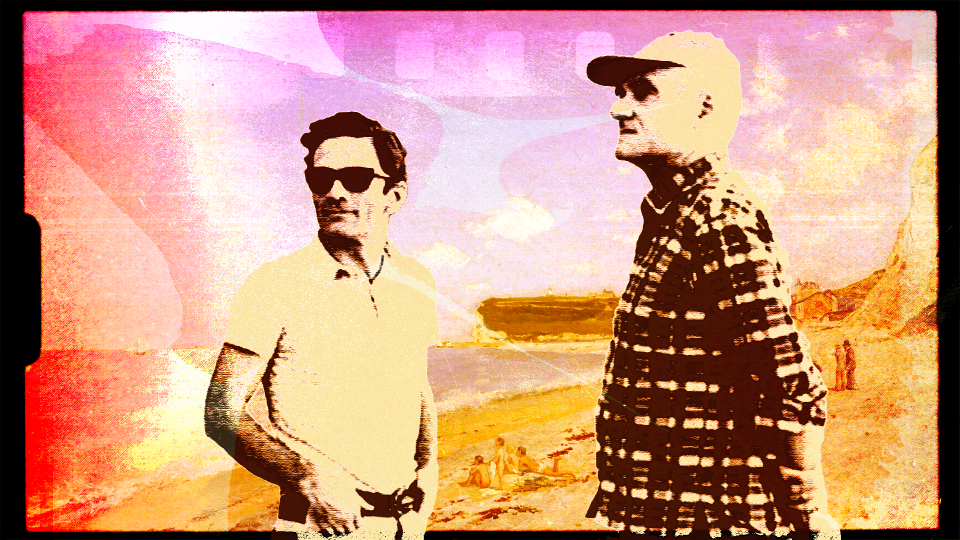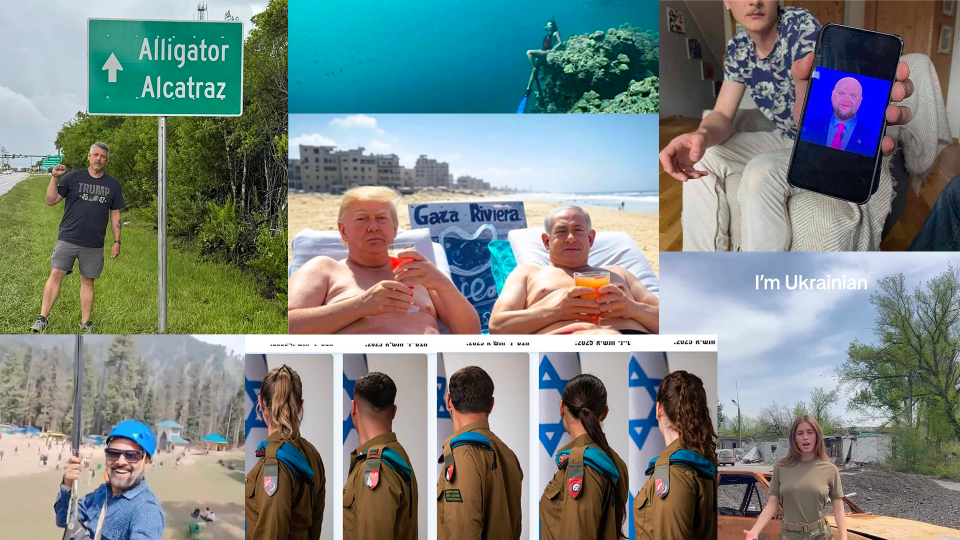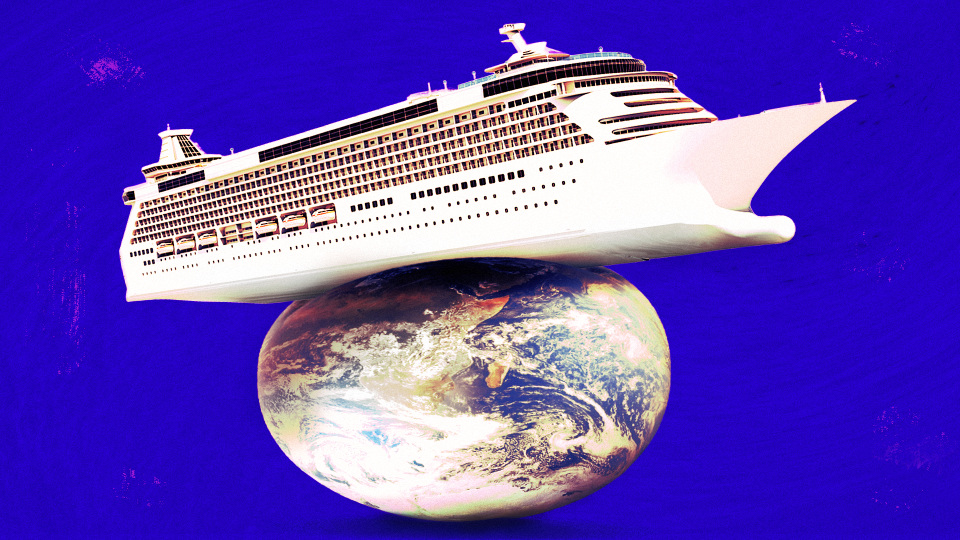Con il nuovo mese inauguriamo anche un nuovo tema: ve lo presentiamo qui.
Il numero di Lucy d’agosto ha per titolo una tema che allude a un altrove: Mari, monti e altri luoghi. Abbiamo scelto la congiunzione “e” perché non vogliamo costringervi al trito bivio tra mare o montagna, città o campagna. In questo agosto di Lucy c’è spazio per tutti: per chi parte, per chi resta – e pure per chi trova una terza via.
Nel suo Mes apprentissages, Georges Simenon racconta un viaggio in barca tra la Provenza e la Tunisia, compiuto a inizio Novecento, nel tentativo inizialmente vano di cogliere l’identità l’inafferrabile del mar Mediterraneo. E però a fine libro lo scrittore dichiara la resa lasciando la definizione a una reticenza: “Il Mediterraneo è…”: una sospensione che dice molto più di qualsiasi aggettivo speso sul Mare nostrum.
Allo stesso modo, il Palomar di Calvino, camminando in solitaria sulla spiaggia, fissa un’onda, la scruta, la scompone fotogramma per fotogramma: più la osserva, però, e più questa gli sfugge nel suo eterno rompersi, poi montare, e infine ricrearsi – la speranza di afferrarne il senso si infrange come schiuma sulla battigia.
Ma al di là una reale conoscenza della natura che è forse sempre destinata allo scacco, giù al mare o magari su per i monti l’umanità ha sempre cercato un sentiero per allontanarsi dal brusio e dai pettegolezzi. Franco Battiato ha reso immortale quel senso di torpore primordiale che ci raggiunge in una spiaggia solitaria dove sola arriva l’eco di un cinema all’aperto. Il tipo di estate che non spiacerebbe a Richard Powell: “Le vacanze, per la maggior parte dei miei amici di New York, devono essere dinamiche. Se ne vanno al largo con delle barche prese a nolo, muniti di lenze robustissime, e si attaccano a grossi pesci rabbiosi […] A me personalmente, piace bighellonare per le spiagge ed arricchire la mia collezione di conchiglie”.
Laddove Nietzsche, in uno dei suoi aforismi, asseriva che “chi è salito sui più alti monti, ride di tutte le tragedie del teatro e della vita”. Una distanza bramata anche da Heinrich Heine che l’ha cantata in versi carichi di desiderio d’evasione almeno quanto di stanchezza per i lussi borghesi:
“Addio, saloni lucidi,
lucidi gentiluomini, signore levigate,
voglio andarmene sui monti
e da lassù ridere di voi”.
Per alcuni, andare in montagna può significare invece lasciare la città per tornare a casa. È l’inizio de La luna e i falò, il libro in cui Pavese si interroga su cosa di sé è rimasto sulle colline piemontesi mentre era altrove. Paesi che d’estate si popolano di sagre mentre le città finalmente si svuotano, e svuotandosi diventano luoghi in cui ripararsi dalle insidie della mondanità o del turismo.
Manganelli, in un corsivo dei tanti suoi dedicati alle metropoli estive, raccontava con misantropica sollevazione l’aria che in città muta nei mesi più caldi: “Comincia ai primi di agosto la grande disintossicazione delle città. Questi conglomerati iracondi, congestionati, superalimentati di scorie – il normale nutrimento casalingo – fluttuanti tra infarto, suicidio, omicidio plurimo, collasso, paralisi, paresi, distrofia, questi subnormali maggiorati, ormai allo stadio terremotante del delirium tremens, si svuotano, si purificano: propriamente parlando, defecano i loro batteri cittadini, li essudano; si ammantano di un sole ferragostano fervido di candeggiante, il loro alito fetido si raffresca di dentifrici al fluoro e alla menta”
E non per caso Irene Brin durante l’estate suggeriva la pigrizia: “Siatelo isolandovi, dormendo, tacendo. E mettetevi a letto come se vi chiudeste in una cittadella guerresca, difendendovi da ogni assedio.
Quel genere di isolamento, purezza e distensione che Emily Dickinson aveva fermato in uno dei suoi versi più belli: “Come si chiude dolcemente l’estate, senza il cigolare di una porta, fuori per sempre”.
E certo lo spostarci tra mari e monti inevitabilmente ci porta a interrogarci sulla nostra presenza, sulla nostra ricerca di solitudine, e magari a metterci in prospettiva al cospetto della natura da cui invece di solito fuggiamo in inverno. Basti pensare, anche al sicuro di un museo, a come ci sentiamo inermi di fronte alle tempeste marine dipinte da Turner, a come siamo minuti rispetto alle cattedrali arborescenti di Rousseau “Il doganiere”, o a come ci sentiamo schiacciati dai ghiacciai immortalati da Salgado.
In questo numero di Lucy racconteremo allora il mare, i monti e il modo in cui ci relazioniamo a essi, ma provando a evitare gli astrattismi tipici di una conoscenza affrettata. Tenteremo di fare nostra la lezione che Cognetti fa impartire al suo Bruno ne Le otto montagne: “Siete voi di città che la chiamate natura. È così astratta nella vostra testa che è astratto pure il nome. Noi qui diciamo bosco, pascolo, torrente, roccia, cose che uno può indicare con il dito”.
In questo numero monografico Lucy cercheremo cioè di andare oltre la superficie dell’acqua, di non rimanere ai piedi della cima, di non arrestarci al primo confine o sentiero interrotto. Autori e autrici ci parleranno di vette e spiagge, di isole remote o catene montuose impervie – oppure di paesi e città per guardarli, però, da una prospettiva nuova.