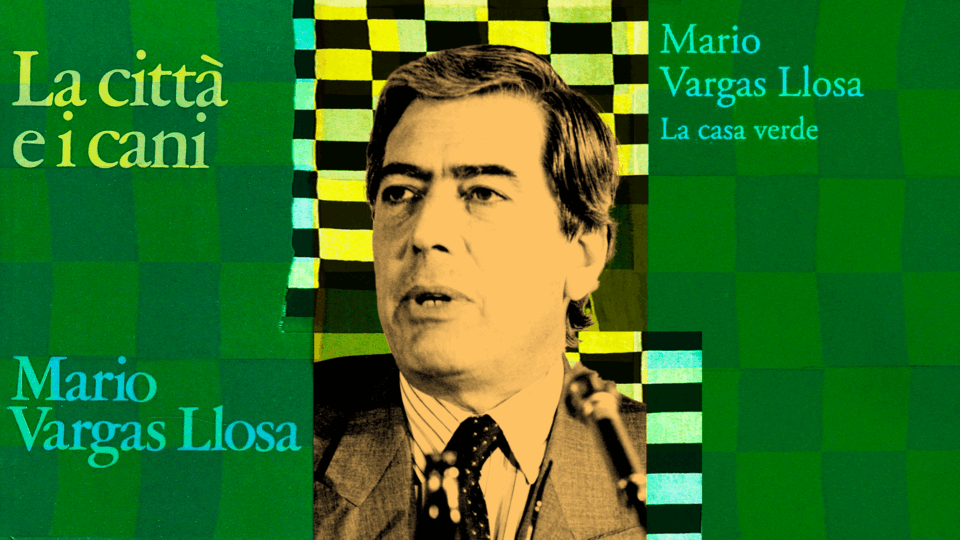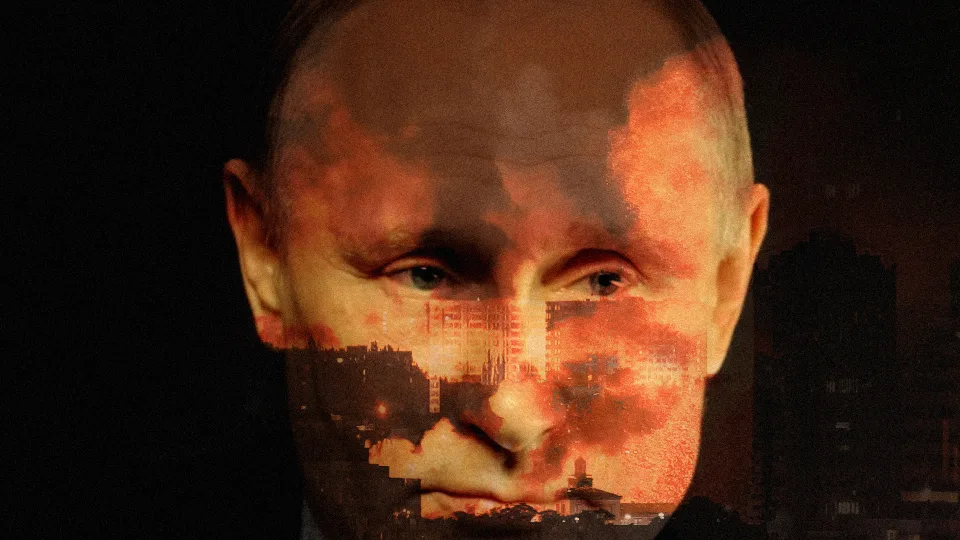Un ricordo dello scrittore peruviano, Nobel nel 2010, che ha dedicato la vita a decifrare e difendere il proprio Paese. Non soltanto con la scrittura.
Quando qualche professore d’apocalisse (in Italia se ne trovano tra analfabeti e accademici) lamentava fino a poco tempo fa la mancanza di grandi scrittori, offrendo un pasto quotidiano al proprio risentimento, rispondevo con feroce soddisfazione: “scusa, hai presente Mario Vargas Llosa? L’hai mai letto?” Soddisfazione, mentre la prefica di turno farfugliava dei sì che erano no, di sapere che da qualche parte nel mondo, in quel preciso istante, mentre io perdevo tempo con un imbecille, si aggirava per strada o mangiava o dormiva o chiacchierava amabilmente o fronteggiava un’intervista o lottava con una frase particolarmente ardua o immaginava un nuovo libro l’uomo che aveva scritto La città e i cani, La zia Julia e lo scribacchino, La casa verde, La guerra alla fine del mondo, La festa del caprone e molte altre opere di rara forza e bellezza e solidità e audacia compositiva, ma soprattutto Conversazione nella Cattedrale.
Dalla porta de «La Crónica» Santiago guarda l’avenida Tacna, senza amore: automobili, edifici disuguali e scoloriti, scheletri di pubblicità luminosa che ondeggiano nella nebbiolina, il mezzogiorno grigio. In che momento si era fottuto il Perù? Gli strilloni, infilandosi tra i veicoli fermi al semaforo della calle Wilson, gridano i titoli dei giornali del pomeriggio, e lui comincia a camminare, piano, verso la Colmena.
Ogni volta che rileggo questo incipit, immagino cosa accadrebbe sostituendo a “Perù” il nome di un altro Paese. In che momento si era fottuta l’Italia? E gli Stati Uniti? E la Francia, la Germania, la Grecia, la Gran Bretagna… Intravedo allora il libro – nella letteratura degli ultimi trent’anni – che manca non solo al nostro Paese (una genealogia delle speranze tradite e dunque un riscatto) e che Vargas Llosa riuscì a comporre per il proprio.
Scritto nella seconda metà degli anni Sessanta tra Lima, Parigi, Londra, Washington e Porto Rico, Conversazione nella Cattedrale prende le mosse da una giornata particolare di Santiago Zavala, detto Zavalita, un giovane giornalista piuttosto disilluso che lavora in un giornale di Lima, «La Crónica» (quotidiano per il quale Vargas Llosa cominciò effettivamente a collaborare nel 1952). Un fatto in apparenza insignificante, la fuga di un cagnolino, porta Santiago a spingersi ai margini della città. “Si sono portati via il suo cane?”, dice il farmacista, “il canile si trova dalle parti del Puente del Ejército. Vada subito, a mio cognato hanno ammazzato un chihuahua, una bestiola carissima”.
Zavalita sale su un taxi collettivo, si dirige verso plaza Dos de Mayo, “una grande spianata con attorno un muro malconcio di mattoni crudi color cacca, il colore di Lima, pensa, il colore del Perù”. Siamo all’indomani del crollo del regime di Odría, in un paese che prova a tirarsi fuori dalla catastrofe, ma sembra più che altro agitarsi tra le sabbie mobili. Nel canile i cani adesso vengono uccisi a randellate (“prima li ammazzavano come Dio comanda, adesso i soldi non bastano. Ci scriva un articoletto, signor giornalista”) ma Zavalita ritrova il proprio. Mentre si imbatte in un altro addetto del canile – un nero di umili origini, probabilmente afro-peruviano – a Santiago Zavala viene un colpo, riconosce l’uomo e pensa: “no, Zavalita, lui non ti riconosce. Il suo sguardo è torbido distante e rispettoso. Oltre a invecchiare è anche abbruttito. Pensa: fottuto anche lui”.
Invece l’uomo si ricorda. Si chiama Ambrosio, è stato molti anni prima l’autista di suo padre. “Ambrosio? Non sei Ambrosio? Ti sei dimenticato di me? Sono Santiago, il figlio di don Fermìn”. E l’uomo: “Non sembra vero di vedermelo qui uomo fatto – lo palpa, lo guarda, gli sorride – La vedo e non ci credo, signorino, Certo che la riconosco, adesso sì. Somiglia al suo papà; e un po’ anche alla signorina Zolla”.
Cominciamo a capire un po’ di cose. Santiago proviene da una famiglia altolocata, ma ha rotto con quel mondo: ha rinnegato suo padre, ha interrotto gli studi di legge, ha rinunciato al benessere e vive in ambienti bohémien (tra i suoi colleghi diversi giornalisti alcolizzati, ridotti a vedere “i diavoli blu”), ha militato in ambienti di sinistra, ha sposato una proletaria, Ana, la proprietaria del cagnolino che è fuggito. Santiago ultimamente si sente tuttavia disilluso anche nei confronti del suo mondo d’adozione, è in un momento di smarrimento, cerca di risalire a ritroso il percorso che lo ha portato in un naufragio esistenziale.
Per festeggiare il caso che li ha riuniti dopo tutto quel tempo, Zavalita e Ambrosio decidono di andarsene a mangiare qualcosa.
“Conosco un posto dove vado a mangiare – dice Ambrosio – La Catedral, è un posto da poveri, non so se le piacerà”.
“Se hanno birra gelata mi piacerà”, dice Santiago.
Le successive settecento pagine sono il resoconto della conversazione tra i due. Già dalle prime battute, il lettore inizia a precipitare in un gorgo, un viaggio nel tempo (e nelle vite dei protagonisti, nella vita del Perù sotto la dittatura) che si trasforma presto nella seduta di psicanalisi (ma anche una seduta spiritica, una messa funebre, un esorcismo) di un intero Paese. Santiago, nel corso della conversazione con Ambrosio, scopre lentamente, o forse dovremmo dire ricorda, che suo padre, imprenditore in apparenza rispettabile, è stato molto vicino al regime, c’è stato uno scambio continuo di favori, un tentativo di manipolare i destini politici del paese, ma è successo ben di peggio, ci sono stati delitti, tradimenti, episodi irriferibili… Quanto il buon Ambrosio, servitore fedele e in apparenza amabile, ne è stato complice? E quanto lo strappo di Zavalita è stato sufficiente a salvarlo? Si può fuggire dal proprio passato senza averci fatto i conti fino in fondo?
Quando Vargas Llosa pubblica Conversazione nella Cattedrale (1969, due anni dopo Cent’anni di solitudine) ha trentatré anni. È nato ad Arequipa, in Perù. È figlio unico. I suoi genitori si separano poco prima della sua nascita. Cresce credendo che il padre sia morto, o almeno così gli dicono. Vive con la madre e con i nonni materni, in una famiglia affettuosa e colta, tra Cochabamba (Bolivia) e Piura, nel nord del Perù. È un’infanzia libera, piena di romanzi d’avventura e sogni da scrittore. Ma quando Mario ha dieci anni, quel mondo crolla. Suo padre, Ernesto Vargas Maldonado, riappare. È vivo. E molto diverso da come lo immaginava: autoritario, gelido, violento. Mario è costretto a tornare a Lima, e a vivere con lui, a dimenticare la leggerezza dell’infanzia, impara il silenzio e l’umiliazione. Il padre disprezza la letteratura, teme che il figlio diventi effeminato, lo iscrive al Collegio Militare Leoncio Prado. Sono anni molto duri, ma è lì che Vargas Llosa inizia davvero a scrivere, con la furia e il talento del sopravvissuto.
Nel 1955, a 19 anni, Mario compie un gesto scandaloso: sposa Julia Urquidi, la sua zia acquisita, più grande di lui di dieci anni. È un amore controverso, turbolento, capace di rompere tutte le convenzioni, e dunque è una relazione anche molto contrastata. Julia diventerà anni dopo la protagonista del romanzo La zia Julia e lo scribacchino. La scrittura, nel frattempo, è il maggior impegno di Mario. Il giovane studia Lettere e Giurisprudenza all’Università di San Marcos a Lima, nel 1958 vince una borsa di studio per Madrid. Parte per il suo primo esilio volontario. Dopo la Spagna, si stabilisce a Parigi. È povero, vive traducendo, corregge bozze, si arrabatta tra mille lavori, ma è felice: la libertà e la letteratura valgono ogni sacrificio. Legge Sartre, Camus, Flaubert, Faulkner. Scrive con furore.
Nel 1963 il suo esordio. Pubblica La città e i cani, un romanzo che denuncia la brutalità del collegio militare. Il libro suscita polemiche in Perù, ma vince premi internazionali. Poi arriva La casa verde (1966), ancora più ambizioso, un affresco del Perù profondo. La critica inizia a parlare di lui come uno dei protagonisti del “boom” latinoamericano, accanto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes. Ma il padre di tutti loro, non lo dimenticherei, è il Juan Rulfo di Pedro Paramo.
Bevute fraterne e scazzottate a parte, Mario Vargas Llosa è stato davvero lo speculare di Gabriel García Márquez. Quest’ultimo costruisce un mondo pieno di meraviglia e di magia, dove il reale e l’incredibile convivono, le atmosfere sono calde, sensuali, piene di spiriti, sogni, profezie, anche nel dolore dimora uno splendore leggendario. Vargas Llosa (anche quando parte per l’Amazzonia alla ricerca del Perù arcaico dei nativi, e lo racconta) è lontano da ogni esotismo, costruisce mondi metropolitani, spesso claustrofobici, dove la lotta tra potere e individuo è impari e spietata (per “la propria cartografia delle strutture del potere e per la sua immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell’individuo” recita la motivazione del Nobel per la Letteratura, conferitogli nel 2010), l’indagine prevale sull’incantamento. Entrambi danno nuovo respiro alla forma romanzo. Ma a un certo punto sono divisi anche dalla politica.
García Márquez diventa un’icona della sinistra, a volte in modo anche stucchevole. Vargas Llosa cambia idea. Negli anni ’50 si dichiara socialista. Da studente partecipa alla politica universitaria attraverso Cahuide, nome sotto il quale si nasconde il Partito Comunista Peruviano, perseguitato dal regime di Odría. Nel 1962 visita Cuba come corrispondente durante la crisi missilistica, e in quel contesto esprime simpatia per la rivoluzione. Due anni dopo, però, arriva la rottura. Nel 1967, dopo l’imprigionamento del poeta Heberto Padilla, Vargas Llosa rompe pubblicamente con il regime di Fidel Castro.
A differenza di molti intellettuali latinoamericani, non cercherà mai un compromesso: Vargas Llosa si sposta con decisione verso posizioni liberali. Difende la libertà di espressione, il pluralismo, l’economia di mercato. Scrive articoli infuocati contro ogni forma di totalitarismo, di sinistra e di destra. Nell’America Latina delle dittature e dei populismi sfrenati, del messianesimo d’accatto e del misticismo da strapazzo, sostiene, l’unica rivoluzione possibile è quella liberale. Con queste premesse, si candida nel 1990 alle presidenziali del Perù. Viene sconfitto al secondo turno da Alberto Fujimori, sostenuto da molte forze della sinistra. Nel 1992, con un colpo di stato, Fujimori abolisce il parlamento e la democrazia, inaugurando l’ennesimo regime dittatoriale.
La posizione politica di Vargas Llosa è stata (è la disgrazia di molti grandi scrittori) un altro catalizzatore di smaniosi – non so se solo in Italia, porto l’esperienza del mio paese. Negli ultimi anni, quando ho elogiato senza riserve l’arte di questo scrittore, sono stato puntualmente raggiunto da messaggi di felicitazione e biasimo, entrambi insopportabili. Felicitazione da giornalisti e intellettuali sedicenti liberali i quali si dicevano sorpresi che uno scrittore come me (oggi basta essere gobettiani e azionisti per diventare massimalisti nel gioco dell’idiozia polarizzata) portasse acqua (come ne avesse bisogno…) al mulino di Vargas Llosa (il quale, da vero liberale, considerava Silvio Berlusconi un personaggio “caricaturale” e si era schierato con Carola Rackete contro Matteo Salvini nel 2019, proponendo che le fosse addirittura dato il Nobel per la pace); e biasimo da amici e amiche post marxisti che proprio non riuscivano (esattamente come i falsi liberali di sopra; in quest’ultimo caso la tentazione ulteriore era trascinare Vargas Llosa verso il rogo in cui si è cercato di scaraventare Harold Bloom) a leggere senza pregiudizi almeno uno dei romanzi che hanno fatto di Mario Vargas Llosa uno scrittore destinato a sopravvivere agli equivoci in cui inciampano a volte anche i suoi estimatori.
“‘Continuerai a fare la vita di sempre?’, chiese il Giaguaro”.