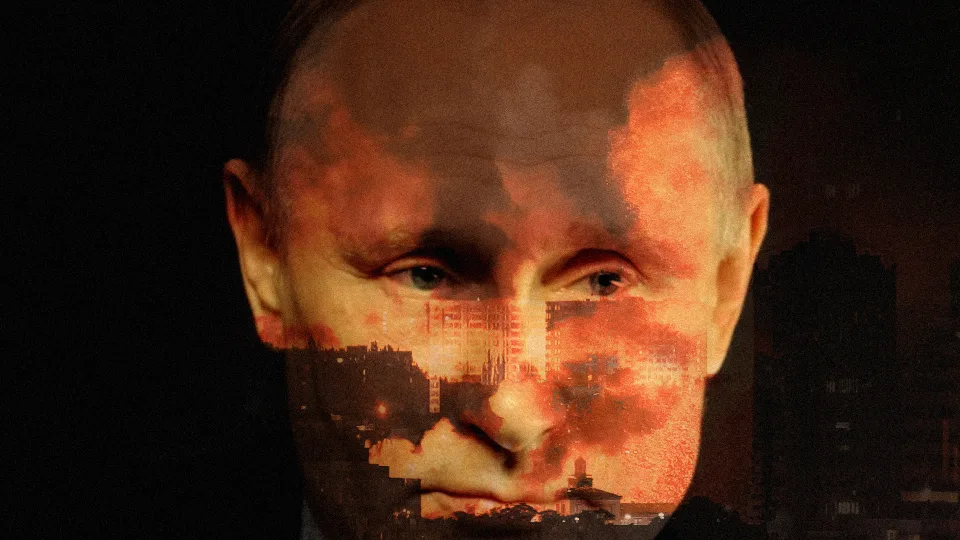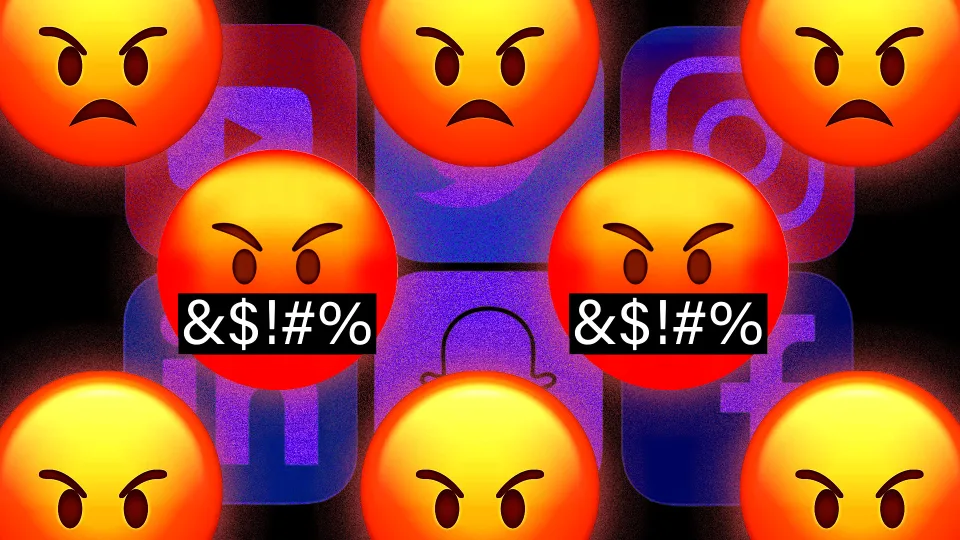L’ultimo documentario di Alex Ross Perry, "Videoheaven", racconta la storia del videonoleggio e la sua fine: da luogo alternativo, di aggregazione e scoperta, a squallido teatro di incontri indesiderati. Oggi che mancano i luoghi fisici per condividere la propria passione per il cinema e scoprire cose nuove, dei videonoleggio si sente la mancanza.
Un uomo entra in un videonoleggio e puf!, sparisce. Tra i luoghi che abbiamo smesso di frequentare, come le edicole o i negozi di dischi, non è forse quello che ha fatto la fine più mesta e definitiva? “I videonoleggio sono diventati insoliti e obsoleti come (…) il trillo di un modem che si connette online”, esordisce il documentario Videoheaven, diretto dal regista statunitense Alex Ross Perry e narrato dall’attrice Maya Hawke. “Ma a differenza del segnale di trasmissione di internet”, continua caustica la voce in off, “la breve esistenza del videonoleggio come spazio fisico si è evoluta in un nulla di fatto. Qualsiasi immagine di quei luoghi proviene dal passato, o lo riguarda. Sono spazi estinti, le cui rappresentazioni attuali o future saranno per sempre ambientate in un tempo che fu. Sebbene esista ancora un numero esiguo di negozi dove si possono noleggiare film [biblioteche escluse, n.d.r.!], per molti di noi l’unica possibilità di visitare uno di questi luoghi significa vederlo sullo schermo”.
Manco a farlo apposta, la biografia del videonoleggio segue il classico arco narrativo di ascesa promettente e declino rovinoso. Per raccontarla, Perry si è affidato non a un formato franchise o a una serie tv nata corta, ma a decine di spezzoni dove questo luogo esotico fa la sua comparsa. Non importa se è protagonista, o semplice sfondo, la missione è catalogarlo con la devozione minuziosa di chi si imbarca nell’impresa per amore (e non per soldi: presentato a Rotterdam, sta viaggiando nei circuiti festivalieri – in Italia il 26-28 settembre, da Archivio Aperto a Bologna e poi a Fondazione Prada a Milano). Il risultato è un documentario composto esclusivamente da materiale non originale: eccoci a Videoheaven, il paradiso del videonolo. E stiamoci più a lungo possibile, che l’inferno è quaggiù, dove Netflix è una tech company, MUBI conta nel suo CDA finanziatori del genocidio palestinese e pure Franco Maresco fatica a girare “un film fatto per bene”.
Da parte sua, Perry è uno che della retromania ha fatto un mestiere: gira quasi solo in pellicola, il suo ultimo film narrativo, Her Smell, è una specie di epica in costume su una musicista grunge, e la sua penultima fatica documenta il comeback dei Pavement. Per realizzare il Videoheaven, Perry ha impiegato quasi dieci anni, a partire dalla lettura di un libro di Daniel Herbert che cronicizzava l’esistenza del videonoleggio. In Videoland: Movie Culture at the American Video Store, Herbert offriva un’analisi appassionata dei videonoleggio come fenomeno sociologico. Il documentario di tre ore di Perry è del saggio accademico la versione cinematografica espansa, realizzata con l’aiuto del fondatore della mitica rivista «Reverse Shot», Michael Koresky e di Clyde Folley, il montatore di Criterion, uno dei maggiori distributori di film del Paese.
Come spesso gli encomi postumi, tende a essere più magnanimo del dovuto. Se lo chiedete a me, il videonoleggio ha avuto un’esistenza piuttosto confortevole, ma lo dico con la stessa invidia con cui, da millennial, guardo ai Gen X, decisamente più fortunati di noi, essendo cresciuti in un mondo più semplice. Già a inizio anni Settanta alcuni artisti delle avanguardie (come, ad esempio, Alberto Grifi) avevano cominciato a sperimentare col nastro magnetico anziché usare la pellicola, ma è verso la fine del decennio che Hollywood offre il VHS come alternativa. Contemporaneamente cominciano a comparire negozi in cui noleggiare le cassette, anche se all’inizio i videoregistratori hanno prezzi proibitivi. Ma in pochi anni già il 70% della popolazione possiede uno di questi dispositivi, facendo sì che nel 1989 il mercato dell’home video sorpassi quello dei cinema.
Ma ai suoi albori, il videonoleggio non era espressione di comfort casalingo. Già in Videodrome di Cronenberg, nel 1983, la videocassetta è oggetto misterioso e ambiguo che si insinua nella sfera domestica, rivelando minacce esterne o disturbi interiori. Al cinema, il videostore debutta l’anno dopo, in Body Double di Brian de Palma, comparendo nelle vesti del Tower Records di Sunset Boulevard. Il film – che (ri)lanciò Melanie Griffith ed è uno dei capolavori della decade – floppò in concorrenza con Terminator e venne generalmente considerato niente di più che un plagio hitchcockiano.
Oltre a offrire testimonianza di uno dei primi luoghi del genere (quando erano ancora un’invenzione underground), il film fornisce anche il collegamento che traghetta il videonoleggio fuori dall’infanzia e dritto nell’adolescenza: la sezione di film per adulti. Meno conosciuto ma dello stesso periodo è un film antologico (altro formato defunto) intitolato Amazon Women on the Moon, dove John Landis, nel suo episodio, si immagina un negozio che noleggia cassette porno su misura, cioè che interagiscono magicamente col cliente, trasportandolo al centro dell’azione sullo schermo. Per chi l’avesse visto, è impossibile non pensare a quell’episodio recente di Black Mirror in cui la vita di un’abbonata viene adattata in diretta in una serie televisiva. Genere Netflix Plays Itself, insomma, che comunque mi impressiona poco, perché l’autoparodia non è l’invenzione ironica di qualche showrunner col cervello lavato dai meme ma una pratica artistica in cui il cinema eccelle da sempre. Nel suo formato citazionistico e meta-testuale, infatti, Videoheaven è anche un omaggio al grandioso Los Angeles Plays Itself (Thom Andersen, 2003), in cui la storia della città è raccontata con i filmati che ne hanno fondato il mito.
Quanto al periodo d’oro del videonoleggio, questo avviene negli anni Novanta. L’ubiquità del luogo (più della metà degli esercenti afferma di avere un negozio concorrente a meno di 1km di distanza) si traduce in un’esperienza specifica e quotidiana come il consumo di un marchio registrato. Così Blockbuster – che Netflix proverà ad acquisire e dopo satireggerà con ben due produzioni – comincia a diventare sinonimo di mercificazione dello sguardo, tra moltiplicazione della scelta e appiattimento dell’offerta. Un’altra catena vanta 32 categorie da esplorare mentre Walmart incorpora il business model offrendo oltre 3.000 titoli. Una miseria, al confronto con oggi (36 mila sottocategorie su Netflix, 13.000 titoli in media in un paese europeo su Amazon). Si sente che la fine è vicina, eppure prima bisogna toccare il fondo.
Come sono i tonfi hollywoodiani? Eccessivi e viziati alla base: “Da oscuro e alternativo, il videostore diventò un posto banale, profano, e successivamente un luogo di incontri indesiderati e di corteggiamenti bizzarri ”identifica acutamente Videoheaven, vedendo nel videonoleggio uno degli ultimi luoghi fisici dove era “normale” parlare delle propri preferenze in pubblico, col rischio di diventare autocelebrazione. L’audacia del mainstream che se la canta e se la suona da solo, si ritrova in una sequenza tratta da The Last Action Hero (1993), dove il protagonista è un fan sfegatato di film d’azione, e non può credere ai suoi occhi quando, accompagnato da Arnold Schwarzenegger in un videonoleggio simile a un Blockbuster, si imbatte in un cartonato di Terminator 2 col faccione del rivale, l’altro eroe muscoloso, Sylvester Stallone. Altre locandine, Bram Stoker’s Dracula e The Sandlot (in italiano Ragazzi vincenti), appaiono nella sequenza per “gentile concessione” della Columbia Pictures, produttori del film. Così, “tv e cinema mostrano il videonoleggio per parlare di sé stessi”: non solo implicando che lo spettatore conosca e ami altri film, ma anche, semplicemente, per farsi pubblicità. Un’usanza che, se negli anni Novanta è tecnica di posizionamento sul mercato, già nei Duemila diventa ricatto nostalgico, come ricorderà chi ha versato una o più lacrime guardando i remake fai-da-te dei noleggiatori allo sbaraglio, Mos Def e Jack Black, in Be Kind Rewind (Michel Gondry, 2008).
Prima di proseguire in direzione dell’inarrestabile decadenza (l’analogico che viene rimpiazzato dal digitale e il noleggio che scompare in favore dell’acquisto – una tendenza invertita poi dalle piattaforme), è bene fare una tappa intermedia. Al picco della sua popolarità, il videonoleggio è frequentato da persone tra loro diversissime, che sono clienti ma anche spettatori. A rispondere alle loro esigenze, il commesso, o clerk, (solitamente maschio bianco etero, con la memorabile eccezione di Cheryl Dunye in The Watermelon Woman) che è un po’ tutti noi, un po’, per fortuna, no. A partire dal nostro Franco Maresco (che tra i suoi clienti poteva vantate un giovane Luca Guadagnino), passando per Tarantino e Alex Ross Perry (che lavorò nel leggendario Kim Video che, dopo la chiusura, fu trasferito a Salemi, in Sicilia, tramite Vittorio Sgarbi!), fino ai protagonisti della saga di Kevin Smith, Clerks, in molti svolgono l’assieme ambito e dileggiato lavoro di impiegato in quel luogo, perché ricopre un ruolo di mediazione tra arte e consumo, spettatore e cliente. Il clerk ha cioè il delicato compito di accompagnare (se non formare!) il gusto del cliente/spettatore e fargli rispettare le regole (pena sanzioni se non riavvolgi il nastro). In Italia questa creatura è più originale dell’archetipo e ha un nome e cognome: enrico ghezzi.
“Un uomo entra in un videonoleggio e puf!, sparisce. Tra i luoghi che abbiamo smesso di frequentare, come le edicole o i negozi di dischi, non è forse quello che ha fatto la fine più mesta e definitiva?”
Breve deviazione: nel nostro Paese la storia del videonoleggio non è neanche lontanamente paragonabile a quella raccontata da Videoheaven. Nel 1994 Blockbuster apre la sua prima filiale a Milano sud e si vocifera sia una joint-venture con la Standa, iniziata da Fininvest. La tessera costa 10.000 lire e la puoi fare solo se sei maggiorenne. (Per sempre sarò debitrice alla mia tata di allora, ventenne studente di Giurisprudenza, a cui commissionavo i VHS di Romeo + Juliet, Tutti pazzi per Mary, 10 cose che odio di te. L’esperienza che mi segnò, comunque, non furono queste visioni ma l’odore che lasciavano sulle dita certi popcorn al formaggio, veri responsabili della fragranza omologante del luogo).
Al di là del fatto che Blockbuster si diffonde poco e solo nei capoluoghi, nel nostro Paese altri esercenti del genere non passano comunque alla storia perché ci sono già due altri canali che dominano l’home video. Sono le cassette de «L’Unità» e il programma televisivo fuori orario. Soprattutto le prime, portandolo all’estremo, sono emblematiche di un altra tendenza pressoché defunta: quello della pedagogia culturale di orientamento politico.
Trent’anni fa il quotidiano fondato da Gramsci inventa i gadget culturali da allegare il fine settimana, come racconta tra gli altri un pezzo uscito per «Rivista Studio» lo scorso gennaio. L’ideatore è il direttore dell’epoca, Walter Veltroni, che spera di sconfiggere le televisioni dell’avversario a colpi di Truffaut, Bergman, ma anche Mars Attack!. Senza quei VHS che furono per breve tempo iconici come i dorsi degli Adelphi, non conserverei uno dei ricordi più cari della mia infanzia: mio padre che fa la pernacchia alla tivvù guardando il sorpasso di Sordi ne I vitelloni. Vista a posteriori, l’operazione è meno innocente della memoria infantile; resta il fatto che, se sei una bambina, non puoi stare sveglia fino a tardi e fare quello che fanno i grandi, e cioè sintonizzarti su fuori orario.
La trasmissione di Rai Tre è in palinsesto già dalla fine degli Ottanta – 2 novembre 1989 per la precisione, un angelo dell’internet ha archiviato e pubblicato ogni episodio dalla prima messa in onda – quando nasce perlopiù per la necessità di “smaltire un eccesso di diritti”, di titoli che ghezzi e soci (fondatori: Sergio Grmek Germani, Ciro Giorgini, Carmelo Marabello, Marco Melani, Roberto Turigliatto. Ne seguiranno altri che avevano acquisito per il programma precedente, La magnifica ossessione).
Nonostante l’abbia cercata, non ho trovato alcuna monografia accademica o divulgativa su fuori orario. Cose (mai) viste e mi sorprende molto perché, come suggerisce il titolo, per oltre un ventennio – prima cioè che internet rendesse tutto a portata di sguardo – è l’unico luogo dove lo spettatore italiano può guardare film – anzi, “visioni”, dato che il programma mostra anche spot speciali, videoarte, interventi sui generis – altrimenti inaccessibili. Rigorosamente a notte fonda, talvolta fino alle prime luci dell’alba, è possibile sbirciare un “piccolo misticismo quotidiano televisivo. (…) con l’accanimento di voler far essere cinema la tv e tv il cinema, ‘diretta’ un film di Vigo, Lang, Rossellini e ‘film’ una telecronaca, fuori orario insiste, proponendo ridisponendo indisponendo immagini mille volte (mai) viste e inediti assoluti”.
Sono capolavori nuovi visti ai festival (dai cui arrivano missive gracchianti dai primi cellulari), sono classici “da salvare”, sono intere filmografie o correnti o scuole, vere e proprie retrospettive – tutte visioni accompagnate dalle intro-fiume di enrico ghezzi, in primo piano e fuori sincrono, col canale audio completamente diverso da quello video. Questo sfasamento irriverente, davvero sovversivo negli anni d’oro del varietà Mediaset, amalgamano fuori orario nello spazio amorfo di cui anche blob fa parte, guadagnandosi un posto d’onore nel cuore di tutti i cinefili in divenire e perciò anche una parodia, memorabile quasi quanto la longevità e l’incisività del programma (che, lo ricordiamo, va in onda da 36 anni).
Col formato associativo e idiosincratico, le curatele di fuori orario sono meglio di qualsiasi suggerimento algoritmico ma lo preludono, e le presentazioni a mezzo busto di ghezzi, piene di personalità, anticipano, senza nobilitarli, interventi di youtuber o film influencer che oggi fanno la nuova critica cinematografica.
Non ne cito nessuno perché non ne conosco, ma mi racconto sia così perché nessuno spicca come particolarmente valido o innovativo; la sensazione è che la forma scritta registri ancora al meglio la vita tipicamente orale della passione cinefila. Per un analogo paradosso, anche se guardare film è un’attività immateriale e benché sia originariamente un fascio di luce, è un oggetto intrinsecamente fisico. Se non si tratta del luogo, allora della pellicola, se non è la pellicola allora è il disco digitale o la sequenza in codice racchiusa nel DCP o il segnale d’avvio di qualcuno che ha scelto di guardare, in quel momento, proprio quelle immagini – un segno che ci siano ancora le persone, sempre le persone. Guardiamo film per ritrovare noi stessi anche quando ci sono gli alieni o le foreste incantate o gli scenari post-apocalittici.
Ah, giusto. A proposito di quelli: l’ultimo Blockbuster chiude nel 2012, lo stesso anno in cui è ambientato Io sono leggenda, film del 2006 ispirato all’omonimo romanzo di fantascienza di Richard Matheson. Will Smith è l’unico superstite di un’epidemia che ha reso tutti quanti degli zombie fotofobici e perciò durante il giorno bighellona per una Manhattan deserta.
Tra le varie routine che mette in atto per ammazzare il tempo, visita regolarmente uno storico negozio di dvd e dischi del Greenwich Village. Tre mesi dopo le riprese, Tower Video chiuderà per sempre i battenti.
Nel mondo fittizio del film, invece – dove più tardi altri due personaggi introducono una scena in cui si vede Shrek in tivù, che il protagonista conosce a memoria – guardare dvd presi in prestito continua a essere una pratica verosimile. Nell’adattamento del 1971 dello stesso romanzo, The Omega Man, vediamo Charlton Heston inserire la pellicola nel proiettore di un ex-cinema diventato sua sala privata e guardare – solo in mezzo alle poltroncine vuote, bisbigliando le battute che sa a menadito – un documentario su Woodstock prodotto dagli stessi studios del film in cui sta recitando, la Warner Bros. “La prossima volta che adatteranno questa storia”, commenta Videoheaven, “non ci sarà modo di includere logicamente una versione di questa scena. In un mondo che ha abbandonato il film e lo spettatore analogico, ‘l’ultimo uomo sulla terra’ non potrà accedere allo streaming’”.
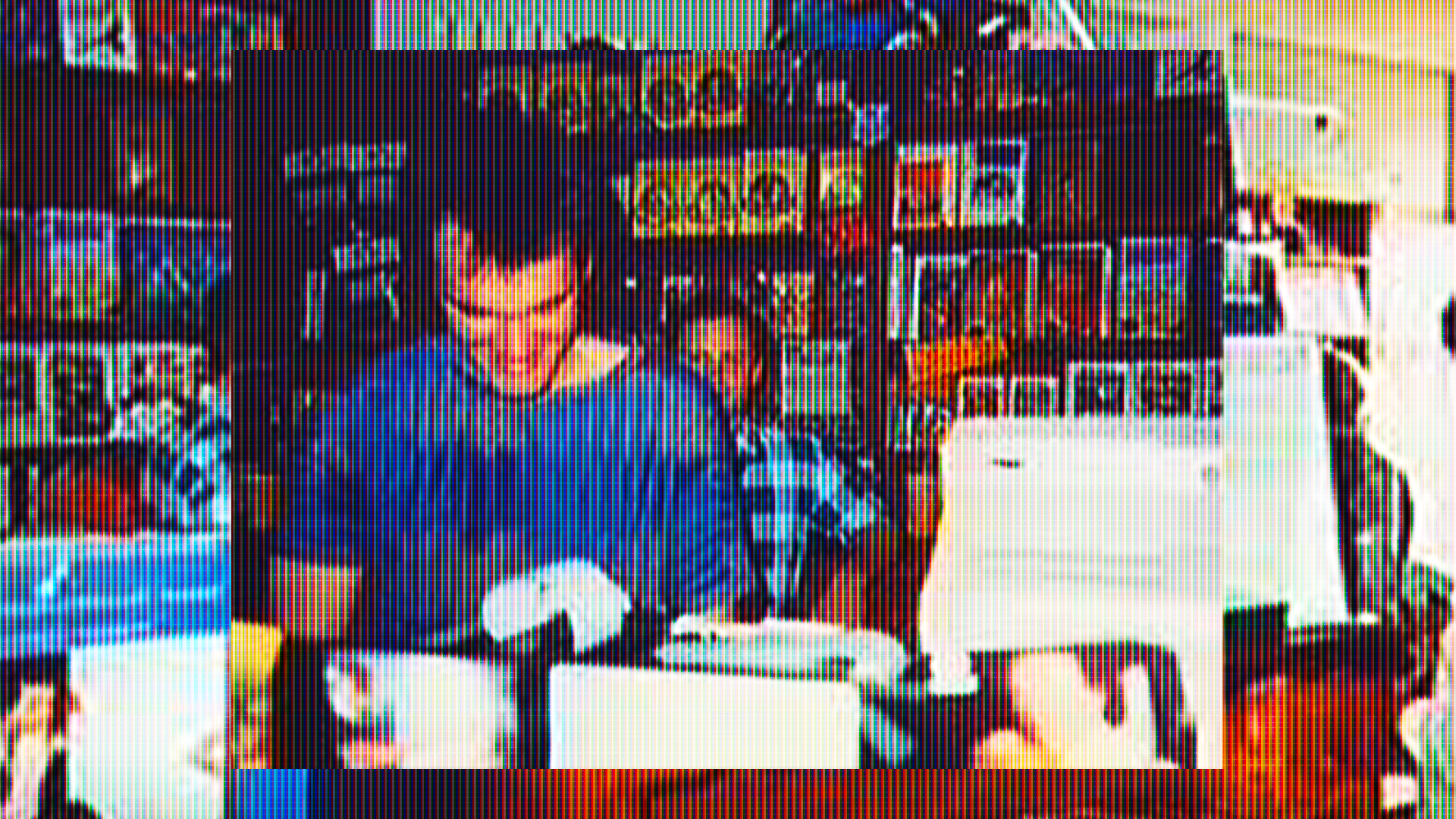
Anni Ottanta: un poco più che ventenne Quentin Tarantino al lavoro da Video Archives, videonoleggio a Manhattan Beach, California.
Vista dal traballante avamposto del presente, la fine che ci aspetta sembra meno eroica e sublime di quelle immaginate dalla fantascienza, ma altrettanto tragica. La premessa è che non solo il luogo (meta)fisico attraverso cui accediamo ai film stia venendo sopraffatto da sistemi automatizzati, ma che anche il modo con cui i “contenuti audiovisivi” vengono concepiti è sistematicamente dipendente da un ecosistema dove il non-umano detiene la maggioranza.
Il motivo per cui l’impiego dell’intelligenza artificiale nella produzione di questi contenuti si riscontra principalmente nelle serie televisive o piattaforme è perché il settore dell’IA è attualmente tra i più suscettibili della speculazione finanziaria, speculazione che trova agganci immediati all’interno di multinazionali già attive nel campo e in possesso di una riserva pressoché illimitata di dati. Da questo arazzo si diramano molti fili, alcuni visibili, altri meno immediatamente riconducibili al nodo di partenza. Lo sciopero degli sceneggiatori ad Hollywood nel 2023, ad esempio, è solo la parte più visibile di un processo di smantellamento che questa categoria professionale subisce da oltre vent’anni e che ha come movente principale il coinvolgimento delle società d’investimento statunitensi nel settore audiovisivo, che oggi detengono quote di maggioranza in compagnie concorrenti come Disney, Netflix o Apple.
Le cosiddette “streaming wars” sono conseguenza indiretta di questo intervento, che tra le varie cose è stato complice nel permettere che la crescita di abbonati potesse venir confusa con la crescita di profitto. Quando una bolla del genere scoppia, non esplodono solo i salari, le condizioni di lavoro, la cura manifatturiera del prodotto, ma viene generata anche un sacco di spazzatura, i cui detriti continueranno a fluttuare nella nostra orbita per molto tempo, col rischio di mutare per sempre non solo cosa si intende per “creatività” e “guadagno” ma causando anche l’estinzione di intere classi professionali.
Alcuni di questi deragliamenti sono deliziosamente ridicoli, perché nonostante l’affanno dietro al progresso rivelano ancora la natura tutta umana dei pasticci. Netflix, ad esempio, ha utilizzato – senza dichiararlo – l’intelligenza artificiale per ricostruire delle voci fuori campo in un suo true crime, di fatto screditando l’integrità del proprio approccio investigativo. Amazon utilizza la generative AI per le cover dei film di catalogo, col risultato che il Nosferatu di Fritz Lang viene offerto in streaming raffigurato con quattro dita anziché nel memorabile poster originale. Non scoraggiata da simili scivolate, sempre Amazon ha messo sotto contratto Fable Studio, una start-up che promette cartoni animati generati da semplici prompt. Come proof of concept, ha pubblicato dieci minuti di una puntata di South Park taroccata dall’AI, mentre la prima serie originale si dovrebbe intitolare Exit Valley, “una commedia televisiva genere I Griffin ambientata a ‘Sim Francisco’ che prende in giro i leader della tecnologia AI come Sam Altman, Elon Musk e altri”. Saremo questo, nell’aldilà, uomini che sussurrano alle macchine cose già viste?
Arrivata alla fine di questo articolo, ho bisogno di qualcosa che mi aiuti a guardare avanti. Mi viene in mente la categoria “time-based art”, che si usa talvolta per differenziare certe opere d’arte da quelle di tipo plastico o concettuale. Si tratta di formati audiovisivi, installazioni o su schermo, che sono dipendenti dal tempo, dalla durata. Anche noi lo siamo. E finché in circolazione ci saranno degli umani che conoscono il significato della parola fine, quella dei film sarà sempre temporanea, una prova generale in eterna attesa di quella vera.
Come dicevano su fuori orario il 7 novembre 1993: “Anche se finisce la proiezione, il film non è finito, lo sappiamo, lo dobbiamo proseguire noi. E solo l’apocalisse, per l’appunto, è, forse, la fine. (…) Ma è come il tempo, il tempo per noi c’è perché non ne vediamo l’inizio, non ne vediamo la fine. Solo per questo c’è il tempo e quindi abbiamo gli inizi e le fini: perché non la vediamo la fine, l’inizio, e quindi sogniamo. E ci è stata annunciata, più volte, l’apocalisse e il momento in cui assisteremo a una fine. Ecco, i finali dei film sono, simulano questa grande catastrofe, questa grande apocalisse. La fine davvero in diretta. Buona visione: Finalmente la notte”.