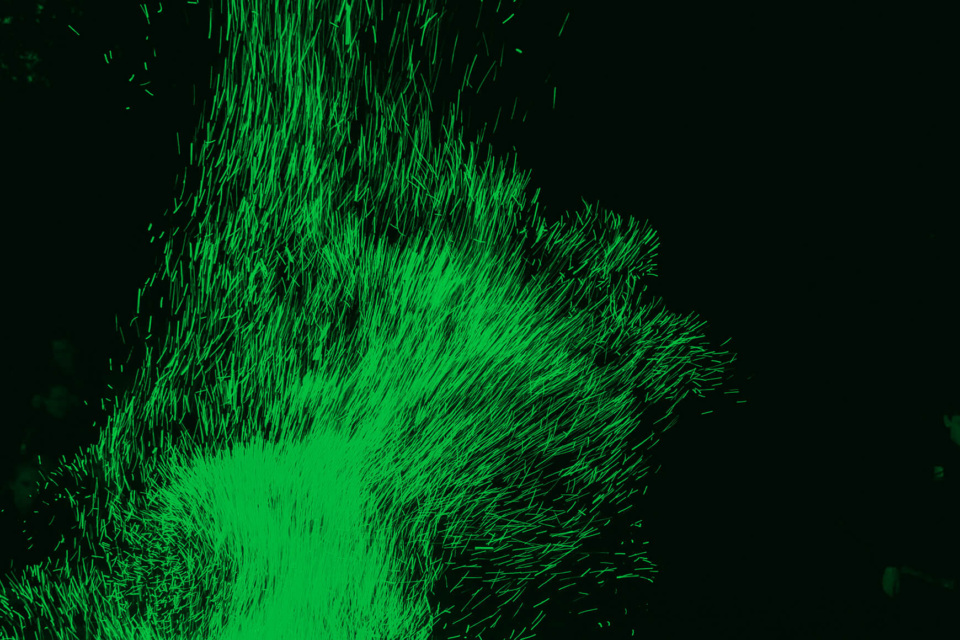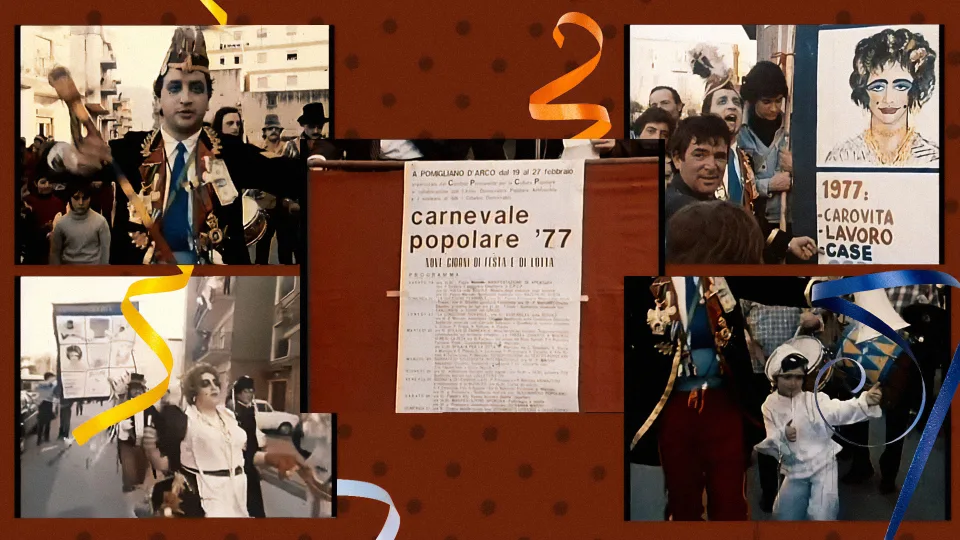Lo psicologo Jonathan Haidt ha pubblicato uno studio che illustra le ragioni di un fenomeno curioso: la maggiore concentrazione di disturbi psichici di vario tipo si riscontra tra le ragazze giovani e benestanti. Com'è possibile? L'unica spiegazione possibile è una: i social network e le regole relazionali e moraliste che li dominano.
Dal mio balcone a Montreal, in Canada, vedo spesso dei bambini giocare per strada. Urlano, saltano, sfrecciano tra i passanti in bicicletta o in monopattino. Le strade sono tranquille, residenziali, ma comunque aperte al traffico; nei dintorni non sembrano esserci adulti a sorvegliarli. Sono tutti figli degli ebrei ortodossi che risiedono in gran parte nel quartiere in cui abito. Vivono in comunità chiuse e coese e, nonostante abitino in una metropoli nordamericana, riescono a tenersi lontani dal resto del mondo. Non usano alcun tipo di tecnologia avanzata, in rari casi possono usare dei cellulari vecchio stile, che chiunque riterrebbe obsoleti.
La loro vita può apparire opprimente, fatta di privazioni e una certa rigidità nel gestire i ruoli di genere. Ma è pur vero che i loro figli sono gli unici bambini rimasti a giocare per strada in modo spericolato, senza adulti preoccupati che li sorveglino, timorosi di rapimenti o incidenti. Ai più piccoli è concesso di assumersi dei rischi per esplorare il mondo – rischi comunque arginati dal fatto di poter poter contare su una grande comunità che vive nel quartiere, pronta ad aiutarli in caso di problemi. Osservandoli, mi sono chiesto come mai sia sempre più raro vedere dei bambini giocare per strada. Eppure è noto come questo tipo di gioco, quello che comporta dei rischi, sia fondamentale per la crescita dei bambini, affinché sviluppino “anticorpi” contro l’ansia e la paura di ciò che non conoscono.
Secondo l’ultimo libro dello psicologo sociale Jonathan Haidt, The Anxious Generation, un possibile “colpevole” è il progresso tecnologico, che negli ultimi decenni ha contribuito a far abituare i bambini all’uso di smartphone e social media, disincentivandoli a giocare all’aria aperta. Questo passaggio, scrive Haidt, avrebbe portato a conseguenze significative dal punto di vista psicosociale. A partire dal 2010 – anno in cui Facebook è diventato mainstream e in cui è stato lanciato l’iPhone 4, il primo con la fotocamera frontale – si è osservato un peggioramento della salute mentale, e in particolare dei cosiddetti disturbi internalizzanti – ansia, depressione, stress psicologico – tra gli adolescenti, soprattutto di sesso femminile. Questo fenomeno riguarda tutta l’anglosfera, dagli Stati Uniti all’Australia, e l’Europa.
Come mai i giovani nati dalla fine degli anni Novanta, quelli della generazione Z, stanno così male? Perché a partire dal 2010? Negli anni sono state proposte una serie di spiegazioni: la crisi economica del 2008 e la conseguente incertezza economica, l’angoscia dovuta al cambiamento climatico, le sparatorie scolastiche. Forse siamo semplicemente più consapevoli dei sintomi di ansia e depressione, e di conseguenza li riportiamo di più quando ci vengono chiesti. Potrebbero essere tutte spiegazioni valide, eppure alcune sono circoscritte per lo più agli Stati Uniti (le sparatorie) quando questo fenomeno si osserva in tutto l’Occidente. Altre sono facilmente testabili.
La rivista scientifica «Nature», nel commentare il libro di Haidt, obietta che, più che i social, a causare questa sofferenza nei giovani sia perlopiù l’incertezza economica. Ma sorprendentemente, pare sia vero il contrario: un’analisi della psicologa Jean Twenge rivela che negli Stati Uniti a stare peggio sono le adolescenti di status socioeconomico più alto. Se l’aumento di ansia e depressione riguardasse trasversalmente tutta la popolazione, allora si potrebbe supporre che sia l’angoscia dovuta al cambiamento climatico o alla crisi economica a esserne la causa principale; eppure questo fenomeno riguarda soprattutto le adolescenti. Si potrebbe allora dire che è probabile che oggi, grazie ai social, i giovani siano più consapevoli dei disturbi mentali, o che tendano a ingigantire i loro problemi identificandosi con una diagnosi psichiatrica – ma se c’è una cosa che non si può fingere sono le ammissioni al pronto soccorso per autolesionismo, anche quelle in aumento costante dal 2010. I dubbi a questo punto sono sempre meno, anche alla luce di diversi studi sperimentali e longitudinali (in cui è più facile individuare cause ed effetti): l’uso dei social non è semplicemente associato a una peggiore salute mentale tra i giovani, ne è una causa.
Se osserviamo il contesto europeo, l’incremento percentuale peggiore dello stress psicologico tra gli adolescenti, anche in questo caso a partire dal 2010, non riguarda tutti i paesi allo stesso modo. Si è verificato tra paesi dell’Europa occidentale ad alto reddito, di religione protestante, a bassa religiosità, ad alto individualismo. L’Italia rientra in quasi tutte queste categorie, fatta eccezione per la bassa religiosità e il protestantesimo. E infatti il contesto italiano sembra confermare queste tendenze, visto che negli ultimi anni in Lombardia c’è stato un aumento drammatico di ragazze che hanno fatto ricorso ai servizi di assistenza psichiatrica. In questi paesi i più giovani si sono trovati isolati, poco equipaggiati e più vulnerabili agli effetti negativi dei social. Al contrario, quelli nei paesi meno individualisti e più religiosi avrebbero potuto contare su relazioni solide nel mondo reale, piuttosto che online, beneficiando del loro effetto protettivo contro ansia e depressione.
I social tendono a esacerbare una serie di dinamiche che incidono negativamente sulla salute mentale: portano a una riduzione della vita sociale, contribuiscono alla privazione del sonno, che ci rende irritabili, stanchi e ansiosi e riducono la nostra soglia di attenzione. Queste dinamiche fanno male a tutti, quindi c’è da chiedersi perché proprio le ragazze ne abbiano risentito maggiormente.
Una prima spiegazione è che sui social le adolescenti sono sessualmente più vulnerabili. Inoltre, rispetto ai ragazzi, le ragazze sono più predisposte a confrontarsi tra di loro su temi legati all’estetica e al corpo. Sui social, l’aspetto fisico, la bellezza e il fatto di possedere determinate caratteristiche del viso e del corpo sono questioni centrali. È facile puntare il dito contro influencer mainstream come le sorelle Kardashian – i cui profili Instagram pullulano di volti attraenti ma grottescamente simili tra loro, con zigomi alti, labbra gonfie, e mascelle squadrate – ma molte le avranno ormai bollate come “modelli inarrivabili”; adesso tutti possiamo modificarci il viso o il corpo senza troppe difficoltà, sia con filtri che con procedure cosmetiche. Tutto ciò può avere un impatto significativo sulle adolescenti, già la categoria più colpita dai disturbi alimentari e dell’immagine corporea.
C’è poi un fattore ancora più rilevante. Sappiamo dalla letteratura sulle differenze di genere che, mentre solitamente i ragazzi esprimono l’aggressività in modo fisico, le ragazze usano modalità più indirette e relazionali, che si manifestano attraverso la diffusione di voci, gossip, danni reputazionali, ostracismo. In questo senso, diversi studi hanno dimostrato come, in ambito digitale, le ragazze siano più aggressive dei ragazzi; i social offrono l’occasione perfetta per mettere alla gogna e rovinare la reputazione di altre ragazze. Basti pensare, anche in Italia, a come tante influencer e attiviste si facciano la guerra a vicenda, costantemente pronte ad attaccarsi e a spingersi giù dal piedistallo. Di recente, i più attenti (o annoiati) avranno assistito ai piatti che sono volati su instagram tra due fazioni di sedicenti attiviste che si accusavano vicendevolmente di aver commesso azioni meschine e ipocrite per infangare le donne appartenenti alla fazione opposta.

È probabile che questi personaggi siano seguiti per lo più da ragazzine – se sei una giovane donna online, è impossibile non imbattersi nella “cancellazione” del giorno. Che effetto può avere sulle più giovani questa cultura della gogna e dell’indignazione, in cui il prossimo viene percepito come una minaccia costante? In cui il disaccordo, il conflitto e gli errori (o presunti tali) vengono puniti, percepiti come minacce, talvolta persino come abusi?
Mi metto nei panni di un adolescente che osserva tutto ciò e mi chiedo: cosa mi succederebbe se oggi, su Instagram, dicessi la cosa sbagliata? Se mi accusassero di qualcosa che non ho fatto? Ci possiamo illudere di essere vaccinati contro la cancel culture tipica del mondo anglosassone, eppure non ne siamo completamente immuni, se consideriamo il nostro gusto per l’oltraggio, per lo scandale du jour, e la propensione a importare le peggiori tendenze provenienti da oltreoceano.
Si può dire a questo punto che le ragazze siano vulnerabili a una sorta di terapia cognitivo-comportamentale al contrario che domina sui social. La terapia cognitivo-comportamentale è un approccio psicoterapeutico che ha l’obiettivo di riconoscere e modificare comportamenti e pensieri distorti che possono essere dannosi per l’individuo. Esempi di distorsioni cognitive sono il catastrofismo, il pensiero dicotomico, la presunzione di prevedere il futuro e di saper leggere la mente altrui, e il ragionamento emotivo. La terapia cognitivo-comportamentale si è dimostrata efficace nel trattare ansia e depressione, scardinando gli schemi di pensiero infruttuosi dei pazienti. Ma la cultura in cui sono immersi i social tende a rinforzare invece gli schemi disadattativi: il disaccordo è considerato violento e pericoloso (catastrofismo); se non stai dalla nostra parte sei contro di noi (pensiero dicotomico o in bianco e nero). Ragionare in questo modo non è solo sintomo di ansia o depressione, più spesso ne è la causa.
***
Sono nato nel 1997, anno che viene usato arbitrariamente per distinguere chi appartiene alla generazione Z. Io e i miei coetanei abbiamo attraversato la pubertà e la prima adolescenza proprio quando gli smartphone e Facebook hanno iniziato a entrare nelle vite di tutti. Verso i dodici anni ci sono stati dati in mano dei dispositivi che non sapevamo avrebbero avuto un certo tipo di influenza sui nostri pensieri e comportamenti. Dopotutto cosa poteva mai esserci di male nel restare in contatto con i propri compagni di classe e con altre conoscenze?
Da adolescente trascorrevo la maggior parte del mio tempo su Tumblr, una piattaforma per creare blog e condividere contenuti multimediali. Vi passavo buona parte della giornata: ero un adolescente gay in un contesto provinciale in cui le relazioni sociali con i miei coetanei mi mettevano ansia – ancora oggi i giovani LGBT hanno tassi di depressione più alti rispetto agli eterosessuali; non importa quanto aumenti l’accettazione dell’omosessualità e delle identità LGBT, la nostra salute mentale resta tra le peggiori… non a caso siamo anche tra gli utilizzatori più assidui dei social.
Era uno spazio che nell’anonimato mi aveva permesso di condividere i miei interessi, di curare minuziosamente l’estetica del mio blog, tra gif di Glee e di Lana Del Rey, di connettermi con persone da tutto il mondo che facevano parte dei miei stessi fandom – le uniche con cui avevo fatto coming out – persino di imparare l’inglese. Anche se su Tumblr c’erano contenuti inquietanti e non adatti ai minori (porno hardcore, autolesionismo, celebrazione dei disturbi mentali), eravamo ancora lontani dall’esibizionismo che i social stimolano oggi: il numero di follower non era pubblico e per molti di noi era più comune parlare dei propri interessi che condividere foto di sé e della propria vita privata.
Ciononostante passavo troppo tempo online, ed ero spesso di cattivo umore. I miei genitori erano preoccupati, e un giorno riuscirono a scoprire la password del mio computer e la usarono per monitorare cosa facessi online. Quando lo scoprii mi arrabbiai, sentivo che la mia privacy era stata violata. Oggi mi chiedo se non avrei fatto lo stesso vedendo mio figlio adolescente costantemente frustrato e ritirato in un mondo distante da quello reale, che pure era soffocante e insoddisfacente. Da bambino i miei genitori mi avevano permesso di esplorare il mondo e di assumermi rischi moderati. Ora erano comprensibilmente scettici rispetto a una nuova tecnologia di cui non conoscevano le conseguenze. Si può dire che avessero intuito quello che diversi studi scientifici avrebbero confermato anni dopo: che tutto quel tempo passato davanti al computer o al cellulare faceva male.
“I social tendono a esacerbare una serie di dinamiche che incidono negativamente sulla salute mentale: portano a una riduzione della vita sociale, contribuiscono alla privazione del sonno, che ci rende irritabili, stanchi e ansiosi e riducono la nostra soglia di attenzione”.
Erano Facebook e Instagram, i social che più somigliavano allo spazio pubblico, a frustrarmi. Combinavano il peggio del mondo reale (le persone del mio paese, quelle con cui andavo a scuola) e il peggio di quello virtuale (il cyberbullismo). Usarli era diventata un’occasione continua di confronto sociale: verso il basso, con persone che potevamo umiliare e prendere in giro; o verso l’alto, con persone che invidiavo, che percepivo come più belle di me, le cui foto ottenevano molti più like delle mie. Partecipavo anche io a quel coro di voci perennemente indignate e ossessionate da sé e dalla propria identità. Usavamo i social come rifugio e anestetico, ma così facendo abbiamo frantumato delle comunità nel mondo reale, che, pur non essendo perfette, erano comunque migliori del clima ostile che si andava creando online.
Sostenere che i social facciano male è rischioso, perché è retorico, “da boomer”. Eppure è vero. Basta osservare i comportamenti di noi adulti quando siamo online. Scrolliamo Instagram all’infinito senza riuscire a staccarci. Finiamo spesso su profili di persone che non ci piacciono, assecondando una sorta di masochismo emotivo digitale. Pensiamo male dei nostri amici e conoscenti quando condividono qualcosa con cui non siamo d’accordo. Controlliamo ossessivamente i like e i follower dei nostri fidanzati o ex. Dai social abbiamo imparato quel linguaggio tipico della psicoterapia che usiamo per descrivere e problematizzare esperienze che sono per lo più normali. Abbiamo paura di condividere un’opinione, che magari ci farà perdere degli amici, magari verremo “cancellati”.
È grazie ai social che ho conosciuto i miei amici più stretti e i miei fidanzati più recenti. Eppure resta vero il fatto che più li uso più mi alieno dal mio contesto e non riesco a godermi il momento. Sono una fabbrica di distorsioni cognitive e di emozioni negative, che si manifestano ad esempio con rabbia e indignazione su Twitter, o invidia su Instagram, dove è difficile bilanciare il desiderio di essere amati con quello di primeggiare e sentirsi superiori agli altri. Se tutto questo mi frustra ancora oggi che sono un adulto, non è difficile immaginare l’effetto negativo sui bambini e sugli adolescenti, che hanno capacità cognitive e di regolazione emotiva ancora in fase di sviluppo.
***
In passato si somministravano oppiacei ai bambini per calmarli o farli addormentare. Era concesso fumare ovunque, persino i minori potevano. Ci sono voluti decenni per dimostrare i danni di queste sostanze e per superare le resistenze da parte di chi aveva interessi nel difenderne i presunti benefici. La comunità scientifica è ancora divisa sugli effetti dei social sulla salute mentale, ma sospetto che con il tempo anche i più scettici si renderanno conto dei danni che abbiamo vissuto e che continuano a perpetuarsi sulla pelle dei più giovani, e che forse dare smartphone ipertecnologici a bambini e adolescenti non è una grande idea. Che non abbiamo gestito come avremmo dovuto la transizione dalle comunità della nostra infanzia a quelle virtuali di oggi.
Le soluzioni ci sono e non è troppo tardi per metterle in atto. Includono vietare l’uso dei telefoni nelle scuole, così da facilitare le interazioni di persona tra coetanei, e impedire ai piccolissimi di stare sui social. Proprio di recente il Surgeon General degli Stati Uniti – che non è un chirurgo ma il portavoce delle questioni di salute pubblica all’interno del governo federale – ha chiesto che sui social venga posto un avviso contro i potenziali danni per la salute mentale dei minori.

Un’altra misura importante sarebbe smettere di proteggere eccessivamente i bambini e gli adolescenti nel mondo reale, dedicando maggiore attenzione alla loro sicurezza in quello virtuale. Potremmo abbandonare l’idea che i giovani debbano essere protetti da qualsiasi tipo di disagio o controversia, perché ciò limita la loro capacità di affrontare situazioni difficili. Da adolescente percepivo i miei genitori come controllanti perché cercavano di limitare il tempo che trascorrevo con la tecnologia; ora, a più di dieci anni di distanza, comprendo la loro apprensione. Volevano che vivessi davvero, nel mondo reale, nonostante tutte le difficoltà e le persone spiacevoli con cui mi trovavo a condividerlo, senza la pretesa di proteggermi da rischi e fallimenti, che sono elementi chiave per sviluppare una certa elasticità e adattabilità ai cambiamenti.
Oppure potremmo continuare a far sì che i bambini e gli adolescenti vivano alcune esperienze e avventure indirettamente, osservando gli altri attraverso uno schermo – rimuovendo così i rischi che le esperienze più significative inevitabilmente portano con sé. Lasciare che siano solo i figli degli altri, quelli senza smartphone e social, a giocare e divertirsi per strada. Certo, è uno scenario confortante e sicuro, ma piuttosto deprimente.