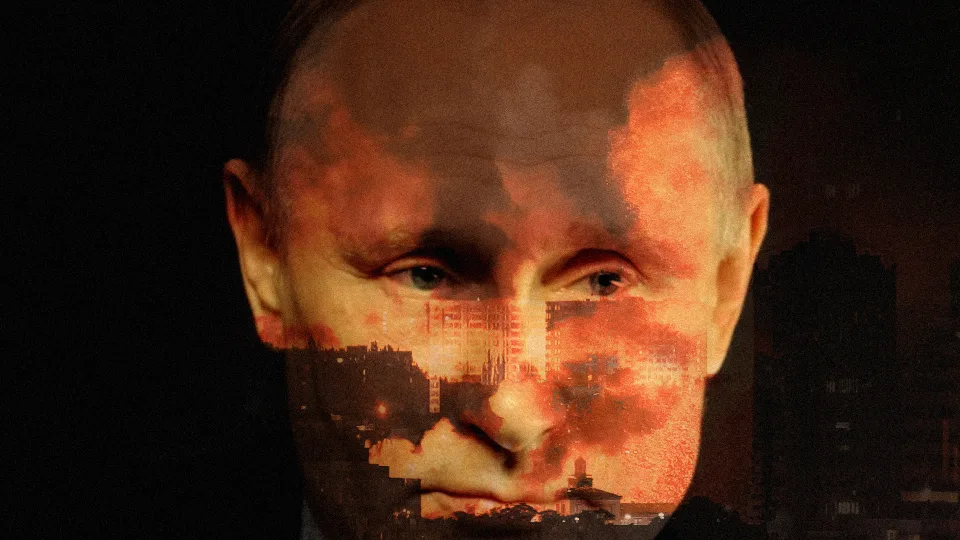Non ho fatto in tempo a rivedere Fantozzi al cinema, restaurato in occasione del cinquantesimo anniversario. Più che guardare lo schermo, forse mi sarei voltato a controllare l’età media degli spettatori in sala. Per i nostri genitori, tutti nati più o meno nell’immediato dopoguerra (tra i venti e i trent’anni all’epoca dell’uscita del primo film […]
Non ho fatto in tempo a rivedere Fantozzi al cinema, restaurato in occasione del cinquantesimo anniversario. Più che guardare lo schermo, forse mi sarei voltato a controllare l’età media degli spettatori in sala. Per i nostri genitori, tutti nati più o meno nell’immediato dopoguerra (tra i venti e i trent’anni all’epoca dell’uscita del primo film della serie), il travet ideato da Paolo Villaggio era l’incarnazione dell’incubo quotidiano della timbratura del cartellino, del grigiore della vita impiegatizia, degli alienanti svaghi di massa (il campeggio, il tennis, la vacanza sulla neve, il veglione di Capodanno), delle proposte culturali imposte dall’alto secondo i dettami di un secolare paternalismo padronale (il cineclub aziendale). Ma per gli attuali ultratrentenni ( mi ci metto dentro anche io), per i quali il posto fisso è più spesso un obiettivo da raggiungere che non l’orizzonte a cui sfuggire, a parte una certa nostalgia e un bel po’ divertimento a tinte sadiche, che cosa significa Fantozzi? Ci parla ancora? E se sì, in che modo?
Nel finale del terzo capitolo della saga, Fantozzi contro tutti (1980), il primo diretto da Neri Parenti, Fantozzi/Villaggio proclama a gran voce di essere “un uomo proprio riuscito”, con “una stupenda casa a equo canone” e addirittura “un telecomando a 99 canali”. All’epoca poteva sembrare (ed era) il misero sogno di un parastatale, peraltro subito punito da una fatale caduta in un tombino aperto; oggi, a voler giocare di paradossi, potrebbe persino essere (ma ribadisco: potrebbe) un ideale a cui aspirare.
Un personaggio inattuale, dunque. Eppure, non sarebbe difficile individuare i Fantozzi intorno a noi: il precario dell’università costretto a umiliarsi di fronte all’ordinario di turno per sperare in un contratto, l’eterna stagista pagata in “visibilità”, l’interinale che attende da anni di passare a tempo determinato… Si potrebbe andare avanti per ore, ma è un esperimento che lascia il tempo che trova e non ci dice granché sulla forza e la persistenza della creatura di Villaggio.
Ripartiamo allora dalla ricorrenza. Cinquant’anni di Fantozzi, si diceva, o meglio: cinquant’anni dal primo film, quello diretto da Luciano Salce su sceneggiatura di Leo Benvenuti e Piero De Bernardi e l’apporto diretto dello stesso Villaggio. Il quale Villaggio – genovese, classe 1932, famiglia agiata, un fratello gemello professore alla Normale di Pisa, ex speaker per la BBC, ex intrattenitore sulle navi da crociera, ex membro della compagnia teatrale Baistrocchi e soprattutto ex impiegato della Cosider – aveva ideato il suo personaggio più famoso in occasione del debutto televisivo a Quelli della domenica, facendone il protagonista involontario di una serie di surreali monologhi.
L’anno era, manco a dirlo, il 1968. Da Parigi a Praga, mezzo mondo è in subbuglio; in Italia, le promesse non mantenute dal boom economico sfociano in una lunga stagione di rivendicazioni sociali, operaie e studentesche. È questo il contesto in cui il comico genovese passa dal piccolo schermo alla carta stampata, trasformando i monologhi televisivi in brevi racconti pubblicati sul settimanale rizzoliano «L’Europeo»; ed è in queste pagine che, mentre dichiara candidamente di “non saper scrivere in italiano”, Villaggio mette a punto quella sorta di neolingua impiegatizia, da lui stesso definita “stile dei commissariati di Pubblica Sicurezza”. Una componente chiave nella costruzione dell’universo comico fantozziano, sulle cui ascendenze si sono interrogati in molti.
Alcuni, forse suggestionati dall’ambientazione, hanno voluto vedere nelle disavventure del ragionier Ugo una sorta di versione più leggera e potabile della letteratura industriale dei vari Bianciardi, Ottieri, Volponi. L’analogia tuttavia regge fino a un certo punto. Mentre romanzi come Donnarumma all’assalto (1959) e Memoriale (1962) mettevano in scena un mondo del lavoro ben definito (l’ufficio, la fabbrica) e popolato di figure riconoscibili da un punto di vista sociale (l’intellettuale borghese, l’operaio in preda alla nevrosi), Villaggio tende a opacizzare luoghi e personaggi. Il suo cronotopo è già quello del terziario e di una incipiente deindustrializzazione: una città anonima, nei libri vagamente ispirata a Genova (la città vecchia, il mare) e destinata nei film a diventare una Roma semiperiferica e irriconoscibile; una misteriosa Megaditta (nel primo Fantozzi cinematografico viene identificata con una improbabile “Italpetrolcemetermotessilfarmometalchimica”: di fatto, una crasi di tutte le partecipate statali dell’epoca); un protagonista “a metà”, troppo in basso per essere incluso a pieno titolo fra i colletti bianchi (nel Secondo tragico Fantozzi apprendiamo che occupa il dodicesimo e ultimo grado nella gerarchia aziendale) ma al tempo stesso troppo in alto per partecipare alle rivendicazioni di una classe operaia che comunque gli è sconosciuta. Fantozzi non è nemmeno Cipputi: non ne possiede l’intelligenza sarcastica né la coscienza di classe; e quando prova a ribellarsi, come nel finale del primo film (“Ma allora mi hanno sempre preso per il culo!”), lo fa con l’avventurismo individualista del piccolo-borghese (“Vigliacchi! Ce l’avete tutti con me, ce l’avete! Ma che cosa v’ho fatto? Vent’anni della mia vita!!!”), non certo in nome di una lotta collettiva.
Lingua e stile si adeguano. Se è vero, come ha fatto notare Claudio Giunta, che alcuni tratti del futuro “fantozzismo” sono presenti in certe pagine della Vita agra (1962), è vero altrettanto che mentre quella di Bianciardi è – parole sue – soprattutto “la storia di una nevrosi, la cartella clinica di un’ostrica malata che però non riesce nemmeno a fare la perla”, in Villaggio è la sola realtà possibile. Non una parodia, dunque, come vorrebbe Giunta, ma una realtà ormai talmente fuori misura da poter essere raccontata soltanto in chiave paradossale: non più la Fabbrica, ma la Megaditta; non più l’ufficio, ma il “sottoscala pauroso”; non più il direttore, ma “un’astrazione kafkiana”. Volendo rintracciare dei precursori a ogni costo, un candidato possibile potrebbe essere il Frassineti di Misteri dei ministeri (la prima versione esce nel 1952, la seconda sette anni dopo), nel quale la satira di una burocrazia disumana e disumanizzante si esprime appunto nelle forme del (falso) trattato scientifico o addirittura dello pseudobiblion. Viene da chiedersi se Villaggio, con la sua solida – e spesso (ironicamente?) ostentata – cultura letteraria, lo abbia mai letto.
“Non ho fatto in tempo a rivedere Fantozzi al cinema, restaurato in occasione del cinquantesimo anniversario. Più che guardare lo schermo, forse mi sarei voltato a controllare l’età media degli spettatori in sala”.
Davanti allo straordinario successo dei pezzi apparsi sull’“Europeo”, Rizzoli decide, vincendo le perplessità dell’autore, di raccoglierli in volume. Nascono così Fantozzi (1971) e Il secondo tragico libro di Fantozzi (1974), autentici bestseller (si parla all’incirca di un milione di copie vendute) in un Paese che, tra bombe fasciste e crisi petrolifera, tutto sommato ha ben poco di cui ridere: un’Italia piccolo-borghese che, come ha ricordato di recente Giuseppe Lupo, è “ancora propensa a credere nelle favole del successo pur inseguendolo con metodi alla buona”, e che assiste attonita, come in un incubo a occhi aperti, allo sgretolarsi delle certezze faticosamente accumulate negli anni del Miracolo. Non a caso, in una intervista rilasciata nel 1975 alla Televisione Svizzera di lingua italiana, l’attore genovese parla esplicitamente di “momento tragico” (non solo nell’accezione fantozziana), in cui sul grande schermo trionfano kolossal catastrofici hollywoodiani come Airport (1970), L’avventura del Poseidon (1972) e L’inferno di cristallo (1973). Ebbene, secondo Villaggio, il suo Fantozzi è un film catastrofico, sulla catastrofe di un ceto medio(cre) educato al benessere e ora costretto a fare i conti col malessere degli anni Settanta.
All’uscita del primo Fantozzi la commedia all’italiana è in crisi: il quartetto Sordi-Gassman-Manfredi-Tognazzi, che ha dominato pressoché incontrastato per tutti gli anni Sessanta, fatica ormai a orientarsi in una realtà sempre più difficile da interpretare. Villaggio appare invece perfettamente attrezzato ai tempi nuovi. Ha letto il Gogol’ dei racconti pietroburghesi (Il cappotto in primis) e il Čechov di Morte di un impiegato, ha studiato con attenzione i meccanismi dei cartoon targati Warner Bros.; e, soprattutto, sembra possedere un’innata propensione al grottesco di matrice swiftiana. Proprio al grande autore irlandese si ispira Villaggio per uno degli episodi del collettivo Signore e signori, buonanotte (1976): diretto da Luigi Comencini, lo vediamo nei panni di un accademico dal forte accento germanico (variante del professor Kranz, uno dei suoi primi personaggi televisivi) che, sulla scorta della Modesta proposta, suggerisce di vendere i bambini delle famiglie più povere come cibo per i ricchi per risolvere il problema dell’alimentazione in una Napoli povera e sovrappopolata.
Più Swift che Gogol’, dunque? Gianni Celati notava a suo tempo come tutta la satira swiftiana sia costruita attorno a “un’immagine centrale di violenza” che dilata i fatti “a proiezioni di portata globale e catastrofica”, fino a scorgere in essi nientemeno che “il segno d’una dimensione infernale”. Ebbene, immagini di questo tipo sono ovunque nella saga fantozziana: il pollice ripetutamente massacrato a martellate, il “taglio di netto del mignolo dell’arcivescovo con anello pastorale”, la poltrona in pelle umana; per arrivare al Fantozzi murato vivo nei cessi all’inizio del primo film, o addirittura ridotto a fare da parafulmine sul tetto dell’azienda nel finale del secondo.
Le cose cambiano sensibilmente a partire dal terzo film; e non solo perché Salce viene sostituito alla regia da Parenti. Ancora una volta, è l’Italia intera che sta cambiando: “Dopo il gelo di questi anni di piombo”, sentenzia il personaggio di una vignetta di Altan, “godiamoci il calduccio di questi anni di merda”. Per il cinema italiano, gli anni Ottanta non sono un decennio particolarmente felice, sia dal punto di vista qualitativo sia da quello degli incassi. I vecchi maestri sono scomparsi, e quelli ancora in attività arrancano. E mentre si afferma una nuova leva di comici (Benigni, Troisi, Verdone, Nichetti, Nuti), i maggiori successi al botteghino sembrano arridere a prodotti più disimpegnati, come le commedie di Castellano & Pipolo con Adriano Celentano protagonista.
E Fantozzi? Incredibilmente non scompare; anzi, la sua ombra si allunga sulle altre interpretazioni di Villaggio, da Sogni mostruosamente proibiti (1982) a Ho vinto la lotteria di capodanno (1989). “Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile”, dice Villaggio alla fedele Pina (Milena Vukotic) in Fantozzi contro tutti. “E lo sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi”; e non a caso di lì a qualche anno avremo un Superfantozzi (1986) che attraversa l’intera storia dell’uomo a mo’ di vittima predestinata, buona per tutti gli usi. È il prezzo della sopravvivenza: malgrado gli agganci più puntuali alla realtà (la crisi della rappresentanza politica in Fantozzi subisce ancora, 1983, i processi di mafia in Fantozzi alla riscossa, 1990), la satira swiftiana dei primi episodi si stempera in una rassegnazione a tratti qualunquistica, tutto sommato coerente con il riflusso nel privato che predomina nel decennio. La risata che suscita Fantozzi non è più reazione sgomenta, ma distanziamento catartico. Si continua a ridere di lui, certo, ma non più col timore di riconoscervi qualcosa di noi, bensì con la pacifica consapevolezza che quella “cosa” buffa, cartoonesca, infantile, non ci riguarda affatto.
Tuttavia, se Fantozzi è indistruttibile, Villaggio lo è molto meno. Incanutito e fisicamente affaticato, l’attore cerca come può di sottrarsi alla tirannia del suo personaggio più remunerativo. Guardando i film, talvolta si ha l’impressione di assistere a uno scontro impari, Villaggio contro Fantozzi: un rapporto sadomasochistico in cui il creatore si fa aguzzino della propria creatura, sottoposta a pratiche sempre più umilianti, dalla sistematica storpiatura del nome (Fantocci, Bambocci, Pupazzi…) agli epiteti insultanti (il ricorrente “merdaccia”), fino ai veri e propri tentativi di soppressione fisica. “Io non sono io!”, gridava disperato Fantozzi nel secondo episodio della saga; e in effetti in questo periodo si assiste a una divaricazione via via più marcata fra il personaggio e il suo creatore, col primo che si fa umiliare alla Coppa Cobram o alle Olimpiadi Aziendali e il secondo che parla a Giovanni Minoli del figlio tossicodipendente ospitato a San Patrignano, si candida alle elezioni per Democrazia Proletaria e finisce per lambire un cinema più autoriale sotto la guida di Fellini e di Olmi, con tanto di Leone d’Oro alla carriera.
Tuttavia, quanto più Villaggio prende le distanze, tanto più inefficace e debole diventa Fantozzi. Alla fine degli anni Ottanta è praticamente un sopravvissuto. I momenti più riusciti degli ultimi film sono proprio quelli che tematizzano l’aspetto “terminale” del personaggio: come in Fantozzi va in pensione (1988), uno dei migliori titoli post-Salce, nel quale il Nostro è ormai talmente alienato da non poter più vivere senza lavorare, tanto da accettare di farlo gratuitamente, forse per sempre, in una sorta di Tartaro impiegatizio dove il tempo sembra non passare mai.
Naturalmente, in ossequio alle ragioni del botteghino, ci sarà spazio per ulteriori capitoli. Fantozzi in paradiso (1993), interamente giocato, fin dal titolo, sul tema della morte, si conclude con una reincarnazione: troppo forte la tentazione dell’ennesimo sequel, che difatti arriverà puntualmente tre anni più tardi con Fantozzi – Il ritorno (1996), nel quale il tapino viene rispedito sulla terra a causa di un Aldilà in overbooking. Infine, allo scoccare del terzo millennio, sarà la volta di un Fantozzi 2000. La clonazione, dove il ragionier Ugo viene restituito alla vita grazie a un ardito esperimento d’ingegneria genetica, per poter subire ancora, e ancora. Il film deve però fare i conti con innumerevoli defezioni, davanti (Gigi Reder, indimenticabile deuteragonista nei panni di Filini, è morto nel 1998) e dietro la macchina da presa (Parenti dà forfait e viene sostituito dallo sceneggiatore Domenico Saverni). Distribuito con scarso successo alla fine del 1999, segna il definitivo epilogo della saga cinematografica.
Sul momento, sono in pochi a piangerne la fine. Per i più, Fantozzi è soprattutto un’occasione perduta, esempio emblematico di un’intuizione geniale che si è andata tristemente annacquando per bieche ragioni commerciali. Lo stesso Villaggio accetterà di vestirne i panni soltanto in qualche siparietto televisivo non proprio alla sua altezza: sempre più amaro e dissacrante, giunto nell’alta età l’attore genovese sembra voler prendere congedo una volta per tutte dal personaggio che gli ha dato la fama. Come in una sorta di tragicomico contrappasso, accadrà invece il contrario.
La rivincita di Fantozzi parte dalla lingua. C’era da aspettarselo, del resto: nessun personaggio, neanche il Checco Zalone di Luca Medici (che pure è probabilmente, anche in virtù dell’enorme successo, l’unica altra “maschera” comica emersa nel cinema nostrano dopo quella di Villaggio) ha una dimensione così “scritta” come il nostro ragioniere. Che infatti entra di prepotenza nei dizionari. Cito dal vocabolario Treccani: “fantòzzi (o Fantòzzi) s. m. [uso antonomastico del cognome del ragionier Ugo Fantozzi, personaggio comico cinematografico creato e impersonato dall’attore P. Villaggio], fam. – Uomo incapace, goffo e servile, che subisce continui fallimenti e umiliazioni, portato a fare gaffes e a sottomettersi ai potenti: oggi mi sento proprio un f.; i fantozzi della politica”.
“Tuttavia, se Fantozzi è indistruttibile, Villaggio lo è molto meno. Incanutito e fisicamente affaticato, l’attore cerca come può di sottrarsi alla tirannia del suo personaggio più remunerativo. Guardando i film, talvolta si ha l’impressione di assistere a uno scontro impari”.
In generale, è l’idioma villaggesco a rimanere parte integrante del lessico quotidiano. Non occorre qui citare Stefano Bartezzaghi, che alla lingua fantozziana ha dedicato anni fa pagine argute e divertenti. A chi non è mai capitato, almeno una volta, di utilizzare parole o espressioni come megagalattico, mostruoso, cagata pazzesca, rutto libero? E se i più colti si spingono abitualmente fino al puccettone del Geometra Calboni (Giuseppe Anatrelli) e al Ah, anche poeta! della Signorina Silvani (Anna Mazzamauro), per tutti gli altri c’è sempre l’immancabile repertorio di vadi, venghi, eschi, si siedi, mi dichi. Insomma, invece di chiederci se Fantozzi ci parli ancora, dovremmo semmai prendere atto di quanto ancora siamo parlati da Fantozzi.
Anche attraverso la sua immagine. La creatura di Villaggio è infatti sopravvissuta alla scomparsa (2017) del suo ideatore, continuando a vivere nelle ristampe dei suoi libri, nei documentari (da La voce di Fantozzi di Mario Sesti, al recentissimo Mostruosamente Villaggio di Valeria Parisi), nei podcast (ultimo, in ordine di tempo, Fantozzi Forever), nelle trasposizioni teatrali (Fantozzi. Una tragedia di Davide Livermore, interpretato da Gianni Fantoni); e ancora nelle gif animate (su Tenor e Giphy se ne possono trovare in quantità), nei meme, nei mashup (memorabile, qualche anno fa, quello con Cowboy Bebop, ma anche quello con Eraserhead è quasi perfetto); e non è mancato neppure un Fantozzi in chiave vaporwave.
Una sopravvivenza che non manca di un risvolto ironicamente ambiguo: dopo averne decretato la progressiva involuzione, è proprio la cartoonizzazione del personaggio a garantirgli una sorta di immortalità. In questa transustanziazione senza fine, oltre le mode, i media e i supporti, per quanto smaterializzata e sempre più decontestualizzata (e decontestualizzabile), l’inconfondibile sagoma dell’eterno ragioniere rimane più presente che mai, col suo basco, i suoi pantaloni ascellari, la sua Bianchina. Tutto sommato, non serviva un anniversario per ricordarcelo: non possiamo non dirci fantozziani.