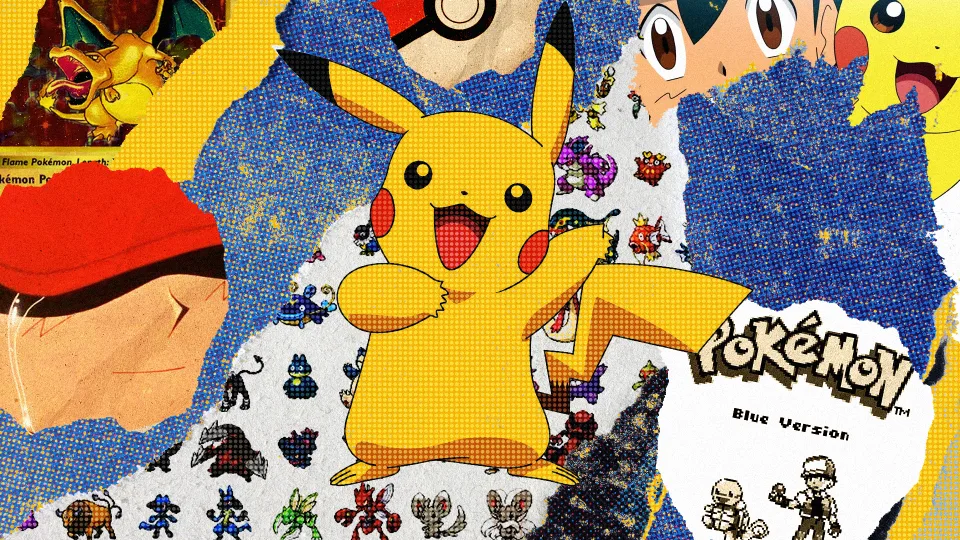Lo scorso weekend, il 19enne egiziano Ramy Elgaml è morto a Milano dopo un lungo inseguimento con i Carabinieri. A seguito della sua morte, un centinaio di ragazzi del suo quartiere, Corvetto, sono scesi in strada chiedendo giustizia. Ma che tipo di giustizia? E che temi solleva, oltre la cronaca, quello che è accaduto?
A Milano, nella notte tra sabato e domenica, uno scooter fuggiva, in una folle corsa contromano, inseguito da una volante dei carabinieri. A bordo viaggiavano due ragazzi di 19 e 21 anni: Ramy Elgaml, egiziano, arrivato in Italia undicenne, e Fares “Fafà” Bouzidi, tunisino, alla guida (senza patente), entrambi residenti a Milano. Poco prima delle quattro di notte, i due non si erano fermati all’alt dei carabinieri in via Farini, non lontano da corso Como, zona di locali e discoteche molto frequentata.
Le ragioni della fuga, secondo i primi accertamenti, starebbero nel contenuto delle tasche di Fares “Fafà”: una collanina, mille euro in contanti, un coltello, uno spray al peperoncino. Entrambi i ragazzi avevano precedenti penali. Una volante dei carabinieri ha inseguito lo scooter per tutta la città in direzione Corvetto, dove i due risiedevano. Come ha riportato l’Ansa, “Nel lungo rettilineo di via Ripamonti il 22enne ha perso il controllo della moto che salita sul marciapiedi si è schiantata contro un muretto, all’altezza di via Quaranta. Ramy Elgaml è stato sbalzato prima dell’impatto. Un colpo fortissimo. Intanto l’auto dei militari si è fermata, finendo la corsa contro un semaforo”. In una dinamica ancora da accertare, lo scooter si schianta, e Ramy, seduto come passeggero, avendo smarrito il casco nell’inseguimento, è volato dalla moto e muore in ospedale, dove Fafa è ancora ricoverato e piantonato.
Alcune centinaia di suoi amici e conoscenti, nelle ore successive all’incidente, si sono trovati nel luogo dell’impatto in via Ripamonti, accendendo fumogeni e lasciando fiori.
L’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti, dove Ramy è morto, è animato anche a distanza di giorni, la sera di martedì. Il palo e il cartello del benzinaio sono ricoperti di fiori, lettere, fotografie e dal suo nome, RAMY, scritto in ogni spazio di muro libero, affiancato a un cuore disegnato, che tappezza tutto il quartiere e la strada che unisce il luogo dell’impatto dalla casa, destinazione finale della fuga. Accanto al palo c’è una ragazza in lacrime. Qualcuno ha posato una bottiglia di latte e una lattina di Redbull. Fuori dal cantiere lì dietro, un lenzuolo recita “Verità per RAMY ”.
Chiedono “verità e giustizia” perché per loro non si è trattato di un incidente: nella loro ricostruzione, i carabinieri avrebbero speronato lo scooter. Le registrazioni video al momento non riescono a determinare se tale scontro ci sia stato o meno. In mancanza di conferme, la rabbia è cresciuta e si è tramutata in due notti di proteste accese, con un centinaio di ragazzi per le strade che hanno incendiato cassonetti, oltre ad aver bloccato un autobus e preso a calci un’auto che aveva in precedenza investito alcuni di loro. Per queste azioni, lunedì sera è stato arrestato un ragazzo montenegrino, sempre ventenne. La procura ha disposto un’autopsia per venerdì, e ha iscritto nel registro degli indagati Fares Bouzidi e il vicebrigadiere del Radiomobile che era al volante della macchina che seguiva lo scooter. L’ipotesi di reato per entrambi è quella di omicidio stradale. Per il primo, si aggiunge anche resistenza a pubblico ufficiale.
Il padre di Ramy ha affermato: “Nessuna vendetta. Rispettiamo la legge del nostro paese, l’Italia. Abbiamo fiducia nella magistratura italiana, vogliamo solo sapere ciò che è successo. Ci dissociamo da tutti i violenti, e ringraziamo tutti per la loro vicinanza”.
I giornali e molti politici hanno commentato l’accaduto ricorrendo a formule pigre, richiamando l’immaginario dell’insicurezza legata alla migrazione: “effetto banlieue”, “guerriglia urbana” “notte di fuoco”. In molti hanno invocato più sicurezza (sia in relazione all’inseguimento che agli scontri), hanno descritto la città come una polveriera e evidenziato la necessità di rafforzare i presidi di controllo (e il dispiegamento delle forze dell’ordine) a tutela dei cittadini. Tra gli obiettivi dichiarati, si parla della necessità di riportare la legalità e difendere i residenti dai “criminali”. Per chi ha un po’ di memoria, i fatti di questi giorni richiamano alla mente la storia di un altro diciannovenne egiziano. Il 13 Febbraio 2010 all’altezza del civico 80 di via Padova, una rissa tra giovani peruviani ed egiziani si è conclusa con l’uccisione Ahmed Abdel Aziz el Sayed Abdou. Anche allora, a seguito della morte del ragazzo, sono seguiti attimi di tensione e momenti di “guerriglia” ad opera di un gruppo di egiziani, successivamente sedati dalle forze dell’ordine. L’evento aveva attirato l’attenzione della stampa, della politica e dell’opinione pubblica, che anche allora aveva utilizzato per descriverlo espressioni non troppo dissimili da quelle di oggi: il “souk” di via Padova, la “polveriera”, la “banlieue”. Le due tragedie, ossia due morti di giovanissimi, sono state lo sfondo di uno scontro sulla sicurezza. Se negli ultimi 15 anni il tenore dei discorsi non è cambiato poi molto, la città sì. Gli stranieri a Milano oggi rappresentano il 19% della popolazione, e dal 2010 sono 60000 in più. Si tratta perlopiù di famiglie, di residenti, di regolari. Di questi, molti sono giovani e giovanissimi: più di 25000 hanno meno di 24 anni. L’Egitto è il primo paese di provenienza. A causa dell’assenza di una legge sulla cittadinanza che si accordi a queste trasformazioni demografiche e sociali, il 22,7% delle persone nate in Italia è nata straniera.
“I giornali e molti politici hanno commentato l’accaduto ricorrendo a formule pigre, richiamando l’immaginario dell’insicurezza legata alla migrazione: ‘effetto banlieue’, ‘guerriglia urbana’, ‘notte di fuoco’”.
A Milano, in particolare, un bambino su cinque nasce straniero. La proporzione più alta d’Italia. Altri, come Ramy, sono arrivati in città da ragazzini, a seguito della migrazione della famiglia. A questi vanno aggiunti, inoltre, circa 1400 minori stranieri non accompagnati. Queste distinzioni sono rilevanti per lo status giuridico, ma hanno poca incidenza sulla quotidianità di queste persone, che della città fanno parte, ne sono abitanti, e alla cui vita contribuiscono attivamente, subendone anche le varie forme di sfruttamento e iniquità. Se il riconoscimento giuridico tarda ad arrivare, e ancora di più quello sociale, anche solamente in chiave utilitaristica è importante evidenziare come Milano, e gran parte del paese, si reggano sulla presenza e attività di queste persone, elementi cruciali dell’economia metropolitana. In città l’82,6% dei residenti stranieri sono impiegati nei servizi, e il 40,2% dei lavoratori è impiegato in lavori manuali non qualificato (a prescindere dal titolo di studio).
Eppure si sente parlare di questi abitanti come di corpi estranei alla città, dai quali proteggersi, e di Corvetto in termini fortemente dispregiativi, rubricando tutto a una questione di sicurezza e legalità e rafforzando la paura e l’allarme sociale. Il sindaco Sala ha difeso la “città accogliente”. Si tratta di un approccio sicuramente meno degradante, che non risolve la separazione tra “cittadini” e “stranieri”, ma riproduce e riafferma il margine tra chi accoglie (e abita) e chi è accolto, mantenendo la condizione politica e morale di “ospite” della città, ne evidenzia la natura temporanea e revocabile. Una lettura che oggi risulta comunque problematica. Sarebbe miope considerare la collocazione geografica dei quartieri periferici come la causa primaria di queste tensioni, del “ghetto” come spazio patogeno, del periferico come ambiente di coltura del “disagio”. Sono interpretazioni altrettanto superficiali, che non tengono conto delle dinamiche metropolitane, delle spinte espulsive e delle condizioni in cui i ragazzi come Ramy Elgaml, nati in Italia ma non italiani, vivono tutti i giorni, quale città abitano davvero, cosa desiderano e cosa non è desiderabile.
Come scriveva Pierre Bourdieu ne La miseria del mondo (Mimesis edizioni, 2015), esistono luoghi “difficili”, spazi sociali non scelti, che riuniscono persone che non presentano punti di contatto, obbligandole a coabitare “sia nell’ignoranza o nell’incomprensione reciproche, sia nel conflitto, latente o dichiarato, con tutte le sofferenze che ne derivano”. Ciò che li lega è l’assenza di possibilità per essere davvero parte della città. La città, infatti, come aveva scritto Jane Jacobs già negli anni Sessanta, riescono ad assicurare qualcosa a tutti, solo quando sono create da tutti, ossia quando tutti ne fanno parte allo stesso modo.
Perché la periferia, in fin dei conti, non è altro che la differenza di potere: economico, sociale, culturale. Il margine si produce e si riproduce attraverso le forme di separazione, ridefinisce costantemente la geografia interna ed esterna dei confini della città, attraverso dispositivi fisici, politici e simbolici. Proprio per questo le periferie seguono le persone a prescindere dal codice di avviamento postale, si replicano in centro, nei locali, negli incontri tra ragazzi, negli scambi con le forze dell’ordine, moltiplicano e alimentano il confronto e i conflitti. Proprio per questo il ghetto è l’obiettivo e non la causa di questi processi, l’ultima tappa dei percorsi espulsivi che attraversano le metropoli. Negli ultimi anni, soprattutto nei quartieri con una forte presenza di edilizia residenziale pubblica, sono state investite molte risorse in progetti di integrazione, nel tentativo di provare a ricostruire i legami sociali indeboliti, a “guarire” il “disagio” delle periferie. Non basta però organizzare un laboratorio in quartiere, un centro di aggregazione, un doposcuola per arginare questa spinta centrifuga. Perlomeno, ora non basta più. Cosa accade di quelle dinamiche in Piazza Duomo o in Corso Como?
Questi interventi, seppur apprezzabili, non sono riusciti a dare potere davvero a chi sta ai margini, a chi è “margine”. Le timide strategie sociali e culturali adottate sino ad ora non sono state sufficienti a bilanciare le forze espulsive della città, dall’aumento del costo della vita alla turistificazione. Come si ricuce la slabbratura che esiste tra i quartieri “difficili” e la via più cara del mondo, che coesistono a meno di venti minuti di distanza?
Se questa distanza sociale e materiale vale indistintamente per tutte le persone che si trovano al margine della metropoli per ragioni di classe o di status, questa dinamica si rafforza ulteriormente nel caso dei cittadini stranieri, in cui al margine economico si somma il margine giuridico, il confine. Il confine si produce e riproduce negli incontri, nel mancato riconoscimento, nella valutazione morale della legittimità a stare, nella possibilità costante di revocare tale concessione. Il confine toglie ulteriormente potere, nella sua pervasività e permanenza che si manifesta nell’incertezza e revocabilità del riconoscimento, dell’accoglienza, dello status. Un ricatto perenne che si rafforza nelle parole e nei racconti populisti, nel costante allarme sociale. Un meccanismo attivo da trent’anni, che oggi però raccoglie le tempeste di chi ha seminato vento sulla pelle delle persone che hanno scelto di abitare qui. Milano non è l’unica città, ma per caratteristiche specifiche e per popolazione, anticipa e radicalizza queste tensioni.
Abdelmalek Sayad, nel sempre attuale volume La doppia assenza (Raffaello Cortina Editore, 2022) scriveva che “pensare l’immigrazione significa pensare lo Stato e che lo Stato pensa se stesso pensando all’immigrazione”. Sayad ci dice che pensare la città attraverso gli occhi di questi ragazzi significa pensarci, riflettere su noi stessi. E il modo in cui la città li pensa, definisce la città stessa. L’Italia è un paese accogliente? Milano è una città accogliente? Ci basta l’accoglienza come modello, anche di riflessione, su 30 anni di flussi migratori e stabilizzazioni? La città come pensa e come gestisce i suoi abitanti? Ė un bene o un male il fallimento dei processi di naturalizzazione? I nuovi cittadini, i nuovi residenti ci riescono a raccontare molto più di Milano di quanto non si possa fare. Mutatis mutandis, la città non può pensare se stessa senza considerare le nuove generazioni che la attraversano e la abitano, senza immaginare che ci sia uno spazio fisico e uno spazio sociale in cui sono anch’essi abitanti, di avere piena dignità di cittadini.
Quell’incertezza di status si riverbera nella difficoltà di riconoscersi e di appartenere ad un luogo, ma anche nel mancato spazio di opportunità e nella domanda di riconoscimento e la tutela di tutte e tutti. Ma la strada è ancora lunga: questa incertezza dei diritti ha un impatto e forse ci aiuta a comprendere alcune delle ragioni della rabbia a cui assistiamo in questi giorni. Per questo oggi c’è bisogno di immaginare altre pratiche, e di non guardare più alla città come uno spazio di concessione, con cittadini che accolgono di ospiti che sono “accolti”, ma si deve rendere più efficace la cittadinanza formale di tutte e di tutti come elemento sostanziale, la legittimazione di tutte e tutti come parti attive e cittadine. Perché la migrazione e il confine rappresentano il margine per eccellenza, quello più profondo, quello che rende impossibile la mobilità sociale. Solo la fine della condizione di precarietà giuridica permette, almeno in teoria, di costruire una città meticcia, una città per tutte e tutti.

Tra i fattori più critici che rendono questo percorso in salita ci sono sicuramente le forme di discriminazione – causa e conseguenza di questo mancato status – che ancora oggi queste persone in attesa di riconoscimento, in cerca di cittadinanza, soprattutto giovani e giovanissimi subiscono costantemente, soprattutto ad opera di alcune delle istituzioni che dovrebbero favorire questa coesione.
La fragilità giuridica diventa fonte di paura e di diffidenza nei confronti delle forze dell’ordine, che spesso rafforzano questo pregiudizio negativo attraverso processi di selettività ed esclusione.
Il recente Report Ecri del Consiglio d’Europa ha criticato duramente l’Italia, parlando esplicitamente di “profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine” con frequenti fermi e controlli su base etnica. Ecri afferma che le autorità non sembrano essere consapevoli di quanto questa pratica sia problematica, perché non considerano la profilazione razziale come una forma di potenziale razzismo istituzionale. “La profilazione razziale ha effetti notevolmente negativi, in quanto genera un senso di umiliazione ed ingiustizia per i gruppi coinvolti provocando stigmatizzazione e alienazione. È inoltre dannosa per la sicurezza generale in quanto diminuisce la fiducia nella polizia e contribuisce a non denunciare reati.”
Oltre alla profilazione, ritorna il margine evidenziato in precedenza: la selettività delle agenzie di controllo è condizionata anche dallo status socio-economico e dalla classe. In altre parole, salvo indagini più dettagliate, la ricchezza materiale opera come vettore di inclusione e di intoccabilità da parte delle forze dell’ordine a prescindere dal riconoscimento giuridico. Al contrario, rafforza i pregiudizi e l’esclusione quando la persona viene dal margine e lo rappresenta. Quella mancanza di potere diventa mancanza di protezione e spazio di azione della discrezionalità del controllo. Un aspetto centrale per una gioventù con le “opportunità bloccate” che vede molto difficile riuscire a raggiungere le mete sociali o quantomeno a poter accedere agli spazi di consumo di una città sempre più escludente.
Queste forme di violenza strutturale e di abuso sistemico a cui queste generazioni di giovani sono esposte, e che percepiscono come una delle più naturali forme di relazione con uno Stato che non ne riconosce lo status di cittadini, forse ci aiutano oggi a comprendere le rivolte degli ultimi giorni, la paura e la diffidenza nei confronti delle forze dell’ordine, la necessità di “essere visti” per poter essere riconosciuti come parti, come vittime, e ci chiedono a gran voce (con modi non del tutto ortodossi) di immaginare soluzioni diverse e congiunte. Non “concedere” i diritti, ma riconoscere la legittimità giuridica e politica di tutte e tutti, a prescindere dal tempo di residenza o dalla provenienza. L’incertezza di status denota una condizione di “impossibilità” dello stare davvero in un luogo, produce e riproduce rabbia e frustrazione, toglie costantemente potere, lasciando ai margini. Si deve allora ragionare davvero di cittadinanza: formale, ossia il riconoscimento giuridico di una serie di diritti necessari per sentirsi legittimati; sociale, intesa come scambio e interazione tra gruppi, non solamente “zone di contatto” potenzialmente conflittuali; e politica, ossia come spazio di parola e di voce possibilità di essere tutelati e quindi anche responsabili. Una battaglia urgente, perché basta poco perché i conflitti si possano rapidamente esacerbare. Un’eco di queste questioni ritorna in una conversazione tra alcune ragazze presenti sul luogo dell’impatto martedì sera. Le incontro al semaforo. Parlano in modo concitato: “ma non lo capite? È il momento di far sentire la nostra voce! Lo dobbiamo fare per Ramy, per Fafà, e per noi! Primo, perché li hanno sicuramente speronati! Poi, anche ammesso che non li abbiano speronati, mia mamma diceva che dopo 5 minuti hai l’obbligo di fermarti, non puoi mettere in pericolo tutti e inseguire uno scooter per tutta la città. Terzo, la polizia dovrebbe essere qui per proteggerci, non per attaccarci. Dovrebbe esserci ANCHE PER NOI, non solo per loro. Ed è ora che capiscano che esistiamo anche noi, che devono proteggere anche noi!”. Sul muro c’è scritta in grande la parola “Giustizia”. Nella prima versione le lettere sono scambiate, era “Giuztisia”, poi corretta. In quello scarto c’è tutto lo spazio per ripensare Milano, a partire da Corvetto, e rimettere in ordine non solo le lettere ma anche i desideri e le paure di chi la città la abita.
Gli scatti in questo articolo sono di Valeria Verdolini, che ne è anche l’autrice.