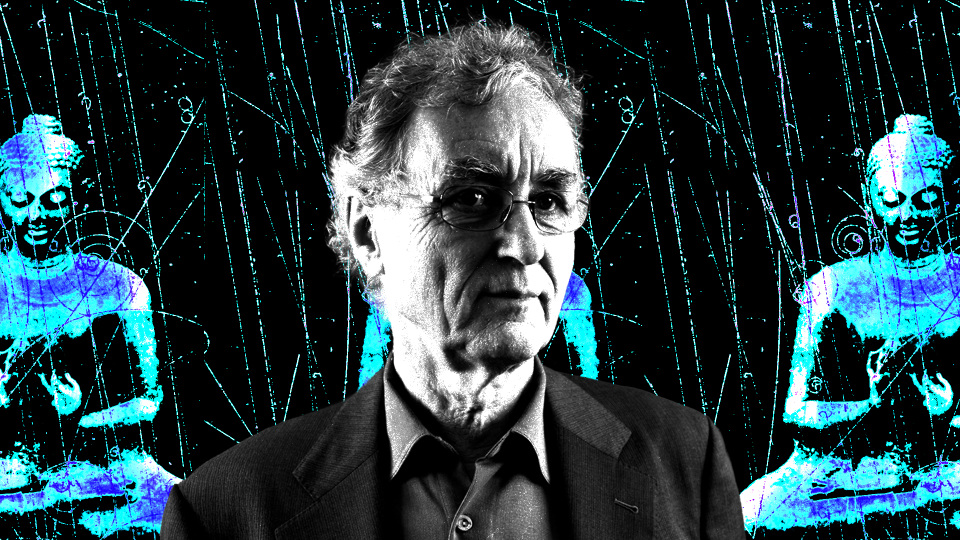Cinquant’anni dopo l'uscita del “Tao della fisica”, di cui Aboca ha da poco pubblicato una nuova edizione, Capra racconta il suo viaggio tra scienza e misticismo orientale. Dalla danza di Shiva alle particelle subatomiche, una visione olistica dell’universo che unisce fisica, spiritualità e vita.
Nel cortile del CERN c’è una statua di bronzo alta due metri che rappresenta il dio dell’induismo Śiva Nataraja. Ad avvicinarsi si può leggere la targa, e scoprire che la statua è stata donata dal Ministero dell’Energia Atomica indiano nel 2004 per celebrare il lungo rapporto di collaborazione tra l’India e il CERN. Un laboratorio scientifico, il più importante al mondo per lo studio della fisica delle particelle, è stato omaggiato con la statua di un dio. Sulla stessa targa, a spiegare il perché, c’è un estratto dalla prima edizione del Tao della fisica di Fritjof Capra, che a un certo punto dice: “For the modern physicists, then, Shiva’s dance is the dance of subatomic matter” (“Per i fisici moderni, la danza di Shiva è la danza della materia subatomica”). Quando uscì, nel 1975, il libro di Capra accese un’inedita e vivace discussione tra gli scienziati occidentali, perché diceva loro, più o meno, che la ricerca scientifica era giunta a un punto al quale le filosofie orientali erano già arrivate da millenni, cioè a una visione olistica della natura. E proprio la danza di Śiva rappresentava il punto di contatto tra la nuova scienza del cosmo e il pensiero mistico fiorito in Asia. Dopo cinquant’anni, un milione di copie vendute e ventitré traduzioni, e una nuova edizione aggiornata appena uscita per Aboca Edizioni, ripartiamo da lì.
L’universo danza: è la danza cosmica, in cui i movimenti e le attività incessanti delle particelle subatomiche tessono una fitta rete di interazioni e scambi di energia, in un continuo ciclo di creazione e distruzione. È così che la fisica moderna vede l’universo. Ed è anche così che lo concepisce la mitologia indiana, come un cosmo pulsante che attraversa cicli di creazione e dissoluzione. Quando lei si è imbattuto per la prima volta nella danza di Śiva, era già un fisico affermato. Come le è venuto in mente questo parallelo, e perché ha deciso di scriverne?
È successo nell’estate del 1969, durante una meditazione sulla spiaggia di Santa Cruz, in California. Sai, meditare sulla spiaggia era la cosa giusta da fare in quei giorni. Così, mentre sedevo su quella spiaggia in meditazione, improvvisamente percepii tutto il mio ambiente come impegnato in una gigantesca danza cosmica. Come fisico, sapevo che la sabbia, le rocce, l’acqua e l’aria intorno a me erano fatte di molecole e atomi vibranti, e che questi consistevano di particelle che interagivano l’una con l’altra creando e distruggendo altre particelle. Tutto questo mi era familiare per via della mia ricerca in fisica delle alte energie, ma fino a quel momento lo avevo sperimentato solo attraverso diagrammi ed equazioni matematiche. Su quella spiaggia, invece, le mie esperienze precedenti presero vita; e in quel momento seppi che era la Danza di Shiva Nataraja, il Signore dei Danzatori, rappresentato nella mitologia indiana.
Poco dopo, ideai un fotomontaggio — uno Shiva danzante sovrapposto alle tracce di particelle in collisione in una camera a bolle — per illustrare quella che oggi chiamo la mia “epifania sulla spiaggia”. E un giorno, guardando questa bellissima immagine, improvvisamente ebbi la chiara realizzazione che i paralleli tra la fisica moderna e il misticismo orientale sarebbero un giorno diventati conoscenza comune. Sentii anche che ero nella posizione giusta per esplorare a fondo questi paralleli e scriverne un libro.
Lei cita alcuni precedenti: molti altri fisici che studiarono e ammirarono le culture orientali prima di lei. Tra questi, Niels Bohr, che, insignito del più alto ordine di cavalleria della Danimarca, scelse per il suo stemma il simbolo del T’ai Chi. E perché, secondo lei, così tanti fisici del ventesimo secolo sono stati attratti dalle tradizioni asiatiche? È la fisica che favorisce una disposizione all’apertura e alla curiosità verso altre culture?
All’inizio del ventesimo secolo, le esplorazioni dei fenomeni atomici e subatomici hanno messo i fisici a contatto con una realtà strana e inaspettata che ha frantumato le fondamenta della loro visione del mondo e li ha costretti a pensare in modi del tutto nuovi. Da quel momento in poi, la discussione sulla natura della realtà non è più stata appannaggio esclusivo dei filosofi, ma ha cominciato a essere un tema anche per i fisici. E per quei fisici, alle prese con nuove e intense lotte intellettuali ed emotive, è stato naturale cercare ispirazione nelle filosofie di altre culture, così molti di loro — Werner Heisenberg, Niels Bohr, Robert Oppenheimer e altri — si sono rivolti alle filosofie dell’Oriente.
Il successo de Il Tao della Fisica, cinquant’anni fa, arrivò del tutto imprevisto. Perché successe, secondo lei? E cosa è accaduto con questa edizione del cinquantesimo anniversario: è cambiato il clima culturale, in particolare per quanto riguarda gli atteggiamenti verso la religione e il misticismo all’interno della scienza?
Il Tao della Fisica allora riuscì a toccare una corda sensibile in persone provenienti da esperienze diverse. Negli anni ho capito che la ragione è che il parallelismo tra fisica moderna e misticismo orientale fa parte di un movimento molto più ampio, di un cambiamento fondamentale delle visioni del mondo, chiamiamoli anche paradigmi, che sta avvenendo dappertutto, e che corrisponde a una profonda trasformazione culturale. In tanti hanno avvertito questa trasformazione, questo profondo cambiamento di coscienza, in questi ultimi cinquant’anni. Certo, da parte della comunità scientifica la reazione iniziale, prevedibilmente, fu molto più cauta; ma anche lì, nel tempo, le cose sono cambiate in maniera significativa. Ne discuto in dettaglio in tre nuovi capitoli in questa edizione anniversario.
In questi tre nuovi capitoli lei aggiorna il libro. E sostiene che nessuno dei progressi e delle scoperte fatte dalla fisica in questi cinquant’anni abbia invalidato la sua visione, anzi, che alcune scoperte l’abbiano rafforzata. Non tutti i suoi colleghi sono d’accordo e qualcuno la accusa, oggi come ieri, di confondere risonanze accidentali tra il linguaggio della fisica moderna e quello del misticismo orientale con prove di connessioni più profonde. Come risponde?
Posso dirle che all’inizio anch’io pensavo che i parallelismi tra la fisica moderna e il misticismo orientale fossero soltanto somiglianze casuali tra le parole. Ma, mentre mi addentravo più a fondo nelle filosofie religiose dell’Oriente, sia intellettualmente che per esperienza diretta, mi sono reso conto che queste si basano su una visione coerente del mondo che presenta due grandi temi: l’unità e l’interrelazione di tutte le cose, e la natura intrinsecamente dinamica dell’universo. E questi sono anche due grandi temi della visione della fisica moderna. Anzi, in realtà, di tutta la scienza moderna.
“Mentre sedevo su quella spiaggia in meditazione, improvvisamente percepii tutto il mio ambiente come impegnato in una gigantesca danza cosmica. Come fisico, sapevo che la sabbia, le rocce, l’acqua e l’aria intorno a me erano fatte di molecole e atomi vibranti, e che questi consistevano di particelle che interagivano l’una con l’altra”.
Le analogie che lei vede tra fisica moderna e pensiero orientale sono numerose: il dualismo tra esistenza e non-esistenza, superato dalla fisica moderna e inesistente nelle filosofie orientali; lo spazio-tempo, che con Einstein diventa una mera costruzione della mente, da cui consegue il carattere dinamico dell’universo riconosciuto da lungo tempo nei misticismi asiatici; il vuoto inteso come potenzialità piuttosto che come nulla. Perché nel pensiero occidentale a lungo si è rifiutata la visione olistica della natura stessa?
La tensione tra meccanicismo e olismo è stata un tema ricorrente lungo tutta la storia. Nel pensiero occidentale, gli antichi filosofi greci vedevano il cosmo come un organismo armonioso, così come fece Leonardo da Vinci nel Rinascimento; la Rivoluzione scientifica introdusse una forte prospettiva meccanicistica, ma la visione olistica rimase come un filone sotterraneo nei pensatori romantici, da William Blake a Johann Wolfgang Goethe. Nel ventesimo secolo, la prospettiva olistica divenne nota come “pensiero sistemico”. Questo è ciò che ho esplorato nel mio lavoro negli ultimi decenni.
Ecco: nella sua visione, la cultura occidentale ha deciso il dualismo tra spirito e materia già con i filosofi greci del quinto secolo. La storia poi avrebbe deciso che del primo si occupavano i filosofi e i religiosi, mentre per la seconda bastava l’eredità aristotelica, l’unica lettura della natura concessa in una società cristiana. La frattura fu cristallizzata poi in maniera definitiva dalla filosofia cartesiana. Questo, dice lei, ci ha concesso di dominare la natura, ma non ci ha mai permesso di capirla. Però dice anche che nel percorso del pensiero occidentale c’è stato un momento in cui questa frattura è stata sanata. Ed è stato il Rinascimento italiano e in particolare Leonardo da Vinci. Genio multiforme, meccanico che non cede al meccanicismo, vive una sintesi feconda di arte e scienza. Ma soprattutto è un pensatore sistemico, che guarda alla natura nella sua interezza. Ma perché Leonardo non ha avuto nessuna influenza sui posteri?
Cento anni prima di Galileo, Leonardo sviluppò da solo un nuovo approccio empirico, che implicava l’osservazione sistematica della natura, il ragionamento e la matematica: in altre parole, le caratteristiche principali di quello che oggi chiamiamo metodo scientifico. Sfortunatamente, il suo lavoro scientifico rimase praticamente sconosciuto durante la sua vita e per oltre due secoli dopo la sua morte. Così, le scoperte e le idee pionieristiche di Leonardo non ebbero alcuna influenza sugli scienziati che vennero dopo di lui. E mentre i manoscritti di Leonardo prendevano polvere nelle antiche biblioteche europee, Galileo veniva celebrato come il “padre della scienza moderna”. Oggi possiamo vedere che il vero fondatore della scienza moderna fu Leonardo da Vinci, ed è intrigante domandarsi come si sarebbe sviluppato il pensiero scientifico occidentale se i suoi Taccuini fossero stati conosciuti e studiati poco dopo la sua morte.
Nel poscritto a questa nuova edizione lei insiste sulla differenza tra spiritualità e religione: punta il dito sull’esperienza profonda della realtà che scaturisce da un’esperienza spirituale e fa notare che è questa esperienza che lei avvicina alle idee della fisica moderna e della concezione sistemica della vita. Non la religione, che è il tentativo di organizzare, interpretare e tradurre in forma concreta la spiritualità. Perché si è sentito in dovere di specificarlo?
Negli anni successivi alla prima pubblicazione de Il Tao della fisica, ovviamente ho avuto molte discussioni con i miei colleghi scienziati su scienza e religione. In queste discussioni, mi sono spesso stupito nel sentire che molti di loro sostenevano una visione dicotomica di scienza e religione, mentre altri non vedevano alcuna opposizione intrinseca tra le due aree. Negli anni, mi sono reso conto che l’origine di questa confusione è proprio la mancata distinzione tra spiritualità e religione.
Alla fine, in questi cinquant’anni lei non ha abbandonato la tesi centrale del libro. Però il suo percorso professionale si è evoluto: da fisico teorico a teorico dei sistemi, a filosofo, storico della scienza, scrittore. Si è anche rivolto alle scienze della vita e all’elaborazione di una nuova concezione della vita, olistica ed ecologica, dedicandosi al contempo all’attivismo ambientale. Questa traiettoria è stata plasmata da Il Tao della fisica?
Sì, la traiettoria della mia carriera è stata decisa in modo importante dal successo del libro. Durante il mezzo secolo passato ho viaggiato molto, tenendo conferenze a pubblici specialistici e non, nelle Americhe, in Europa e in Asia, per discutere le implicazioni della “nuova fisica” con uomini e donne di visioni ed esperienze diverse. Durante queste discussioni, molti mi hanno detto che un cambiamento simile nella visione del mondo — da una visione meccanicistica a una visione olistica ed ecologica — stava avvenendo anche nei loro campi di studio. Così queste discussioni mi hanno stimolato ad ampliare il mio punto di vista dalla fisica ad altri settori: biologia, medicina, psicologia, economia e così via. Negli anni ho sviluppato la sintesi di una nuova concezione della vita emersa in quei campi, una “visione sistemica” che è pienamente coerente con le idee discusse ne Il Tao della fisica.
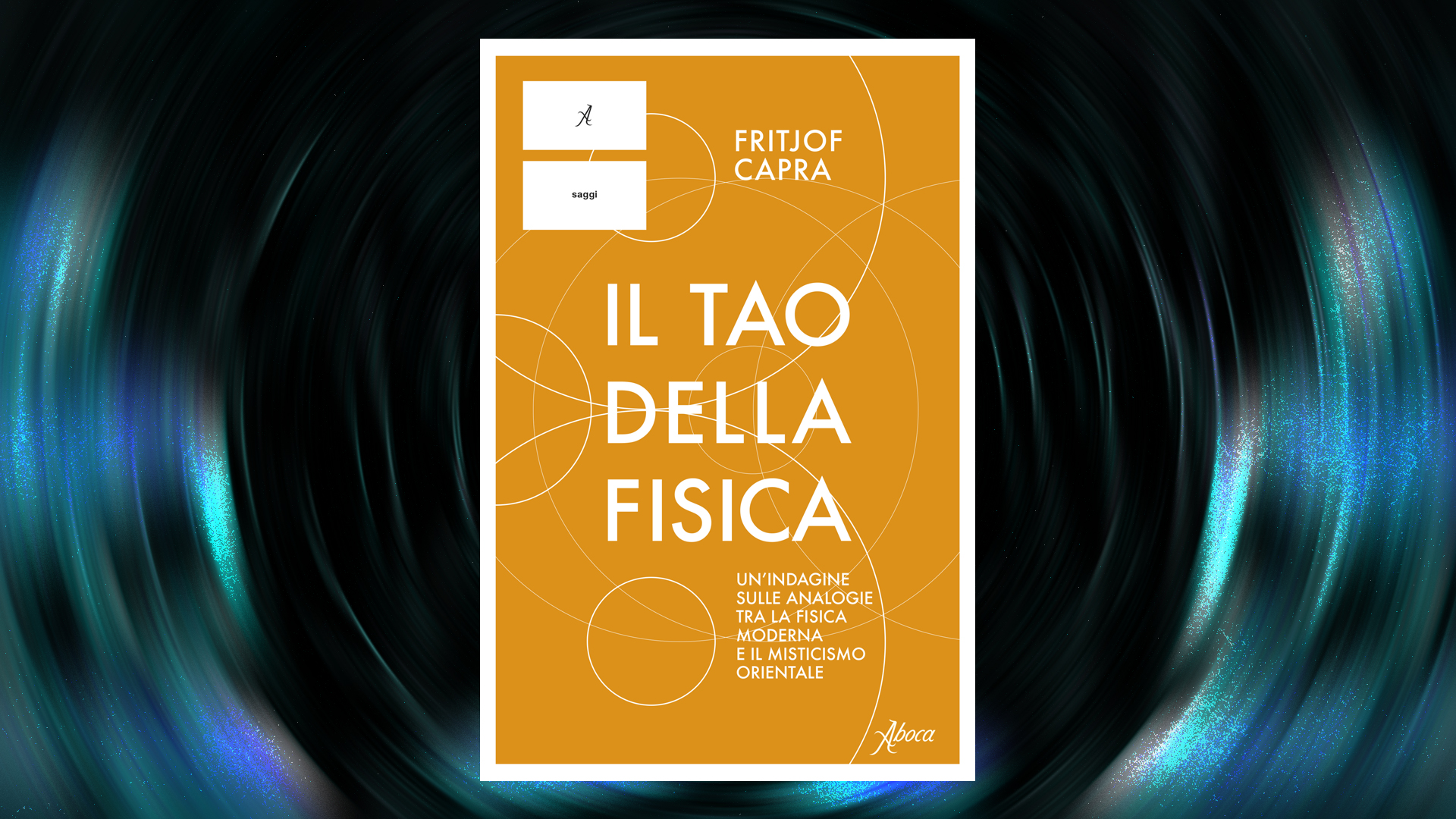
Al termine della discussione resta nell’aria una considerazione che già cinquant’anni fa fu espressa nelle ultime pagine del libro. Cioè: la vera domanda non è “se” le connessioni tra fisica moderna e misticismi orientali esistano davvero, ma che cosa comportino e che cosa possiamo imparare da questo confronto. Anche perché la scienza, di per sé, non ha bisogno della spiritualità, né la spiritualità ha bisogno della scienza, ma gli esseri umani sì, hanno bisogno di entrambe le concezioni dell’universo, di quella meccanicistica come di quella mistica. Secondo Capra, noi occidentali, nel perdere o nel rifiutare o nel non vedere la seconda, ci facciamo troppo Yang, troppo maschili, razionali e aggressivi, e finiamo per mancare lo Ying, l’emotività, l’armonia, la femminilità. E restiamo incastrati in una visione frammentata e statica dell’universo, lontana dal sentire armonioso, pacifico, ecologico che ci porterebbe a vivere in un felice equilibrio dinamico con il resto della natura. A leggerlo nel 2025, può sembrarci un pensiero di un ottimismo sfrenato, ma anche l’ottimismo a volte è necessario.
Questa intervista è stata realizzata in collaborazione con Aboca Edizioni.