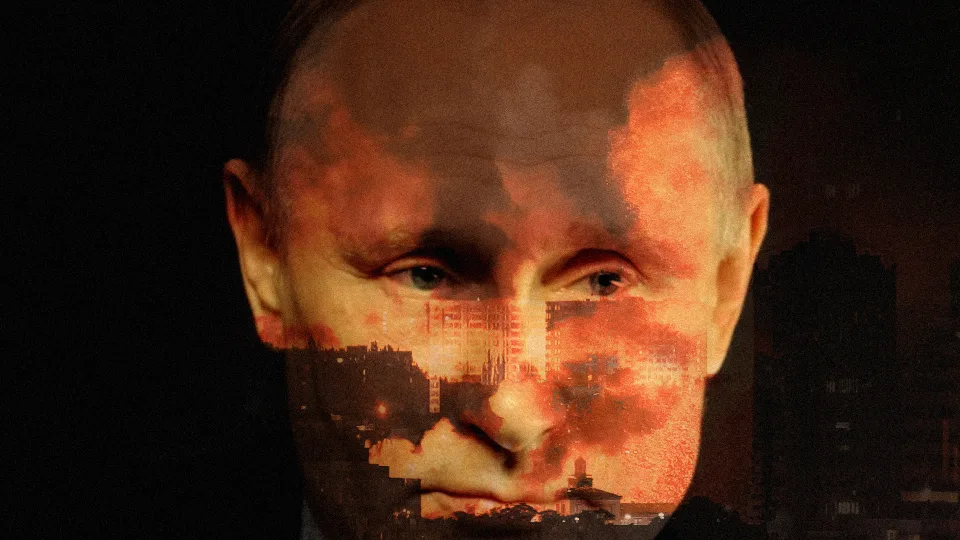Una conversazione con una delle figure più importanti della storia del femminismo italiano, che ha lottato per una vita intera affinché il movimento non si perdesse nell'astratto ma continuasse a parlare a tutte le donne disposte ad ascoltare.
Mentre intervisto Lea Melandri, nel suo appartamento foderato di libri in un sabato mattina luminoso, so di avere una grande fortuna: sedere di fronte a una delle femministe più importanti della storia del nostro Paese. Milanese acquisita, attivista, scrittrice e insegnante, Melandri è sempre stata impegnata sul fronte politico e, soprattutto, su quello pedagogico. Porta avanti da anni la sua passione per l’insegnamento attraverso diverse pratiche: lezioni, conferenze, gruppi di autocoscienza e scrittura. Dalla scuola dell’obbligo alla partecipazione al movimento non autoritario degli insegnanti, dove incontra lo psicoanalista Elvio Fachinelli con cui nel 1971 fonda la rivista «L’erba voglio», fino alla partecipazione all’iniziativa delle 150 ore volute dai sindacati per formare lavoratori e lavoratrici e ai laboratori di scrittura d’esperienza. Accanto a questo impegno costante, volto alla conoscenza e alla condivisione con l’altro, vi è sempre la scrittura: rubriche di posta del cuore, la fondazione e direzione di una rivista pionieristica come «Lapis. Percorsi della riflessione femminile», articoli su quotidiani e periodici come «Carnet», «Liberazione», «Gli Altri», «Internazionale» e «il manifesto», tanti libri, tra cui l’ultimo proprio sull’importanza della pedagogia.
Melandri con il suo calore e la sua generosità regala a questo incontro una piega intima inaspettata, al cui interno si intrecciano storia personale, memoria collettiva e le intricato arabesco disegnato dalle radici del femminismo italiano. Una sintesi appropriata (nel contenuto, ma anche nella forma) di quella stagione segnata da un fermento politico e culturale che, a partire dalla fine degli anni ‘60, iniziò a disseminare e raccogliere nel nostro paese il pensiero della liberazione. Un pensiero che si radicava non soltanto nella lotta per il superamento di condizioni oggettive di subalternità – pubblica e legislativa – ma che propose con forza anche la radicale trasformazione dei soggetti che ne erano vittime, provando a sciogliere, con nuove riflessioni e strumenti, le catene visibili e invisibili che ancora oggi non cessano di segnare la vita delle donne.
Com’è iniziato il tuo rapporto con il femminismo?
“Con una fuga. Una mattina ho preso un treno e sono arrivata a Milano. Dovevo andare a scuola come tutte le mattine – all’epoca insegnavo già – ma quel giorno è stato come se mi fossi risvegliata. Hai presente quelle fasi della vita in cui sei come irretita? Incapace di intendere e di volere? Ecco io lo sono stata a lungo, per varie ragioni, ma quella mattina sono uscita di casa e ho preso un treno. Sono venuta a Milano, che per me ha rappresentato una rinascita, un luogo difficile ma di speranza, e da lì è iniziato tutto”.
Lea viene da una famiglia contadina dalle campagne dell’Emilia-Romagna. Nelle ore che passiamo insieme mi racconta tantissime cose, partendo dal luogo difficile da cui proviene e dalla sua formazione. Prima di tutto, del miracolo del quale si sente rivestita: l’accettazione da parte dei genitori di una figlia femmina, dell’amore e della stima che le hanno consentito di studiare. Dalle medie al liceo classico sino all’università, la Normale di Pisa – che abbandona a causa dello “studio ottusamente specialistico”, che le porta pianto e mal di testa – poi l’Università di Bologna, dove si laurea in Lettere e Filosofia.
Incorniciati sulle mensole, attorno a noi, i volti sorridenti dei suoi genitori, un suo ritratto da giovane dove sfoggia una folta chioma di capelli ricci e rossi e sempre gli stessi occhi che mi stanno guardando in questo momento, lucidi e vispi. Una fotografia di Rossana Rossanda, grande amica e collega di battaglie. E poi alcune immagini della cascina dove è cresciuta, in cui non esisteva il pavimento e i piedi poggiavano sulla terra battuta.
Mi chiede di interromperla con altre domande, altrimenti rischia di non fermarsi più. In effetti durante le ore che passiamo insieme me ne accorgo: Melandri è un fiume, è attraversata da un’energia vitale impetuosa.
Forse mi sbaglio, ma tu sei una delle poche femministe italiane che mi sembra criticare l’operato della propria generazione. Ti va di parlarmene?
“Sì, è vero. Ma non sono critica su tutto. Riconosco e ho sperimentato, coltivando attivamente, le cose preziosissime che il femminismo di quegli anni ha portato alla luce…”
Melandri fa riferimento alle istanze politiche raccolte dal movimento, che in quel periodo guardava ai radicali americani, alla battaglia per i diritti civili e alla tradizione marxista, ma anche ai nuovi strumenti di riflessione messi in campo dalle scienze umane, come la psicologia e l’antropologia. Una lotta su due fronti. Da un lato la richiesta pubblica di leggi a tutela delle donne e, dall’altro, la ricerca e la creazione di spazi di incontro nuovi, comunitari, dialettici e privi di gerarchie (collettivi, gruppi di autocoscienza e di scrittura), in cui poter riflettere liberamente sull’oppressione e sulla dipendenza fisica ed emotiva esercitata dal patriarcato.
“Per capire meglio i miei anni”, prosegue, “c’è il libro Dal movimento femminista al femminismo diffuso delle sociologhe Anna Rita Calabrò e Laura Grasso, che racconta bene il mondo in cui ho vissuto: le pratiche, i gruppi, l’aiuto reciproco che sono emersi tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta. Le mie domande però, già allora erano: le cose che abbiamo scoperto come l’importanza dei racconti intorno al corpo e alla sessualità, delle violenze che si nascondono nel nostro quotidiano, dove andranno a finire nel momento in cui entreranno nel mondo istituzionale? Quando saranno nel mondo dei saperi scientifici, dell’università, che cosa succederà?
Il mio timore era che si perdesse la pratica dell’ascolto, dell’autocoscienza, il lato più radicale inventato dal femminismo. E in gran parte questo è successo. Perciò sono critica nei confronti di quello che definisco ‘accademismo’”.
Spiegami meglio…
“Nella storia del femminismo italiano c’è una data spartiacque, ed è quella del 1987. L’anno in cui esce Non credere di avere dei diritti della Libreria delle donne. È un testo centrale per l’epoca, che affronta la storia del movimento a Milano tra il 1966 e il 1986. È un libro corale, che si propone di unire teoria e pratica femminista, creando una genealogia e ripercorrendo i principi e le attività su cui si fonda il femminismo italiano. Ma a mio parere si rivela incompleto, perché sposta completamente il baricentro sulla parte legislativa, riducendo la carica politica delle storie personali e dei loro racconti, che hanno davvero messo in crisi la società dell’epoca. Leggendo questo libro sembra che le donne si siano dedicate unicamente alla difesa dei diritti, all’aborto, al disegnare un nuovo concetto di famiglia. Ma non c’è stato solo questo. In quegli anni i gruppi di autocoscienza hanno scoperchiato qualcosa di fondamentale: il corpo e il suo ruolo all’interno del rapporto tra i sessi.
Riflettere a partire dal corpo ha voluto dire per noi capire che la cancellazione più violenta che le donne hanno subito nel corso della storia è quella che si gioca su due piani: sessualità e maternità. E Rossana Rossanda lo aveva capito bene. La sessualità in quanto ricerca esclusiva del piacere dell’altro (maschile), e la maternità come mero obbligo riproduttivo. In questo senso le donne non sono mai state considerate persone, individui, ma soltanto un genere. La radicalità delle scoperte degli anni Settanta risiede in queste riflessioni, che ci hanno portate a comprendere quanto le donne abbiano fatto propria per forza di cose la visione maschile del mondo. E quanto il dominio maschile sia stato interiorizzato. Per questa ragione parlare solo di teoria ha significato in fondo ridurre al piano simbolico e fermare, almeno in parte, quella riflessione interpersonale, a più voci, basata sulla vita reale, che cercava di sviscerare il rapporto tra madre-figlia, che era centrale da indagare la madre come figura originaria, la madre come territorio primigenio della violenza patriarcale, ma anche come modello di riferimento da cui partire, emanciparsi e verso il quale tornare. La madre come modello e come flagello nel disegno della propria individualità e nelle relazioni d’affetto e d’amore”.
È lì che è avvenuta una separazione nel femminismo italiano?
“Sì”, in qualche modo è quello che è avvenuto. Fino alla fine degli anni Settanta siamo state capaci di restare unite, l’una al fianco dell’altra nonostante le differenze di vedute. C’erano sempre stati dei punti di scontro, ma non ci eravamo mai escluse a vicenda perché avevamo capito quanto fosse importante essere un fronte comune e…sapevamo ascoltarci! Poi, negli anni Ottanta, le cose sono cambiate. Iniziavano a uscire i primi documenti “di lavoro” (testi comunitari, redatti a più mani) della Libreria delle donne, che per me rappresentavano più una rivalsa teorica che una vera liberazione dai modelli patriarcali interiorizzati. Una rivalsa che anziché spostarsi procedeva in analogia con il piano simbolico maschile. Questo voler ristabilire una genealogia tutta al femminile, dal mio punto di vista, ha alimentato la separazione tra corpo e pensiero, tra natura e cultura, cioè quella dicotomia che il dominio maschile non ha fatto altro che perpetuare per secoli”.
Fermiamoci qui. Ai miei occhi il tuo operato dentro e fuori dal movimento sembra distinguersi proprio per l’unione costante tra teoria e pratica. Puoi raccontarmi come hai fatto a non restare “intrappolata” dentro il simbolico?
“Intanto, sono andata in analisi. E questo ha smosso dentro di me moltissime cose, aprendo uno spazio alla memoria e alla comprensione di quello che resta incastrato all’interno dei nostri ricordi. Poi ho sempre insegnato. A scuola, ma anche facendo tanti laboratori di scrittura. Un esempio che mi ha cambiato la vita è stata l’esperienza delle 150 ore di Affori, raccontata nel film di Adriana Monti Scuola senza fine.
Grazie alla legge del 1974 che concedeva un tempo per la formazione ad alcune categorie di lavoratori, nel 1976 ho avuto l’opportunità insieme ad altre insegnanti di votare il mio impegno femminista in maniera concreta a insegnare a un gruppo di casalinghe di Affori. È stata un’esperienza incredibile, in cui si fondevano istruzione e incontro, spingendo queste donne meravigliose a trovare non solo un tempo, ma anche uno spazio fisico in cui esprimersi. Dove esercitare una scrittura vicino alla vita”.
Mentre parla di queste donne Lea Melandri si anima sempre di più e il suo volto si trasforma attraverso il ricordo. Gli occhi si accendono e la pelle, su cui si era posata la fatica quando raccontava degli scontri interni al movimento, si distende. Adesso c’è soltanto l’urgenza più preziosa per un insegnante, quella di trasmettere all’interlocutore la magia e la potenza di una cosa che non conosce.
E in questo spazio cosa è accaduto?
“È accaduto che delle donne che erano sempre state soltanto mogli e madri si sono rivelate filosofe, pensatrici, scrittrici. E si sono meravigliate nello scoprire che nella loro condizione di vita, fatta di immobilità e ripetizione, avevano in realtà pensato moltissimo. Quello che ne è uscito sono stati dei testi in cui la pratica si annida dentro la vita. Dove il personale diventava il soggetto, mostrava ciò che rischiava altrimenti di rimanere oscuro: la storia del rapporto tra i sessi, delle passioni del corpo. La vita personale di queste donne – di tutte le donne – è l’archivio di qualcosa che non è mai stato scritto. Una storia che dobbiamo ancora restituire e che ha una lingua comune, che a lungo è stata silenziata: una lingua aderente alle cose”.
Cosa intendi con “lingua aderente alle cose”?
“È una lingua solo in apparenza semplice, che abbiamo sondato con i gruppi di autocoscienza, come quello di cui ho fatto parte, dedicati a sessualità e simbolico. Il mio interrogativo, senza volerlo, era già opposto rispetto a quello della Libreria delle donne, che ha avuto il merito e l’onere di riprendere e veicolare le teorie del femminismo francese e in particolare di Luce Irigaray e del suo testo cardine Speculum, l’altra donna. In questo pensiero la ‘differenza sessuale’, il principio cardine di discriminazione tra un sesso dominante e uno dominato, viene ribaltato. Cercando di svicolare la logica binaria insita nei rapporti uomo/donna, attraverso la teoria e una lingua a volte forzatamente filosofica, si propone la donna non più come oggetto del pensiero e del desiderio ma come soggetto. Tuttavia questa ricostruzione si articola in una genealogia composta esclusivamente da figure femminili, una linea che sembra costruita fuori dalla complessità della storia delle relazioni sociali, e cade, spesso, in una rappresentazione simbolica che riproduce all’inverso le reti di potere ‘naturali’ e immodificabili tramandati dalla cultura e dal linguaggio dominante.
Nei gruppi di autocoscienza di cui ho fatto parte, invece, a prescindere dai costrutti teorici, noi donne ci chiedevamo che cosa fosse davvero la vita normale, che vivevamo tutti i giorni e quanto questa incideva sulla nostra lingua. Ci chiedevamo come parlavamo, ma anche in che forma riuscivamo a scrivere i nostri libri, i nostri documenti. Come e cosa insegnavamo. Volevamo sconvolgere i saperi disciplinari, la regola della ricerca accademica, universitaria. Sconvolgere il lessico, la lingua che ci viene ancora chiesto di osservare nei contesti istituzionali e sociali, una lingua oggettiva, impersonale. La “lingua aderente alle cose” è una lingua che emerge dalla memoria del corpo, libera di dire l’indicibile. Una lingua che il pensiero della differenza – che a un certo punto è diventato quello egemonico, l’unico pensiero femminista possibile – fa ancora fatica a parlare”.
Il punto dolente allora è ciò che il corpo nasconde e che da esso può emergere? Ciò che si cela al suo interno e che, invece, è rimasto taciuto? O c’è dell’altro?
“Nell’intervista che mi ha fatto Elvira Roncalli nel suo libro uscito lo scorso anno Il futuro aperto. Storia e prospettive del femminismo italiano (dove ci sono anche Luisa Muraro e Adriana Cavarero) è spiegato tutto. Io non sono d’accordo con questa strategia che si cela dietro il pensiero della differenza, e tantomeno con la “teoria dell’affidamento” pensata da alcune figure legate alla Libreria delle donne di Milano. Questa teoria in cui il femminile tenta di mettere in discussione concetti complessi come potere e fedeltà, ha concepito una dinamica relazionale secondo una modalità che a mio parere può risultare molto pericolosa: una donna più fragile si affida a una donna più forte, una “maestra” alla quale riconosce un’autorità superiore. A me questa è sempre sembrata una forma di sottomissione spontanea che, al posto di spingerci a riflettere sulle complessità del legame originario di madre-figlia, ha finito per edulcorare la patologia insita nei legami di dipendenza emotiva.
Il tema, insomma, è sempre l’amore originario. L’ho visto in tutti questi anni di laboratori e di scrittura. Tutte le donne parlano e scrivono sempre delle loro madri. E che cosa significa questo? Questo significa parlare dell’amore, che è il centro della relazione tra i sessi”.
“Ci chiedevamo come parlavamo, ma anche in che forma riuscivamo a scrivere i nostri libri, i nostri documenti. Come e cosa insegnavamo. Volevamo sconvolgere i saperi disciplinari”.
Ne avete scritto tanto nella rivista di cui sei stata direttrice «Lapis. Percorsi della riflessione femminile».
“Sì, ecco questo è un buon esempio, una realtà che sin dalla fine del 1987 ha visto una redazione di tante donne ragionare su temi importanti come il corpo, la politica, lo spazio sociale e il potere, che ha tradotto e portato in Italia pensatrici ora all’ordine del giorno, come bell hooks o artiste importanti come Louise Bourgeois e Sophie Calle.
È stata una pubblicazione pionieristica, ma che per qualche motivo è rimasta fuori dal discorso pubblico femminista, pur continuando a viaggiare in maniera sotterranea…”
Quanto conta all’interno di questa storia l’estrazione sociale, ancora prima dell’appartenenza politica?
“Ovviamente le origini contano. Per lo meno per me, che vengo da una famiglia umile. Mi sono ritrovata in un femminismo che era borghese… non solo borghese, ma di certo molto borghese. Sai, oggi si parla di intersezionalità per dire che portiamo dentro appartenenze diverse. Elencarle oggettivamente può essere utile, ma il punto è guardarsi dentro, dentro la propria soggettività, e imparare a vedere che tutte queste diversità non sono davvero in armonia e cercare di capire come affrontarle.
Per me al centro di tutto c’era il tema sessuale, non tanto quello di classe, ma evidentemente quello era un sottotesto. Ora classe, sesso, etnia, sono allo scoperto, ma allora non lo erano. Certo si parlava di marxismo, di sfruttamento economico, ma noi stavamo scoprendo lo sfruttamento dei corpi, della maternità e su questo per un po’ siamo state unite.”
E poi è arrivato l’‘accademismo’? Una sorta di rielaborazione dei temi che avevate incontrato da parte di chi è entrata poi nel mondo universitario?
“Sì. In un certo senso è arrivato con il convegno di Modena del 1987, La ricerca delle donne e gli studi femministi in Italia, al quale io ero stata invitata ma ho scelto di non andare, perché avevo un presentimento: da lì sarebbe fuoriuscita un’élite intellettuale. Alcune di noi in quel frangente lo hanno fatto notare e hanno detto ad alta voce che ci sarebbe stato bisogno di una sorta di ‘pendolarismo’ tra esterno e interno. Fra il mondo del sapere e il mondo della vita. Ecco io di pendolarismo non ne ho visto. Pochissime hanno pendolato!”
E tu? Tu pendoli?
“Io provo a farlo. È quello che ho fatto con la Libera Università delle Donne. Restare in un territorio di confine, tra pratica e teoria, portando avanti dialoghi, incontri, il cui fine ultimo è sempre stato provare a comunicare con l’altro. Condividere. Non è facile. E poi è un po’ il mio carattere. Mi piace parlare con i morti, con gli assenti, con chi non è d’accordo con me. Sai, ho questa brutta abitudine di leggere anche i libri delle persone con le quali non sono d’accordo…”
L’impressione che ho mentre continuiamo a parlare è che Lea sia profondamente centrata, e che sia stato in qualche modo l’insegnamento, una pedagogia consapevole in cui ha messo in gioco se stessa in prima persona, a consentirle la libertà di questo moto oscillante. Un moto aperto all’altro, in cui non si ha paura di sporcarsi le mani, di andare a fondo, di interrogarsi sulla complessità dei rapporti umani a tutti i livelli.
È il momento per chiederle del suo libro che mi ha colpito di più, uscito nel 1988, che nel 2025 sarà ripubblicato in una nuova edizione da Bollati Boringhieri: Come nasce il sogno d’amore. Un libro che mi aveva stravolta non solo per il suo contenuto, ma anche per la forma, e che ho ripreso in mano in un momento in cui la mia vita ne riecheggiava i temi. Un libro in cui la rilettura critica di alcuni testi di Sibilla Aleramo si fonde con la vita di Melandri, con le teorie di Freud, cercando di sondare le origini dell’idea che abbiamo dell’amore e il suo rapporto intricato con il bisogno e, di conseguenza, con la violenza.
“Quel testo è in parte il frutto della fine di un amore. Infatti, tutta la prima parte, scritta in frammenti, s’intitola I racconti del gelo. Era la prima volta che riuscivo a scrivere così, ed è stato in quello spazio di dolore e di libertà che ho riflettuto su quello che io chiamo ‘il sogno d’amore’.
Io vengo da una famiglia in cui sono stata fortemente amata, ma in cui la tenerezza non c’era. Quello che ho sentito e respirato nell’infanzia non si può cancellare e quindi, in maniera naturale, come tutte le donne alla fine, ho iniziato a fantasticare. Ho sempre avuto libertà e potenza nel pensiero ma, allo stesso tempo, ho ragionato sul peso che mi portavo dietro: un grande bisogno d’amore. Gli ho dato un nome e ho provato ad affrontarlo. A capire perché le donne si tengono sempre tutto, qualsiasi cosa, con l’unica costante speranza di essere amate… eccolo il sogno d’amore. È un bisogno atavico. Che proviene dal rapporto con la madre. Anche con il padre, certo, ma le madri non hanno trasmesso le leggi dei padri? Non è solo quello che ti viene detto, in quanto donna, ma quello che vedi, quello che assorbi, quello che vivi. Pensaci. Il primo giocattolo che danno in mano a una bambina è un bambolotto. Un altro essere umano, e il messaggio è chiaro: sei tu che devi dare l’amore.
Ripenso a un brano de I racconti del gelo, che mi ha stordita:
“Essere tutti e nessuno è l’umanità delle donne e la loro miseria: la corsa disperata per raggiungere nell’altro qualcosa che ti appartiene e non è tuo”.
L’onnipotenza è un attributo di dio, ma dio l’hanno inventato gli uomini per sentirsi protetti e per poter rinascere ogni volta dalla sua morte.
L’onnipotenza è ciò che gli uomini continuano ad attribuire alle donne, perché non cessino mai di essere madri e perché la nascita del potere maschile abbia una legittima difesa”.
Il tuo discorso mi fa venire in mente una cosa. Sto leggendo un libro bellissimo sul mito di Pandora e sono rimasta basita. In alcune versioni del mito Pandora apre il vaso e da questo non escono tutti i mali del mondo, bensì tutte le cose belle. E all’inizio ho pensato, stupidamente, che fosse un racconto nuovo, in cui il femminile era finalmente altro. Poi, però, mi sono accorta che il punto è esattamente lo stesso. La donna come causa maggiore, di male o di bene. La donna che tiene fra le mani il vaso pieno. La donna che è il centro, il perno, la causa di tutte le cose negative o positive….
“Ma certo, il punto è proprio questo. È il femminile che cura sempre troppo o troppo poco, che seduce troppo o troppo poco. È qui che bisogna indagare… Il sogno d’amore è un libro ancora molto attuale, in cui parlo di letteratura, di una scrittrice incredibile, ma in cui prima di tutto parlo di un tabù. Per il femminismo in parte l’amore ancora lo è. E lo è proprio perché entrare lì dentro vuol dire entrare in un territorio difficilissimo. È lì che le acque si confondono. Dove hai l’illusione di perderti nell’altro. Lo ha detto in maniera chiara Bourdieu nelle ultime pagine de Il dominio maschile: “L’amore è un’eccezione, la sola, anche se di prima grandezza, alla legge del dominio maschile, una messa tra parentesi della violenza simbolica, o la forma suprema, perché la più sottile, la più invisibile, di tale violenza?” Questo è la domanda che dobbiamo farci… e questo lo dirà anche Sibilla Aleramo, in maniera esplicita: è un atto sacrilego pensare che la tua individualità si possa perdere nell’altro”.
E perché questo tema fatica a emergere?
“Perché altrimenti bisognerebbe trovare il coraggio di dire che l’amore è intriso di potere. Le donne invece vogliono salvarlo sempre, vogliono proteggerlo. Ma forse oggi iniziamo finalmente a vederne il pericolo. Ne ho scritto nella nuova edizione di Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà, in cui riprendo le parole di Elena e Gino Cecchettin a seguito dell’omicidio di Giulia, che hanno aperto una breccia nella riflessione pubblica sulla violenza. Mentre nel 2011, quando il libro venne pubblicato, in tanti mi dissero che avevo teorizzato ‘la miseria femminile’. La miseria femminile? Il sogno d’amore e la violenza che si cela al suo interno sono le architravi della nostra cultura! E il commento ricorrente, da anni, che porto di fronte a tutti i casi di femminicidio è sempre lo stesso: non si uccide per amore ma l’amore centra!”
Mi risuonano nella testa le parole del suo libro: “Dove l’incontro agisce sotto la spinta di un fatale ricongiungimento non può esservi libertà”.

Parlarmi un po’ della tua scrittura, il frammento, l’uso del corsivo, quella “mineralogia del pensiero” di cui ha scritto Alberto Asor Rosa.
“La scrittura per me è sempre stata importantissima. Sin da quando ero piccola ha rappresentato un modo per incontrare e confrontarmi con degli adulti diversi, lontani dalla mia famiglia. Su questo ho una bella storia. Al liceo, il primo tema che scrissi in IV ginnasio doveva avere come tema ‘novembre’. Io scrissi di tutt’altro, raccontai di quello che vivevo in casa, della mia famiglia, della violenza. L’insegnante me lo riconsegnò per ultima e mi disse: ‘è scritto benissimo ma è fuori tema’. Io piansi e mi disperai, non volevo più andare a scuola. Poi, la vita va anche così, arrivò una nuova insegnante e io decisi di tornare a scuola. Ma quell’etichetta mi è rimasta addosso. Il fuori tema resta piantato come una spina nella mia carne”.
Cos’è per te il fuori tema?
“Un sacco di cose: la condizione sociale, la sessualità, l’essere femmina. Le esperienze più universali dell’umano che di norma non entrano nelle lingue colte. Restano intraducibili. E qui c’è la radice della mia polemica. Se le lingue non cambiano? Se le lingue non riescono ad accogliere questi aspetti impresentabili della vita, la separazione ci sarà sempre”.
E la forma per tradurre il fuori tema qual è?
“Nel femminismo ho guardato al fuori tema attraverso le pratiche. Nella lingua sono riuscita a farlo molto dopo, e con grande difficoltà, nella saggistica. È stato un percorso, possibile solo attraverso un incontro illuminante, quello con la scrittura di bell hooks… A un certo punto ho letto questa sua frase: “io scrivevo teoria per consolare il dolore”. Ecco, io non potevo scrivere niente che non partisse da me e la teoria è stata a lungo un modo per imbrigliare un dolore. E ho iniziato ad avvicinarmi alla possibilità di esprimermi attraverso l’uso del frammento e del corsivo…”
In qualche modo senti di aver dovuto travestire il tuo personale con quello di qualcun altro? Mischiarli per riuscire a scrivere e pubblicare?
“Questo non lo so, di certo ho costruito una nuova lingua. In cui ho provato a lavorare sulla memoria del corpo, sull’infanzia e sui linguaggi sociali. È quello che faccio anche nei miei laboratori di ‘scrittura di esperienza’, in cui si lavora non solo su tematiche personali da indagare, ma anche sullo scoprire una lingua segreta. Per stimolarla faccio leggere alcuni frammenti dei miei libri ma anche stralci tratti da autori diversi, che per me hanno significato qualcosa, come Sibilla Aleramo, Alberto Asor Rosa, bell hooks, Agnese Seranis, Alice Rivaz…”
E tu? Tu come scrivi?
“Io parto da un tema. Trovo delle pagine di altri che mi interessano e inizio a trascriverle. Le chiamo ‘note di preparazione’. Sai, quando lo faccio, è come se pedinassi qualcuno. Mentre selezioni e trascrivi entri nelle pieghe, vedi quello che l’autore forse non ha visto di se stesso. Lo percorri, attraverso la trascrizione. Se ci pensi il frammento è un viaggio che fai dentro la scrittura dell’altro. Andando a collimare con lui, in una sorta di automatismo. Noi leggiamo e poi qualcosa ci colpisce, non sappiamo bene il come e il perché, ma la sottolineiamo. Ma nella trascrizione tu esci da te e poi ci torni dentro attraverso un altro. Il frammento ti permette di andare oltre l’uno, di capire che hai all’interno tante parti diverse, che si incontrano e scontrano con quelle degli altri”.
“Io parto da un tema. Trovo delle pagine di altri che mi interessano e inizio a trascriverle. Le chiamo ‘note di preparazione’. Sai, quando lo faccio, è come se pedinassi qualcuno. Mentre selezioni e trascrivi entri nelle pieghe, vedi quello che l’autore forse non ha visto di se stesso”,
Mi sembra di scorgere una critica all’autobiografia… o sbaglio?
“Eh un po’ sì, perché spesso è anche noiosa… Lì ci hanno fatto un business. Ma alla fine cosa ce ne frega delle nostre vite singole?! Io credo che quello che conta davvero sia il lavoro collettivo”.
E cosa ne pensi dei generi letterari che possono entrare in contatto con questo discorso, il diario, il memoir, l’autofiction, la nonfiction…
“Sono tutte cose molto diverse, prima di tutto perché la scrittura d’esperienza non è un genere. È un allenamento del pensiero. È un tentativo di scoprire un’altra lingua, la propria. È un interrogativo alla scrittura, per questo parla con tutti i generi, ma non è un genere. Vuole attraversare l’indicibile e trovare le parole per dirlo. È un lavoro di scavo, faticoso, in cui spesso non sai più cosa è tuo e cosa è dell’altro.”
Ti chiedo solo un’ultima cosa. Cosa ne pensi delle nuove generazioni femministe?
“Io mi ritrovo molto in Non una di meno. Hanno pratiche diverse dalle nostre, perché loro sono ‘azione e organizzazione’, mentre noi eravamo “introspezione”. Però loro hanno raccolto la radicalità degli anni Settanta. Per noi il tema principale era partire dal sé per modificare il mondo, dopo aver compreso che il sessismo è solo la base di tutte le forme di violenza. E Non una di meno questo lo vede, lo ha intercettato. La rete di certo aiuta. Loro lavorano in senso orizzontale, non hanno più bisogno di una centralità. E durano! Sono tanti anni ormai: questo non è scontato!
Poi certo ci sono tante giovani che scrivono di femminismo… Io amo i giovani ma mi sono accorta, spesso, che non gli piace la storia. Si documentano troppo poco! Non hanno molto interesse a ricostruire le origini delle cose. E soprattutto non hanno quella spinta alla soggettività, a scavarsi dentro, che ci aveva unite nel profondo: noi volevamo conoscere noi stesse. Sapevamo, ed è stata lì la fatica, che dovevamo fare un lavoro enorme sulla nostra mancanza di libertà. Un lavoro che si giocava dentro di noi. Perché il patriarcato le donne lo hanno talmente tanto vissuto e interiorizzato, che immaginano il potere anche dove non c’è. Parlavamo prima, per esempio, dei rapporti tra donne. Per me la socialità tra donne va ancora costruita con fatica e con tenacia, perché siamo le prime a proiettare l’una sull’altra delle cose che non ci riguardano. Il dominio maschile non è tra noi. Il dominio maschile è ancora dentro di noi”.