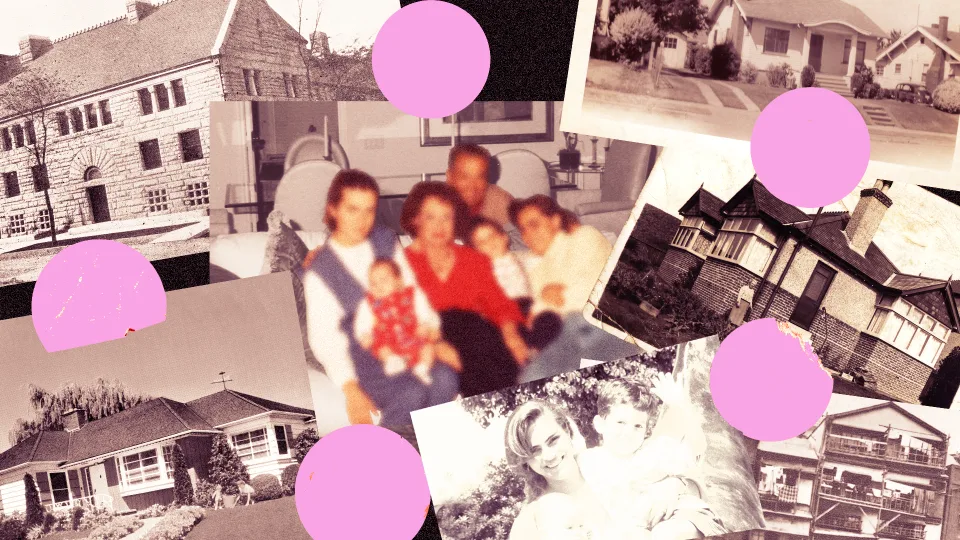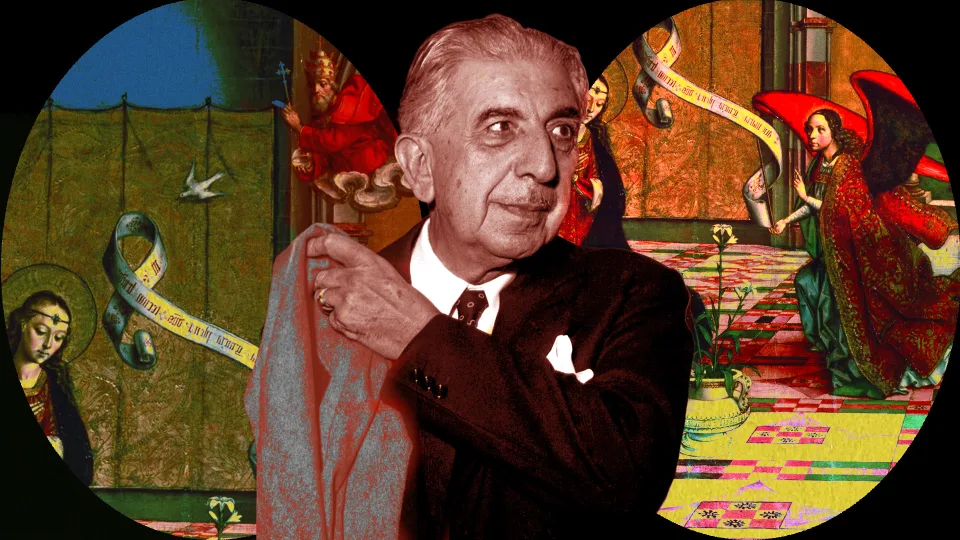All'indomani del rapporto Ecri che accusa l'Italia e le sue forze dell'ordine di rinfocolare e sostenere il razzismo istituzionale, una riflessione sulle origini del razzismo nel nostro paese, che spesso nasconde una paura più profonda di quella per lo straniero, e che andrebbe affrontata prima che sia troppo tardi.
L’Ecri, la Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, ha segnalato nel suo ultimo rapporto “con grande preoccupazione” che negli ultimi tempi il discorso pubblico italiano è diventato “sempre più xenofobo”, che la retorica di molte personalità del nostro mondo politico ha assunto toni “fortemente divisivi e antagonistici” contro migranti, rifugiati, richiedenti asilo. Sotto accusa anche le forze di polizia, le quali farebbero “profilazione razziale durante le attività di controllo e sorveglianza, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana”.
È un giudizio molto duro. Stiamo diventando un popolo di razzisti? Sono razzisti alcuni nostri rappresentanti e chi dovrebbe tutelare l’ordine pubblico? O non lo è nessuno e l’Ecri vaneggia?
Lo scorso settembre, a Roma, nei giardini di piazza Vittorio, questa rivista ha organizzato, insieme con Slow Food, la seconda edizione di MULTI, un festival dedicato alla multiculturalità. Ci hanno partecipato i rappresentanti di tante comunità di stranieri che risiedono a Roma. Nel corso del festival ci sono stati seminari, lezioni, presentazioni di libri, degustazioni. Si è parlato di migrazioni, guerre, crisi delle democrazie. Sono intervenuti scrittori, registi, giornalisti, religiosi, c’erano i rappresentanti di associazioni, ong, comitati di quartiere, e poi migranti, rifugiati, richiedenti asilo. I saperi e le esperienze di diverse culture si sono mescolati in modo pacifico e addirittura felice, persino in tempi di orrore quotidiano come quelli che viviamo.
Tra i molti ospiti illustri c’è stato Matteo Garrone. Ha parlato di Io Capitano, il suo ultimo film, in cui il regista ha raccontato le attuali migrazioni – dall’Africa in Europa, da Dakar alla Sicilia. C’è stata Paola Caridi, che ha raccontato ciò che accade oggi in Medio Oriente, in particolare in Palestina (e quel che è successo nel corso del Novecento) prendendo come riferimento e griglia interpretativa gli alberi, le piante. (Lei parlava, ed eravamo tra gli alberi di Roma, “l’unica città mediorientale che non possiede un quartiere europeo”, la definiva Ennio Flaiano).
“Come è possibile che ci stiamo facendo il callo? Cosa ci anestetizza? Perché reagiamo così poco o non reagiamo? È il clima che respiriamo? L’Italia è un paese razzista? Il problema nasce dai vertici? Dalla base?”.
Durante le giornate del festival sembrava di stare in un paese diverso da quello descritto nel rapporto dell’Ecri. Se tuttavia vivere una piccola parentesi di concordia è sufficiente a generare una vertigine emotiva come quella che ho provato, e non ho provato solo io, è solo perché all’esterno, fuori dalla parentesi, infuria la tempesta.
Mentre scrivo, il nostro paese cerca di trasferire in Albania dei corpi umani trattati come bestie. “Ho guardato con tutta l’attenzione di cui sono capace le riprese filmate del penitenziario italiano in Albania”, ha scritto di recente Adriano Sofri, anche lui protagonista a MULTI, “ho guardato e riguardato come chi immagini di trovarcisi, a un titolo qualunque. Può succedere a quasi tutti, infatti. La vita può aiutare a compiere l’azione così tipicamente umana, di mettersi nei panni altrui. Quella che spinge a guardare e riguardare la scena, compreso, ieri, l’arrivo del primo sparuto drappello di castigati, con un passo di sbarcati ancora ubriachi di mare, e a interrogarsi su quale sarà lo spazio prescelto dal primo di loro e dei loro imminenti successori per togliersi la vita”.
Come è possibile che ci stiamo facendo il callo? Cosa ci anestetizza? Perché reagiamo così poco o non reagiamo? È il clima che respiriamo? L’Italia è un paese razzista? Il problema nasce dai vertici? Dalla base?
Penso a com’era piazza Vittorio nei giorni del festival, sono tentato di rispondere di no. Penso alle persone che incontro girando per il paese, anche in questo caso vorrei rispondere di no. Ma cosa si intende davvero per razzismo? Come funziona il razzismo oggi? Come nasce e si alimenta? Forse è questo che dovremmo chiederci. Quando posso, discuto con interesse (e molta passione) con chi sostiene i partiti che sui problemi legati alla gestione dei flussi migratori hanno costruito parte del loro consenso (una cosa è capire come affrontare i flussi migratori; altro è immergere questa necessità in un clima capace di trasformare un disperato in un nemico, un sofferente in un pericolo pubblico).
È difficile che alla fine della discussione io creda davvero di essermi imbattuto in un razzista convinto, in un fanatico, in un teorico del suprematismo. Ascolto le risposte di questi miei interlocutori, osservo i loro sorrisi nella cui piegatura c’è qualcosa che appartiene anche a me. Cercano spesso di convincermi che siamo il paese di Alberto Sordi, non quello delle leggi razziali, che esiste un’italianità strumentale, a cui partecipiamo tutti in modo diverso, a seconda delle stagioni e della convenienza (è una strumentalità che può giocare in modo retorico con i migranti per far ottenere a chi la esercita un vantaggio temporaneo), e che questa italianità strumentale, o se vogliamo d’occasione, è diversa dall’italianità profonda – la quale ci accomunerebbe tutti in modo identico –, che invece quei migranti li rispetta, li considera fratelli, anche quando non desidera che entrino in Italia, e anche quando finge di empatizzare con loro per mantenere un privilegio.
Questo sentimento profondo ci terrebbe uniti come popolo (“siamo tutti italiani”) e io non dovrei prendere alla lettera le sparate di certi leader politici e dei loro sottoposti, così come non dovrei confidare nelle parole di certe anime belle.
“Se quell’italianità di superficie si traduce in leggi o comportamenti che ledono la dignità umana, che creano sofferenza, che minano l’integrità psicofisica delle persone verso cui si applicano, cosa può fare l’italianità profonda per impedirlo?”.
A me però questo non sembra un innocuo gioco delle parti. Se quell’italianità di superficie si traduce in leggi o comportamenti che ledono la dignità umana, che creano sofferenza, che minano l’integrità psicofisica delle persone verso cui si applicano, cosa può fare l’italianità profonda per impedirlo?
Lo domando ai miei interlocutori, cerco di arrivare all’osso della questione. Porto numeri e statistiche per provare a dimostrare che la gestione dei flussi migratori è un problema reale, non c’è dubbio, e un problema che i paesi europei stanno affrontando male, ma non si può parlare di invasione, non esiste un progetto di sostituzione etnica, non c’è il rischio che i migranti rubino il lavoro agli italiani, molti di loro contribuiscono anzi alla tenuta di un sistema pensionistico dei cui vantaggi spesso non godranno (i migranti che lavorano regolarmente qualche anno in Italia e poi vanno altrove, pagano i contributi di una pensione che non riscuoteranno, tutto a vantaggio degli attuali pensionati, quasi sempre italiani).
A questo punto della discussione le nostre strade si dividono. La piegatura sul sorriso non è più la stessa. Ci salutiamo con freddezza o con imbarazzata cordialità, a seconda delle spinte emotive di cui si è caricata la discussione.
Non c’è un rischio di invasione. Non c’è furto di lavoro. Non c’è sostituzione etnica. Lo dicono i numeri, la ragione. Come possono certi miei concittadini non saperlo? Ma in realtà lo sanno. Ciò che li agita nel profondo è altro.
È a questo punto che ripenso a un episodio a cui, proprio a piazza Vittorio, mi è capitato di assistere qualche tempo fa. A dire il vero ci penso di continuo.
È successo che una rivista di urbanistica mi ha fatto un’intervista. Volevano che parlassi di Roma, dei quartieri e dei rioni che frequento e in cui ho vissuto. Nel corso dell’intervista ho parlato dell’Esquilino, di Tor Pignattara, di Centocelle, del Pigneto, anche di Re di Roma, una zona molto tranquilla dove, appena arrivato in città, quando avevo ventiquattro anni, ebbi la fortuna di trovare un seminterrato a un canone d’affitto inaspettatamente contenuto. Erano altri tempi.
Qualche giorno dopo, i referenti della rivista mi hanno chiesto di potermi fotografare a corredo del pezzo tra le strade dell’Esquilino, non lontano da dove abito.
Ho così incontrato la piccola troupe, due fotografi, un uomo e una donna sui cinquant’anni, accompagnati da un assistente, un giovane uomo sui trenta. Eravamo poco distanti dalla Porta Magica. Mi hanno scattato qualche foto. Ci siamo quindi diretti alla fermata della metropolitana. Secondo uno dei due fotografi era un posto ideale per un altro po’ di scatti. Dalla bocca della “Metro Vittorio” passa l’umanità più varia, gente di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le classi sociali. Ho obiettato che avremmo rischiato di ostruire un po’ il passaggio e, conoscendo gli abitanti della mia città, questo ci avrebbe potuto procurare qualche noia.
I fotografi hanno scrollato le spalle. Non erano di Roma. “Ma no, dai, scattiamo lo stesso”, hanno detto, “cosa vuoi che succeda?”
La piccola troupe si è posizionata davanti alla fermata della metro, rendendo per un quarto d’ora ai passeggeri che entravano e uscivano da lì il passaggio un poco meno agevole.
La maggior parte dei passeggeri, salendo e scendendo le scale della metro, ci ha evitati con qualche mugugno. Qualcuno ha aggirato l’ostacolo senza dire niente. Qualcun altro ci ha insultati (un “li mortacci vostra” di prammatica, senza astio supplementare) o ci ha proprio presi di peso e spostati di qualche centimetro (senza violenza, un gesto risoluto), innanzitutto per comunicarci fisicamente il fastidio che stavamo arrecando, e poi per agevolare il passaggio.
Per questo tipo di passanti era chiaro che noi eravamo nel torto e loro avevano ragione a lamentarsi. Ero d’accordo con loro.
Solo che poi – saranno state una decina di persone nel giro di quel quarto d’ora – c’è stato anche qualcun altro che non ha protestato, non ci ha insultati, non ha tentato di spostarci, non ci ha aggirato. Queste persone, singolarmente, si sono invece fermate davanti alla troupe, davanti a me e ai fotografi, ci hanno chiesto a occhi bassi “scusa” per essersi trovati loro a intralciare la nostra attività, e infine ci hanno chiesto, con una gentilezza che rasentava la sottomissione, il permesso di passare. Queste persone erano tutte di pelle nera. Nessuna esclusa. Mi è sembrato incredibile. Ci chiedevano scusa anziché manifestare il proprio disappunto, e ci chiedevano scusa in un modo così umile perché evidentemente si sentivano in una posizione di subalternità, di debolezza, di pericolo costante.
Ma c’è un altro dettaglio, ugualmente importante. Mentre questa cosa succedeva, mentre sette o otto o dieci persone di pelle nera, ciascuno per proprio conto, ci chiedevano il permesso di passare, trasformando il loro diritto in un nostro inesistente privilegio, altre due persone, poco distanti, due signori italiani, di pelle bianca, due uomini sulla sessantina, male in arnese, con addosso dei vestiti che sembravano di seconda mano, in condizioni fisiche precarie, sghignazzavano osservando la scena. Ridevano delle persone di pelle nera che chiedevano il permesso di passare, li denigravano, si davano di gomito, facevano battute su di loro. Mimavano il gesto della scimmia. Cercavano anche la nostra complicità.
“Ripenso a un episodio a cui, proprio a piazza Vittorio, mi è capitato di assistere qualche tempo fa. A dire il vero ci penso di continuo”.
Ho provato vergogna per me stesso e per la situazione. Ho guardato meglio i due signori. Era palese la loro condizione di debolezza. Potevano essere disoccupati o sfrattati o anziani semiabbandonati. Guardandoli ridere mi è stato chiaro (l’ho capito con la forza delle sensazioni che portano a conclusioni indimostrabili ma poco equivocabili) che quei due non erano razzisti per come il razzismo si cerca di definire (e di inchiodare) in quanto teoria, postulato ideologico, o anche solo istinto di superiorità. I due signori sapevano benissimo (senza bisogno di leggere numeri o statistiche) che i migranti non gli rubavano il lavoro, non gli rubavano la pensione (al contrario, presumibilmente, gliela pagavano), non creavano a loro o ai loro figli alcun danno materiale. Non c’era pericolo di sostituzione etnica. E non c’era nessuna questione legata alla sicurezza. I due signori sghignazzanti, semplicemente – in una guerra tra poveri giocata ormai solo sulle emozioni, non sui vantaggi materiali e ancora meno sul dato di realtà – godevano per il fatto che le persone di pelle nera si sentivano a disagio o in pericolo, in un territorio (una fermata della metropolitana, un quartiere, un rione, una città, un intero paese) dove loro, i due italiani male in arnese, erano invece meno a disagio, meno in pericolo.
Pure con una pensione da fame, o senza pensione, o disoccupati, o bistrattati, o abbandonati, i due anziani esercitavano (o avevano la sensazione di farlo) su quel territorio un dominio residuale, che si traduceva nella maggior angoscia delle persone di pelle nera. Quella, per i due anziani di pelle bianca, era una consolazione. Era l’ultimo privilegio rimasto. Perché gli era anche chiaro, agli anziani di pelle bianca, che la loro situazione non sarebbe migliorata. La pensione non sarebbe aumentata, il lavoro non l’avrebbero ritrovato, la condizione di abbandono e debolezza (economica e sociale) in cui versavano non avrebbe avuto vie d’uscita.
Il paese li aveva traditi. Ma sapere che in quello stesso paese c’erano persone messe peggio di loro, umiliate, sottomesse, in pericolo, gli dava sollievo. Tanto più grande, quanto era tra gli ultimi sollievi a loro disposizione. È intorno a questo sentimento disperato che si coagula un razzismo invisibile, diffuso, in apparenza e forse davvero impersonale, a cui però l’italianità strumentale che ci farebbe tutti diversamente Alberto Sordi (ma ciò che comincia con La grande guerra finisce con Un borghese piccolo piccolo) dà poi una direzione ben precisa, gli conferisce un nome, un iban, una poltrona, si trasforma in slogan, narrazione, retorica, campagna elettorale (è qui che l’informe soddisfazione senza speranza dei penultimi può diventare la fortuna di qualche avventuriero; e il privilegio, in certi casi il sadismo, di qualche eletto), e si traduce per forza di cose in legge, in decreto, irrompendo “finalmente” sul piano di realtà, produce allora emarginazione, spoliazione di dignità, diventa la dannazione degli ultimi, corrode ogni giorno quell’italianità profonda di cui l’italianità strumentale continua a farsi scudo, fino a quando dello scudo non rimarrà più niente, e un’altra italianità, ben più cupa e violenta, risalendo dagli abissi, andrà a sostituirsi a quella. Allora la mutazione sarà completa. La trasformazione di un popolo divorato al proprio interno da se stesso: il vero stravolgimento di cui dovremmo avere paura è l’autosostituzione.