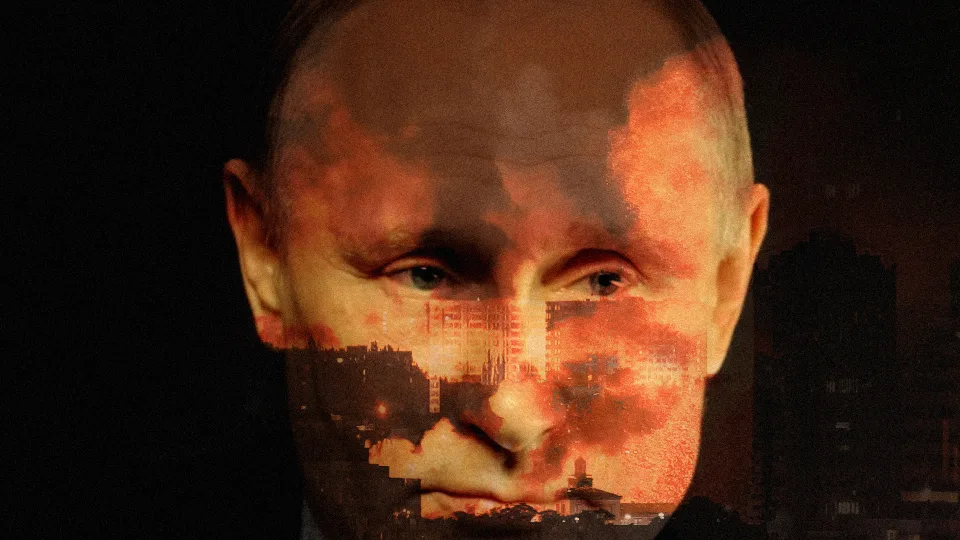"La mela e il serpente", il testo più noto della filosofa, critica e scrittrice è uscito la prima volta nel 1974. Eppure la sua riflessione sul linguaggio e i tabù del patriarcato ci è forse più che mai utile nell'analisi degli odierni femminicidi.
“Cosa è andato storto?” “Non è cambiato niente!” “Possibile siamo ancora a questo punto?”.
Sono solo alcune delle reazioni emerse nel tour di presentazioni di La mela e il serpente di Armanda Guiducci, bestseller del femminismo anni ’70 che abbiamo riportato di recente in libreria con nottetempo.
Fin dal primo incontro ho percepito un clima inedito rispetto a eventi di solito frequentati da chi per mestiere o per vocazione si occupa di questioni di genere: in sala e in libreria non c’erano solo militanti dell’epoca, esperte o operatori dell’editoria, ma anche ragazze e ragazzi della Gen Z che si avvicinavano per la prima volta ai testi del femminismo storico. Una volontà di confronto collettivo, trasversale alle generazioni, si intrecciava a un senso di prostrazione, quando ci si trovava a leggere e commentare insieme passaggi che sembravano scritti ieri, non nel 1974. A cinquant’anni dalla pubblicazione, era come se l’attualità (con i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula, avvenuti a distanza di poche ore, e relativi racconti mediatici distorti) ci sollecitasse a tornare su quelle pagine per riconoscere quanto la lotta per la liberazione sia ancora incompiuta, e vada rinnovata di continuo.
Perché La mela e il serpente parla ancora al presente? Ho provato a lasciarlo parlare per quello che è: un ‘libro-laboratorio’ che non smette di interpellarci.
Mitologie
“Non sono autobiografia, sono un campione d’esistenza al femminile. Ogni ragazza dell’Occidente percorre infatti fasi “obbligate” dello sviluppo fisico e psichico. Importante, questo modello imposto e comune. Rifletto sul destino della donna e mi domando: da dove proviene la forza prepotente che ci costringe a seguire quel modello? Chi ci impone di recitare, con la convinzione di prime attrici, una parte secondaria nell’esistenza sociale? Chi ci suggerisce di dire “io” a bassa voce? Risalgo ad Eva, la mela e il serpente, e discendo dentro me stessa. Frugo dietro le istituzioni sociali, dietro i tab. del sesso, nell’inconscio maschile. Ma frugo anche nel mio inconscio che pullula di immagini compiacenti, deformate, della Femminilità. E mi sforzo di toccare il fondo, di snidare quanto di ancora inconfessato giace nel ripostiglio della mia bell’anima tradizionale”.
Così il libro si presentava nella quarta dell’edizione Rizzoli, apparsa nella primavera del ’74 con un’invitante copertina progettata da John Alcorn (sostituita, nella nuova edizione, da un’altrettanto raffinata fotografia di Pepi Merisio, che mette l’accento proprio sul “seguire quel modello”). Il successo di pubblico è immediato.
Un anno più tardi, arrivato alla nona ristampa, era in corso di traduzione in vari paesi — un risultato inaspettato per Guiducci, fino ad allora figura appartata nella geografia dei femminismi. Non risultano sue corrispondenze con le principali attiviste dell’epoca; sporadica la presenza a manifestazioni e convegni dedicati; la pubblicistica non si limita alle riviste autogestite del movimento, mantenendo assidua anche la collaborazione con testate generaliste. A ben vedere, scelte del tutto naturali vista la sua biografia intellettuale. Classe 1923, Guiducci (il cognome da nubile era Giambrocono) appartiene a una generazione precedente rispetto ai principali nomi del femminismo della differenza. Napoletana d’origine ma cresciuta a Milano, si era laureata in filosofia con Antonio Banfi, formandosi nelle riviste del marxismo critico — sua è la direzione di “Ragionamenti” — e avviando una lunga attività come traduttrice, poeta ed esperta di antropologia.
Ma fin dalla scelta dell’argomento della tesi (sui personaggi di Dostoevskij), Armanda si era pensata prima di tutto come critica letteraria – di fatto, gran parte delle sue attività erano dedicate alla ridefinizione del canone e alla scoperta dei contemporanei. Tra i libri precedenti alla svolta femminista – i primi in cui mi è capitato di imbattermi – un posto di rilievo spetta a Il mito Pavese e Invito alla lettura di Pavese, apparsi rispettivamente nel 1967 e nel 1972, due profili in grado di resistere al tempo. L’attività critica di Guiducci non è però declinata solo in senso accademico (“era appassionata e coltissima”, ricorda oggi la sorella Jole, un ritratto confermato dai tanti interlocutori che hanno avuto la fortuna di conoscerla). Tra gli anni Cinquanta e i primi anni Settanta crea e disfa riviste, anima per anni il Circolo Turati di Milano, interviene più volte in radio, convinta che fare critica fosse una pratica declinabile in tante modalità – un modo di essere nel mondo, con gli altri.
“Alla struttura così composita — per questo parlavo di libro-laboratorio — corrisponde una radicalità di pensiero non poco originale rispetto ad altri femminismi italiani. L’io di Guiducci non si discioglie mai in un “noi”, ma accoglie altre soggettività senza annullarle”.
Queste anomalie entrano nel corpo di un testo all’incrocio tra autoanalisi e trattato d’antropologia, diviso in tre sezioni che raccontano le fasi “obbligate” dell’esperienza femminile: la scoperta delle mestruazioni; l’ingresso nel ruolo sociale di donna, con l’introiezione delle credenze patriarcali; e l’esperienza della maternità, vissuta come passaggio verso una possibile liberazione, uno scendere a patti col proprio corpo e, di conseguenza, con l’essere donna. A ogni fase corrisponde l’alternarsi di registri diversi: dalla ‘vita immaginaria’ narrata in prima persona a un filone d’inchiesta sull’oggi, fino a un terzo livello, attraversato da stralci saggistici dove si riflette su come i miti patriarcali associati al femminile siano stati interpretati nel tempo e nello spazio da diverse culture.
Alla struttura così composita — per questo parlavo di libro-laboratorio — corrisponde una radicalità di pensiero non poco originale rispetto ad altri femminismi italiani. L’io di Guiducci non si discioglie mai in un “noi”, ma accoglie altre soggettività senza annullarle; non c’è volontà di separazione, piuttosto il tentativo di interrogarsi su come trasferire la radicalità del fare femminismo in una dimensione collettiva. Guiducci non si fa sconti: sa di essere portatrice sana di patriarcato (non c’è da stupirsi, per una nata nel ‘23, nel notare una certa iniziale competizione nei confronti della controparte maschile: il mondo patriarcale in cui era cresciuta non aveva accolto quasi mai di buon grado le sue iniziative, e, pur avendo tutte le carte in regola per diventare una figura di primo piano, era restata a lungo nelle retrovie del campo culturale). Cerca di liberare sé stessa per liberare anche le altre, gli altri — uomini inclusi, visti come vittime speculari del sistema patriarcale. E questo non è che uno dei tanti tabù infranti dal libro.
Tabù
Una parola che in queste pagine ricorre di continuo, come mi è venuto da pensare durante l’anteprima della nuova edizione del Contemporanea Festival di Biella, Al cuore dei tabù. Il primo in ordine cronologico (dopo lo scoprirsi invase in partenza dalle mitologie patriarcali, stratificate e proprio per questo dure a morire: “questa non è una rivoluzione, è un’estirpazione”) sono le mestruazioni, con cui si aprono le primissime pagine, dalla grana al contempo organica e smerigliata — come se vedessimo la protagonista da un vetro —, che fa pensare all’Arte della gioia. Dopo la traumatica scoperta della narratrice allora undicenne il racconto da privato si fa plurale, riflettendo su come quelli fossero per tutte le ragazze della sua generazione “giorni di infermità sacra, di impossibilita clandestine, di timori occulti, giorni segretamente femminili”. Ma il tabù del corpo femminile mestruato si lega nell’immediato a uno di stampo specificamente linguistico:
Anche le altre ragazze in quei giorni dicevano: “Non posso”. Erano giorni di infermità sacre, di impossibilità clandestine, di timori occulti, giorni segretamente e assolutamente femminili. Esisteva un certo imbarazzo, tra noi ragazze, sul come nominarci l’evento. La parola franca, clinica, oggi invalsa veniva emarginata dall’ipocrisia borghese, da quel rimasuglio di vittoriano pudore che la guerra — ben più tragico bagno di sangue — doveva spazzar via. Mestruazione era una parola ancora tabù, cruda come uno schiaffo, noi la sentivamo ostile. Io imparai a usare la parola franca più tardi, in tempo di guerra, tra le crocerossine. Ma, da ragazzette, usavamo un gergo — diverso a seconda delle regioni.
Il racconto, in apparenza personale, pochi paragrafi più tardi diviene riflessione sui miti, usanze, elementi folclorici antichissimi, quando — assumendo lo sguardo dell’antropologia, la sua disciplina d’elezione — Guiducci riflette su come il corpo femminile diviene spazio di scontro simbolico e materiale nelle diverse culture. Tutte, in modi diversi, hanno mirato a limitarne il più possibile la libertà, il movimento, la conoscenza e il desiderio stesso. Anche nell’Italia del 1974 il corpo delle donne è campo di battaglia costantemente sotto attacco, in un contesto che non aveva ancora nemmeno visto approvare la legge 194. Guiducci non ci sta: lo protegge, lo ricostruisce, lo esalta citando In Celebration of my Uterus di Anne Sexton, inno all’essere donna nonostante i giudizi altrui, ma rivendica al contempo la libertà di scegliere se diventare madri o meno. “Il primo atto di un femminismo nuovo starà non tanto nella rivendicazione erotica oltranzista”, scrive a un certo punto, “ma, prima, nell’accettazione che la donna saprà fare del proprio corpo”.
Un corpo che nel corso del libro cambia, cresce, si modifica, viene attraversato nei suoi momenti di grazia (“mi godevo momenti inediti e sublimi”) ma anche nelle molte difficoltà, dovute a fattori esterni e a pregiudizi introiettati sin da bambina:
Clandestina allo specchio, osservo il naufragio del mio corpo. Ho chiuso a chiave le porte della stanza. Sto consumando un peccato: guardarmi. Il mio corpo assolutamente nudo, oblungo e liscio, le costole sottopelle, le spalle strette appuntite, ostenta sotto il ventre quel taglio efferato, quella terribile mancanza, quel non avere, quel non essere! La mia anatomia non ha nome. Non conosco il nome di quella parte di me. Forse, non ha un vero nome. Ha solo il nome (vezzeggiato) dell’orma. La pipì e il pipì. Si tratta, dunque, di un nome maschio, mentre orina, liquido vergognoso che cola giallo dal corpo mentre umiliata e colpevole me ne sto al gabinetto (com’era da aspettarmi) un nome femminile, privo di forza e di solennità. Medito sull’assurdo.
Pagina dopo pagina, Guiducci lo legittima come fatto letterario, liberandolo al contempo dalle aspettative che (purtroppo ancora oggi, nella società della performance) gravano sulle donne – Bambine e adolescenti, donne senza figli e neomamme.

Alleanze
Scardinare i tabù per Guiducci significa quasi sempre riflettere sul potere castrante o liberatorio del linguaggio. “Oggi molte esperienze comuni alla struttura patriarcale sono nominabili”, ricordava Valeria Di Tano durante l’incontro al Circolo dei Lettori di Novara, a ragione: ci sono episodi del libro che oggi etichetteremmo senza esitazioni come catcalling e molestie, il che però non vuol dire che quest’ultima abbia perso la propria forza distruttiva, anzi. Il patriarcato agisce come una forza carsica: sembra scomparire, ma riemerge brutalmente ogni volta che le donne affermano la loro libertà. Basti pensare a come nelle ultime settimane sono stati raccontati i femminicidi di Sula e Campanella (su questo, rimando a quanto scritto da Silvia Grasso), o al victim shaming dei titoli di giornale relativi al presunto suicidio di Virginia Giuffre, segnalato in un post della giornalista del Sole 24 ore Lara Ricci.
Facendo proprio il suo retroterra di critica letteraria, Guiducci riflette di continuo su come l’uso della lingua (e il canone, all’epoca quasi interamente maschile) instilli nella donna un senso di inferiorità, un’educazione alla passività, o — nel caso delle più agguerrite — un invito sotteso a far propria ‘la lingua del padrone’:
“Così, mi bevvi tutte le meraviglie sanguinose della Storia, teatro di Cesari – di bruti villosi, soverchiatori nerboruti, sgozzatori spietati, prepotenti accaniti, tagliateste e astuti freddi come lame. Tutti gli inni alla Natura dei poeti pi. celebrati. Tutte le Beatrici e le Giuliette. Suggevo, suggevo – come una stupida mosca si affanna nel secchio in cui fatale annegherà. Giacché questo è il paradosso contraddittorio del sogno infantile dell’emancipazione femminile: affrancarsi attraverso la cultura stessa che ti elide e ti opprime, che non è per te”.
A queste forti pressioni, che innescano uno stress normalizzato che in molte conoscono bene, Guiducci risponde aprendo lo sguardo verso una dimensione collettiva che rende la battaglia delle donne solidale a quelle di tante altre comunità, in un’alleanza tra margini. Anche per questo La mela e il serpente è un testo critico verso i femminismi non inclusivi, quelli incapaci di superare i confini di classe o di provenienza; i racconti delle operaie e delle contadine, le trascrizioni di sogni richieste a conoscenti e gli incontri con le ventenni del ’74, la nuova mappa letteraria che viene tracciata nella seconda parte sono ponti verso l’altra-da-sé. È così che il dolore individuale, identitario diventa richiesta collettiva di cambiamento, un cambiamento già all’opera in queste pagine e che permane anche nei libri successivi, a partire da La donna non è gente, un’inchiesta ‘dal basso’ del 1977 che dà voce a nove contadine di varie regioni d’Italia nell’intento di riannodare la parola femminista a una riflessione economica sulle conseguenze materiali della povertà. Il femminismo, pare dirci Guiducci, è una pratica di libertà che non può che andare di pari passo con altre rivoluzioni:
“Credo nel compito futuro delle donne, spero in esso. Esistere non è un dato di fatto, ma un’invenzione. Un’invenzione umana, un fatto di cultura, di civiltà. E la donna, paradossalmente, e proprio a causa della sua lunga emarginazione sociale, si trova ad aver coltivato l’aspetto più misterioso e meno riducibile a macchina dell’esistenza. Perciò, ripeto, le donne e i neri si somigliano nelle loro pretese avanzate sul mondo. Si somigliano perhé in entrambi c’è un black power, c’è un potere oscuro, un culto più erotico e “magico” (cioè più. ansioso e ricco di mistero) di un’esistenza che non solo due più due fa quattro. E, in entrambi, questa potenzialità giace non sfruttata – non logorata e neppure deformata dallo strenuo, e, alla fine, fallimentare, “servizio sociale” prestato dall’uomo”.
Rileggere oggi La mela e il serpente significa dare parola a chi è stata zittita e riconoscere, come Guiducci insegna, che ogni gesto di liberazione femminile interroga l’intera società, e chiama ciascuno di noi a rispondere, a risponderne.