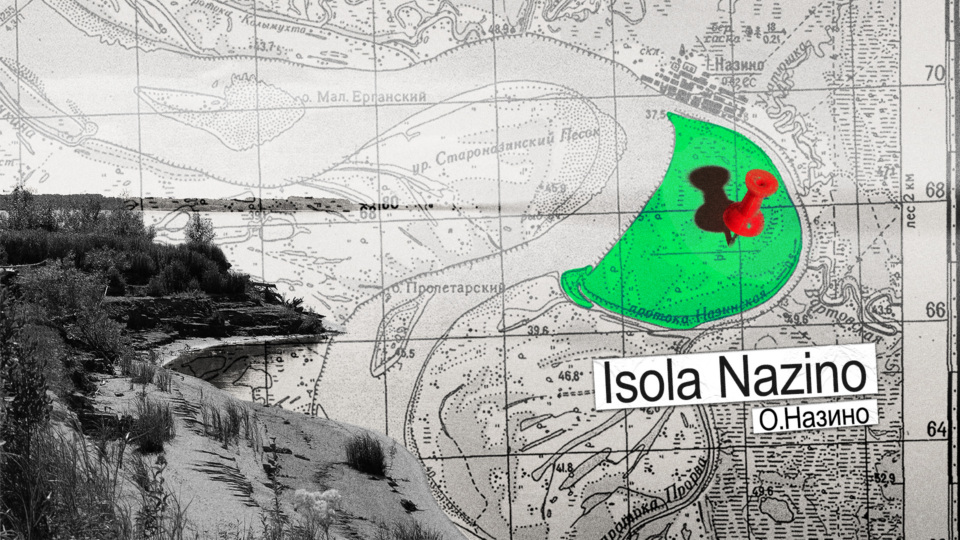Si parla molto del rapporto tra lavoro e salute mentale, ma nella maggior parte dei casi sono le professioni creative o quelle del terziario culturale a essere raccontate. Ci sono però tanti altri lavoratori il cui benessere psicologico è messo a dura prova ogni giorno, come gli assistenti di volo, gli edili e i poliziotti penitenziari.
Appena messo piede in aereo, il passeggero se la ritrova davanti ma la oltrepassa senza accorgersene. La cambusa – galley, in inglese –, l’ambiente nel quale vengono preparati i pasti, è arredato con sportelli metallici, strapuntini con cinture di sicurezza simili a quelle dei passeggini e carrelli per bevande e cibo. Qui gli assistenti di volo, quando non sono impegnati nelle loro mansioni, possono ritirarsi, sgranchirsi un po’ e parlare. Uno di loro, Fabio Bollo, racconta che negli incontri di gruppo con la psicologa avevano ribattezzato quei momenti galley therapy, “una sorta di terapia che noi inconsapevolmente facevamo a bordo chiacchierando con il collega, magari mai incontrato prima”.
Il lavoro è una componente inevitabile nel bilancio psicologico di una persona. La pandemia da Covid-19 ha agevolato un cambiamento nell’approccio di molti italiani al tema della salute mentale e, in alcuni luoghi di lavoro, si riscontra oggi una maggiore apertura. Ma bisogna tenere in considerazione almeno due aspetti. Innanzitutto, le aziende che per diversi motivi hanno iniziato a offrire servizi – più o meno efficaci – per il benessere mentale dei propri dipendenti sono solo la punta di una piramide alla cui base vi sono posti, in Italia, nei quali si fatica ad affermare una cultura della sicurezza sul posto di lavoro. In secondo luogo, la stampa ha rappresentato soprattutto le ansie e i disagi di certi tipi di lavoratori: l’esercito di quel terziario variamente retribuito che, seduto alla scrivania, invia mail, partecipa a riunioni da remoto, pianifica strategie, disegna bagni, sbobina interviste, legge, scrive, conta, programma. Ma quello della salute mentale è un tema che riguarda anche chi lavora in una cambusa a 10.000 metri di altezza, in un cantiere, nei corridoi di un carcere.
Nel cercare di spiegarmi tale distorsione nella rappresentazione dello stato di salute psicologico dei lavoratori italiani mi sono rivolta a Chiara Volpato, professoressa senior di Psicologia sociale all’Università di Milano Bicocca, domandandole se in qualche modo noi giornalisti ci siamo concentrati su alcuni lavoratori perché li percepiamo come simili, tralasciando gli altri. “Mi pare che storicamente sia sempre così,” risponde Volpato, “siccome chi scrive fa parte in genere della classe intellettuale, se possiamo chiamarla in questo modo, io ho l’impressione che da sempre questa abbia più attenzione per il proprio gruppo”. E in questo c’è il rischio di deumanizzare gli altri? “Non userei il termine deumanizzazione, sarebbe troppo forte, però sicuramente nei confronti di certi lavori c’è spesso un’attenzione molto strumentale, quindi parlerei piuttosto di oggettivazione: vediamo gli altri più come strumenti che come persone”. Una ricerca della Bicocca in tempo di pandemia aveva rilevato i burnout dei cassieri dei supermercati durante il primo lockdown; alcuni si sentivano trattati come un prolungamento del nastro trasportatore. E nessuno si affacciava ai balconi per ringraziarli. Il lavoro ha un così grande impatto sulla salute mentale degli individui non solo per il tempo investito nel suo svolgimento – o nella sua ricerca, se non c’è – ma anche per quello che ancora oggi rappresenta. “È collegato alla classe sociale delle persone,” spiega Volpato, “alla loro collocazione nella gerarchia sociale, al prestigio che pensano di avere, per cui è dimostrato che ha intimamente a che fare con il benessere dell’individuo”.
“Le aziende che per diversi motivi hanno iniziato a offrire servizi – più o meno efficaci – per il benessere mentale dei propri dipendenti sono solo la punta di una piramide alla cui base vi sono posti, in Italia, nei quali si fatica ad affermare una cultura della sicurezza sul posto di lavoro”.
Oltre a parlarmi della galley therapy, l’assistente di volo Fabio Bollo ha decifrato la distanza nel suo mestiere tra l’apparenza glamour – giri per il mondo, hotel di prima categoria, buoni stipendi – e le difficoltà che poi emergono nel tempo, legate soprattutto alla gestione della propria vita privata.
“Dall’esterno quelli che pensavano che noi fossimo dei privilegiati non si accorgevano che stavamo perdendo il senso della continuità dei rapporti, dei sentimenti, dell’emotività”. Negli ultimi decenni il fascino del settore aereo si è appannato anche a causa delle crisi aziendali. Lo stesso Fabio è in cassa integrazione da più di due anni, a seguito della trasformazione di Alitalia in Ita Airways, e questa situazione ha reso evidenti le ricadute psicologiche del proprio lavoro. Il continuo cambio di fuso orario, di temperatura, andare su e giù in un ambiente pressurizzato, trascorrere le festività lontani dalla famiglia: lui, in trent’anni di esperienza, ha risposto a tali sollecitazioni con autodisciplina, non senza però sentirne il peso. “Non puoi far sì che ti accadano e basta, devi controllarle, quindi controlli i sentimenti, il sonno, la fame,” racconta. “Non vivi più una condizione naturale ma devi sempre inquadrare quello che stai facendo, prevedere quello che accadrà, risparmiare energie”.
Il controllo è fondamentale anche secondo Valentina Giacchetti, psicologa che lavora nei Sasn (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante), i poliambulatori del ministero della Salute destinati a chi lavora a bordo di aerei e navi civili. Nella sua esperienza, il settore del trasporto aereo tende a essere dominato da una cultura organizzativa satura di controllo che “incentiva l’autonomia operativa, quindi l’adesione di ognuno alle procedure, ma che tende a logorare lo scambio con il gruppo di lavoro rispetto ai suoi obiettivi”. Coloro che si rivolgono a lei hanno il più delle volte difficoltà a tenere insieme i diversi aspetti della loro vita, “come se fossero presi dall’abitudine a dedicarsi a una cosa per volta, esattamente come succede nelle culture del controllo”.
Un’altra assistente di volo mi ha confidato, invece, il ruolo che la solitudine ricopre in questo mestiere.
“Anche se spesso non ce ne rendiamo conto, è un fattore molto importante e ha portato anche alcuni colleghi a compiere gesti estremi”. Ancora oggi, nonostante chat e videochiamate, chi si trova dislocato dall’altra parte del mondo in una camera di hotel può sentirsi solo. E poi subentra anche un “blocco”, che rende difficile raccontare a terra le sensazioni vissute in volo. “Come quando ti trovi dentro certi temporali e hai paura. Poi, quando si scende, si racconta poco”.

Di solitudine mi parla pure una sindacalista del settore edile, Giulia Bartoli.
Bartoli è il segretario nazionale di Fillea-Cgil, con delega a salute e sicurezza sul lavoro. Del mondo dell’edilizia e affini fanno parte figure professionali molto diverse, da chi estrae i materiali nelle cave ai restauratori di beni culturali; e poi i montatori di ponteggi, i muratori e chi lavora nelle fabbriche di cucine e salotti.
La percezione dell’importanza della salute mentale individuale e del benessere organizzativo in questi ambienti è una novità anche per gli stessi sindacalisti, abituati a focalizzarsi su salario, tutela dei diritti e riduzione degli infortuni. Ed è proprio la paura di subire un incidente sul lavoro uno dei primi fattori ad alimentare un disagio psicologico negli edili. Bartoli specifica però che non si riesce ad averne una percezione diretta; quando si tratta di difficoltà psicologiche “il problema principale è che non ne parlano; sono settori prettamente maschili ed è questo forse il limite più grande, perché la donna è più incline a esternare il disagio, ma la presenza femminile qui non arriva al 10%”. Una di loro, Francesca – nome di fantasia –, fa da molti anni la cucitrice presso un salottificio e per telefono mi racconta che in fabbrica sono le donne a parlare in modo più intimo dei propri problemi, mentre i colleghi uomini “urlano, sbraitano il loro malessere”.
Questo silenzio sulla salute mentale potrebbe però essere interrotto dall’arrivo sui cantieri delle nuove generazioni, più inclini dei loro padri a comunicare i propri disagi e con una concezione diversa del ruolo dell’uomo nella famiglia italiana. Da sempre, le imprese dell’edilizia che lavorano in giro per l’Italia richiedono ai dipendenti di lasciare le famiglie per settimane. “Prevale un senso di solitudine, ma è davvero difficile che vengano a dirtelo”, dice Bartoli, aggiungendo, tuttavia, che le è capitato che giovani padri le esprimessero la loro difficoltà nello stare troppo tempo lontani da casa.
“Questo silenzio sulla salute mentale potrebbe però essere interrotto dall’arrivo sui cantieri delle nuove generazioni, più inclini dei loro padri a comunicare i propri disagi e con una concezione diversa del ruolo dell’uomo nella famiglia italiana”.
Graziano Lori la chiama “trasformazione nella componente umana” e conferma che sta avvenendo anche all’interno delle forze dell’ordine italiane. Lui se ne occupa dai primi anni Duemila con Cerchio Blu, associazione di promozione sociale che presiede, nata per portare nel nostro paese il sostegno psicologico tra pari per gli operatori di polizia, e che si è evoluta fino a diventare un punto di riferimento nazionale per la salute mentale degli appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, e Polizia locale. Incaricati dalla pubblica amministrazione, per esempio a seguito di fatti particolarmente traumatici, gli psicologi di Cerchio Blu offrono sostegno individuale oppure conducono degli incontri di debriefing, decompressione emotiva di gruppo per una decina di operatori a seguito di eventi come omicidi, conflitti a fuoco, suicidi.
L’ingresso di nuove reclute con un livello culturale più alto, più inclini a partecipare a incontri di formazione e convegni e capaci di elaborare con più attenzione le ripercussioni della loro attività professionale, sta portando non solo più sensibilità verso il disagio lavorativo, ma anche più apertura nei confronti degli strumenti atti a fronteggiarlo: per esempio, avendo già sperimentato la presenza di uno psicologo a scuola, tendono a non guardare a queste figure come delle spie o dei manipolatori, ma le considerano delle risorse. “Il terreno non è più arido come all’inizio”, sostiene Lori.
Un poliziotto o un carabiniere può risentire psicologicamente del proprio lavoro e del modo in cui è organizzato. Il primo caso è evidente per questo mestiere, che comprende l’uso delle armi, ed espone quotidianamente chi lo fa a morti violente, aggressioni, abusi su minori. Il presidente dell’associazione, inoltre, mi spiega che c’è una situazione particolare che stressa enormemente gli operatori delle forze dell’ordine: “Preferiscono fare un arresto violento che comunicare a una famiglia la morte di un ragazzo, ed è anche comprensibile”. Dallo stress per eventi critici in servizio, nella “quasi totalità” dei casi, spiega Lori, il recupero avviene. Andare, invece, alla radice del problema in questioni legate al contesto lavorativo – come l’accesso alla carriera, oppure il rapporto con i superiori gerarchici – è più complesso. Nel parlarmene, Lori sottolinea come lo stress organizzativo causi livelli di burnout molto elevati tra le forze dell’ordine.

Burnout è una parola con la quale in Italia abbiamo imparato a familiarizzare nel periodo post-pandemico e che, nel linguaggio comune, finisce per indicare in modo accattivante una forma di esaurimento. Il termine – coniato nel 1974 da Herbert Freudenberger, psicologo descritto nel suo necrologio come un uomo “molto complicato” che lavorava abitualmente 15 ore al giorno – viene spesso usato anche per indicare qualsiasi malessere psichico originato a lavoro, anche quando non è così.
In un articolo del 2021 sul «New Yorker», la storica e giornalista Jill Lepore, nel raccontare la parabola della parola negli ultimi decenni, la definisce una “metafora travestita da diagnosi”. Questo perché siamo in presenza di un fenomeno occupazionale e non di un disturbo medico. “Al di là dell’errata concettualizzazione, il rischio reale che vedo è che se io non do a un problema la sua giusta etichetta e collocazione non lo posso risolvere correttamente”, commenta Ilaria Setti, psicologa del lavoro che insegna all’Università di Pavia. Setti ci aiuta a ricollocare il burnout nei giusti termini: “Le sue cause sono da attribuire alla gestione e all’organizzazione del lavoro, e questo non può riguardare un’unica persona; le problematiche che riguardano un’unica persona e sono passibili di diagnosi clinica sono altre, di sicuro non il burnout”. Però spesso accade che la persona avverta uno o più dei sintomi tipici del disturbo – esaurimento delle energie, distanza mentale o cinismo nei confronti del proprio lavoro, ridotta efficacia professionale – e si convinca di essere in burnout anche quando magari la causa del malessere non è organizzativa. Laddove però il burnout c’è davvero, la risposta non può ricadere solo sull’individuo. Oltre alla psicoterapia, “devono esserci soluzioni di tipo collettivo, come forme di psicoeducazione, informazione e riorganizzando le attività lavorative”, avverte Setti.
I disagi causati dal contesto professionale e dalla natura del proprio operato sono comuni a tutte le forze dell’ordine, ognuna con le proprie caratteristiche. Una in particolare, però, sembra essere la più esposta quotidianamente al malessere psicologico altrui.
Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato di categoria Uilpa Polizia Penitenziaria, descrive le carceri italiane come “un luogo dove i criminali sono forse la minoranza: ci sono soprattutto quelli che, per varie ragioni, sono considerati i deietti della società”. Nei loro corridoi, gli uomini e le donne della Penitenziaria sono, a detta del sindacalista, “gli unici costantemente presenti ad accudire” queste persone scaricate dal resto della società. Gli agenti entrano a contatto ogni giorno con le sofferenze mentali dei detenuti, che sono notevoli. Basti ricordare un solo dato: nel 2022 ,abbiamo assistito al più alto numero di sempre di suicidi in cella, 85, secondo il rapporto dell’associazione Antigone.
Questo non può non avere delle ricadute anche sulla mente degli agenti della Penitenziaria, i quali “vanno incontro a disturbi di carattere psicologico o psichiatrico che molto spesso evitano di denunciare perché ne deriverebbero conseguenze negative per la carriera sia per la vita ordinaria”, afferma De Fazio. Una sua stima è che tra il 25% e il 50% dei pensionati della Polizia Penitenziaria si ritirano portandosi dietro delle patologie psichiche. Il sindacalista aggiunge che da qualche tempo è stato messo loro a disposizione un servizio di sostegno psicologico, ma c’è ancora molta ritrosia a rivolgervisi. E se in altri ambienti la speranza nella maggiore sensibilità al disagio psichico delle giovani generazioni di lavoratori sembra ben riposta, negli istituti penitenziari al momento il cambiamento appare lontanissimo.