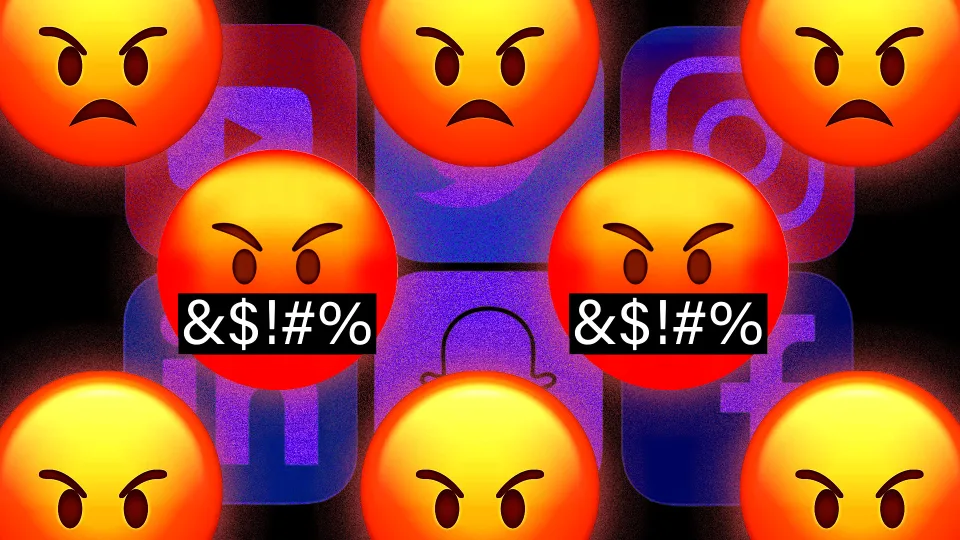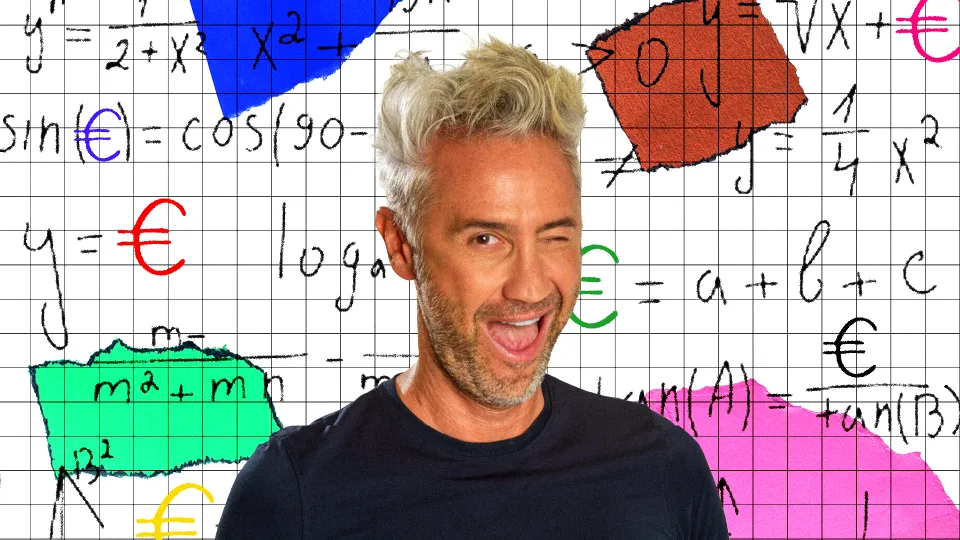Col romanzo “La valle dei fiori”, uscito nel 2023, ha denunciato l’inadeguatezza del sistema groenlandese nel prevenire la depressione tra i giovani. L’abbiamo incontrata in occasione del Festival “I boreali”, e abbiamo parlato del passato e del presente del suo Paese – quindi anche di Trump, della Spiralkampagnen e del pericolo di un turismo invasivo.
Quando guardiamo una qualsiasi rappresentazione del mondo secondo la proiezione di Mercatore, ossia quella che possiamo trovare sui libri di scuola o sulle cartine appese nelle classi, sappiamo già che la grandezza degli Stati è viziata dalla necessità di rappresentare su due dimensioni qualcosa che, in realtà, due dimensioni non ha. Allora ci può sembrare che la Groenlandia sia più grande dell’Australia (non lo è). E non è nemmeno più grande dell’India, ad esempio, o del Brasile.
In realtà, la Groenlandia non è nemmeno uno Stato autonomo, ma è un territorio appartenente al Regno di Danimarca, una sua provincia. La questione, assodata dal 1953, è tornata recentemente d’attualità, visto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso più volte, da quando è stato rieletto, la volontà di acquisire l’isola “in un modo o nell’altro”, per assicurare la stabilità economica degli USA.
La Groenlandia è l’isola più grande del mondo, ricoperta per oltre l’80% di ghiaccio. Il restante 20%, soprattutto in prossimità delle coste, è popolato da 56.865 abitanti, discendenti in maggioranza dal popolo Inuit e da colonizzatori danesi. La densità abitativa è di 0,03 abitanti per chilometro quadrato, la più bassa di tutta la Terra. Per avere un metro di paragone, quella di Milano è di circa 7520 ab/kmq.
Nonostante la terra abitabile sia veramente scarsa, il sottosuolo della Groenlandia è ricco di risorse minerarie a lungo sfruttate dalla Danimarca, tra cui oro, zinco, piombo, rame, nichel e cobalto. Quello che però oggi attira maggiormente l’attenzione delle grandi multinazionali statunitensi, ma anche cinesi, sono le riserve di terre rare e uranio, la cui estrazione non è di particolare interesse per i groenlandesi (ma lo è per i cinesi e gli americani).
L’industrializzazione forzata dell’isola, voluta dalla Danimarca e avvenuta tra gli anni ‘50 e ‘70, ha avuto delle ripercussioni devastanti sulla popolazione locale, con un innalzamento del tasso dei suicidi, l’aumento della violenza domestica su donne e minori, e l’abuso di alcol.
La scrittrice Niviaq Korneliussen, nata a Nanortalik, all’estremo sud dell’isola, delinea nei suoi romanzi un ritratto generazionale della Groenlandia moderna, affrontando temi di attualità e denuncia, a lungo trascurati dalla letteratura tradizionale.
La valle dei fiori, il suo secondo libro, pubblicato da Iperborea nel 2023 con la traduzione di Francesca Turri, denuncia con forza l’inadeguatezza del sistema groenlandese nel prevenire la depressione tra i giovani, mettendo in luce il silenzio e il tabù che circondano questo argomento.
In occasione del Festival di Iperborea “I boreali”, Korneliussen è venuta in Italia per la prima volta. Classe 1990, definita dal «New Yorker» come “una stella inaspettata”, ha pubblicato, oltre a La valle dei fiori, Homo Sapienne, ancora inedito in Italia – in arrivo a giugno per Iperborea con il titolo di Una notte a Nuuk, tradotto sempre da Francesca Turri.
È un’occasione molto rara poter parlare con una scrittrice groenlandese se consideriamo che non esiste una vera e propria scena letteraria sull’isola. La tradizione popolare di racconti orali e miti della Groenlandia e del popolo inuit hanno poco a che fare con quelli che sono considerati i paesi del nord, ma oggi è difficile far leggere libri ai giovani e gli scrittori o le scrittrici viventi si contano sulle dita di una mano. Da dove nasce il tuo bisogno di scrivere e come hai iniziato?
Credo che per me iniziare a scrivere sia stato un processo naturale, fin da quando ero piccola. Mia sorella ha cinque anni in più di me e quando io ho iniziato ad andare a scuola, lei scriveva già diari. La invidiavo molto perché lei sapeva scrivere, quindi riusciva a descrivere tramite le parole ciò che viveva durante la giornata. E soprattutto poteva inventare storie. Per me era come se avesse una sorta di superpotere. Quando ho iniziato a scrivere anche io mi sono sentita estremamente libera.
Oggi vivo a Nuuk, ma la città in cui sono nata è molto piccola – circa 1500 persone – non succede granchè ed è su un’isola, quindi non si può andare da nessuna parte [nda: i collegamente interni all’isola in Groenlandia sono molto difficoltosi e può capitare di rimanere bloccati per settimane tra una tappa e l’altra.] Capita forse una volta ogni due anni di andare in un’altra città o in Danimarca.
Perciò tutto quello che abbiamo è ciò che si può trovare in città. Ma quando ho iniziato a scrivere, ho avuto la possibilità di inventare storie e modellare personaggi che mi sarebbe piaciuto incontrare nella vita reale. È stato molto liberatorio, ma anche molto naturale.
Non avrei mai pensato di diventare realmente una scrittrice perché gli unici scrittori che vedevo, per esempio in televisione, erano dei vecchi uomini groenlandesi che scrivevano di caccia, memorie del passato, o comunque di argomenti molto noiosi a mio parere.
E soprattutto si comportavano come se fossero una casta, uomini di mezza età appartenenti a una classe superiore. Era impossibile riconoscersi in loro. Perciò, quando ho iniziato a pensare di scrivere un romanzo e pubblicarlo, non sapevo bene come fare.
In Groenlandia non ci sono case editrici, anzi, l’unica che ho trovato e a cui ho scritto non mi ha mai risposto. Ma poi, a vent’anni, ho partecipato a un concorso di racconti brevi e sono stata scelta tra i dieci vincitori. Uno dei premi consisteva in un viaggio in Danimarca, Svezia e Finlandia per prendere parte ad alcuni festival letterari e visitare scuole di scrittura, e lì è cominciato tutto.
Mi ricordo a Göteborg, in Svezia, un’enorme fiera del libro con migliaia di visitatori al giorno. È la più grande dei Paesi nordici. Per me era difficile capire come mai ci fossero così tante persone lì. Erano lì per i libri. Ma io non riuscivo a capire perché, visto che in Groenlandia nessuno si occupa di libri.
Per come ero abituata a vederla io, immaginavo che il mio primo libro sarebbe stato pubblicato e avrebbe preso polvere su una libreria o in una biblioteca e che nessuno ne avrebbe mai parlato. Quindi è stato davvero ipnotico rendermi conto di quanto fosse viva la scena letteraria in altri. Dopodiché mi sono innamorata di questo mondo e ho voluto farne parte. Oggi mi ci riconosco.
I personaggi principali dei tuoi libri, La valle dei fiori e Homo Sapienne, sono sempre molto giovani. Lo spazio per gli adulti e gli anziani è marginale e, nella tua scrittura, il distacco tra le generazioni appare molto netto. Perché?
Quando ho iniziato a scrivere il mio primo libro, Homo Sapienne, avevo vent’anni, mentre con La valle dei fiori ero vicina ai trenta. In quel momento per me la cosa più importante era scrivere di qualcosa che mi interessasse profondamente. C’erano così tanti movimenti nella nostra generazione in quegli anni, specialmente a Nuuk, la capitale, ad esempio i giovani queer che diventavano sempre più visibili nella società. Volevo concentrarmi su questo aspetto e scrivere un libro in cui i giovani della Groenlandia potessero riconoscersi. Non mi interessavano le generazioni più anziane perché sapevo che non si sarebbero comunque avvicinate ai miei libri. Volevo che il mio pubblico fosse costituito da giovani. Quando ero un’adolescente, se ci fosse stato qualche libro che parlava della mia condizione, forse non mi sarei sentita sola.
La protagonista di La valle dei fiori si sposta in Danimarca per provare a tracciare il suo futuro fuori dai confini dell’isola, che sembrano opprimerla, ma nemmeno lì troverà il suo posto nel mondo. Nella società groenlanese è molto comune spostarsi per studiare o lavorare?
Assolutamente sì, anzi, in un certo senso siamo costretti a farlo. È possibile studiare in Groenlandia se ad esempio si vuole diventare insegnanti o infermieri. Ma se vuoi diventare medico, psicologo, ingegnere o qualcosa del genere, devi per forza andare in Danimarca. Alcuni oggi si spostano anche verso la Norvegia o il Canada, ma moltissimi si trasferiscono in Danimarca.
“Non avrei mai pensato di diventare realmente una scrittrice perché gli unici scrittori che vedevo, per esempio in televisione, erano dei vecchi uomini groenlandesi che scrivevano di caccia, memorie del passato, o comunque di argomenti molto noiosi a mio parere”.
La Groenlandia infatti è ancora un territorio appartenente al Regno di Danimarca, così come le isole Fær Øer. Oggi qual è il rapporto tra Danimarca e Groenlandia e che influenza ha la cultura danese su quella groenlandese?
Ci sono ancora molti aspetti che derivano dalla cultura danese. È molto presente nella nostra vita quotidiana, ad esempio per il modo di mangiare. Anche lo shopping ricalca molto lo stile scandinavo, così come il design d’interni. Ma questo soprattutto nelle città. Nei villaggi, invece, le influenze della Danimarca non sono molto evidenti, quella danese è una cultura così diversa per origini e Storia che è difficile da intrecciare alla nostra. Infatti, per quanto riguarda il cinema, la musica, il teatro, ma anche la letteratura, noi restiamo molto groenlandesi. La musica e il teatro, soprattutto, si basano in larga parte sulla cultura Inuit, con tamburi, canti di gola… In questo senso siamo estremamente diversi dai danesi. Ed è anche per questo che abbiamo così tanti problemi tra di noi, perché i danesi non ci hanno mai riconosciuto come persone che avevano una propria autonomia.
Per un periodo della tua vita anche tu hai vissuto in Danimarca, ma poi hai deciso di tornare – così come succede in La valle dei fiori – per il bisogno di sentirti immersa nella natura. Non se ne può fare a meno, se sei nato e cresciuto in Groenlandia?
La Groenlandia è molto isolata rispetto al resto del mondo. L’80% del suo territorio è ricoperto di ghiaccio perciò il nostro modo di vivere e di pensare alla vita, alla natura e agli esseri umani è molto diverso rispetto a quello scandinavo anche a causa della natura.
Non ci si rende conto di avere un legame con la natura fino a quando questa non c’è più. Può sembrare una frase fatta, ma io stessa l’ho scoperto quando ho trascorso un inverno in Danimarca. Faceva così freddo, era così buio! Anche in Groenlandia fa freddo, certo, ma lì è diverso, non c’è la neve, non c’è la luce della luna, piove sempre, è molto umido. È stata un’esperienza molto strana per me. E poi in Danimarca di fatto non c’è natura, eccetto per le foreste, che però per noi non sono davvero natura, perché in Groenlandia non ci sono alberi, quindi la foresta diventa un posto molto spaventoso.
Un’altra cosa che mi mancava durante il mio anno in Danimarca è il silenzio. In Groenlandia, quando ti allontani anche solo di venti minuti dal centro della città sei nel mezzo del nulla, potresti prendere una direzione e non essere mai più ritrovato, anzi, potresti camminare per il resto della vita e non arrivare da nessuna parte. È un silenzio che non si trova in nessun’altra parte del mondo
Quando ho vissuto in Danimarca ho avuto la sensazione che gli esseri umani avessero il potere – o volessero avere il potere – di controllare tutto. Per darsi un appuntamento, tra amici ci si dice: “Possiamo incontrarci fra tre giorni, alle 16:30 o alle 16:25, e possiamo stare insieme un’ora”. Per me è claustrofobico.
In Groenlandia credo ci sia una connessione maggiore tra esseri umani. Il modo in cui ci si visita a vicenda ci unisce spontaneamente con altre persone, come se fossimo parte di un ecosistema più grande di noi.
Siamo solo piccoli mattoni in questo mondo enorme. È così che percepiamo la vita.
Parlando del rapporto tra Groenlandia e Danimarca, uno dei fenomeni più crudeli della storia recente dell’isola riguarda la politica danese sulla natalità, la Spiralkampagnen. Tra anni ‘60 e ‘70, seguendo le direttive governative, i medici danesi impiantano spirali intrauterine a circa 4000 donne inuit, dimezzando di fatto il tasso di natalità. Come è emersa questa vicenda?
Credo che oggi la Groenlandia stia compiendo alcuni passi molto importanti verso una chiara presa di distanza dalla Danimarca, soprattutto dopo che Trump ha cercato di comprarci per la seconda volta. Ci sono molte cose che stanno venendo a galla oggi e la Spiralkampagnen è tra queste.
È molto complicato parlarne perché molte delle donne che l’hanno vissuta sono ancora vive oggi. Posso fare un esempio a me molto vicino, quello di mia zia che attualmente vive in Danimarca e non ha mai potuto avere figli per questo motivo. Lei è rimasta sconvolta da quanto le è successo e noi non ne sapevamo nulla.
Solo un paio di mesi fa ce l’ha detto perché non aveva mai pensato fosse un problema concreto. È molto complicato perché noi, come nazione, siamo molto arrabbiati, ma dobbiamo essere anche molto attenti perché ci sono tante donne vive che sono state traumatizzate e che stanno ancora processando il proprio dolore, forse hanno appena iniziato a capire solo ora perché tutto sta venendo a galla.
Ma non siamo mai stati veramente riconosciuti nella nostra storia coloniale. Perché il governo danese non vuole scusarsi. Dicono che devono passare un paio d’anni per approfondire la questione prima di potersi scusare. Non provano mai a venirci incontro, siamo sempre noi a doverci adattare a loro e alle loro esigenze, anziché il contrario.
I danesi hanno avuto l’opportunità di chiedere scusa e ammettere di essere stati dei cattivi colonizzatori, loro sostengono di essere dalla parte giusta, ma non esistono buoni colonizzatori. Si stanno solo difendendo e non riconoscono affatto i nostri traumi coloniali e questo ci porta ad allontanarci ancora di più da loro.
E questo è solo uno dei problemi. Mia madre non ha mai conosciuto suo padre. Negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, alcuni uomini danesi passavano periodi più o meno lunghi in Groenlandia per lavoro. Si trattava di persone che spesso avevano una famiglia in Danimarca e se durante il loro soggiorno mettevano incinta una donna groenlandese potevano scegliere di rinnegare i futuri figli e tornare in Danimarca, protetti dal governo danese.
Ci sono molte questioni che hanno sconvolto la vita di intere famiglie.
Noi vorremmo lottare per loro, ma cerchiamo di essere molto attenti alla sensibilità di queste donne.
È una questione di rispetto del dolore.
Sì, esattamente. Per esempio, c’era un teatro che voleva fare un’opera sulla Spiralkampagnen scritta da una donna groenlandese che non l’ha vissuta in prima persona. Ma non è la sua storia. È la loro storia e noi dobbiamo ascoltarle in questo momento. È davvero complicato.
Un altro argomento molto complesso che è al centro del tuo ultimo libro è il suicidio. A oggi, le statistiche riguardanti il tasso di suicidi in Groenlandia sono viziate dai dati danesi, ma se la Groenlandia fosse uno stato autonomo sarebbe quello con il tasso più alto di suicidi. In alcune interviste parli di una sorta di “cultura del suicidio” della Groenlandia, che cosa significa?
È iniziato tutto nei primi anni Cinquanta. Alla Danimarca fu detto: “Non si colonizza più, quindi dovete sbarazzarvi di tutte le colonie”. Invece di sbarazzarsi di noi, perché ovviamente avevano un interesse economico nel nostro Paese, decisero di farci diventare parte della Danimarca.
Quando ciò avvenne, nel 1953, il governo danese decise di apportare tutta una serie di cambiamenti alla nostra società, costringendo la gente a spostarsi dai piccoli villaggi intorno alla costa per trasferirsi nelle città più grandi per lavorare nelle fabbriche, principalmente ittiche, invece di andare a caccia. Così molte persone sono state trasferite nelle grandi città abbandonando le loro famiglie, le loro case e la natura. È stato un grande trauma collettivo.
Negli stessi anni, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Danimarca ha aperto il commercio di alcol verso la Groenlandia. Molte persone hanno iniziato ad abusarne, insieme all’assunzione di alcune droghe, come l’hashish. Il circolo vizioso è iniziato lì e oggi nella società groenlandese c’è molta violenza.
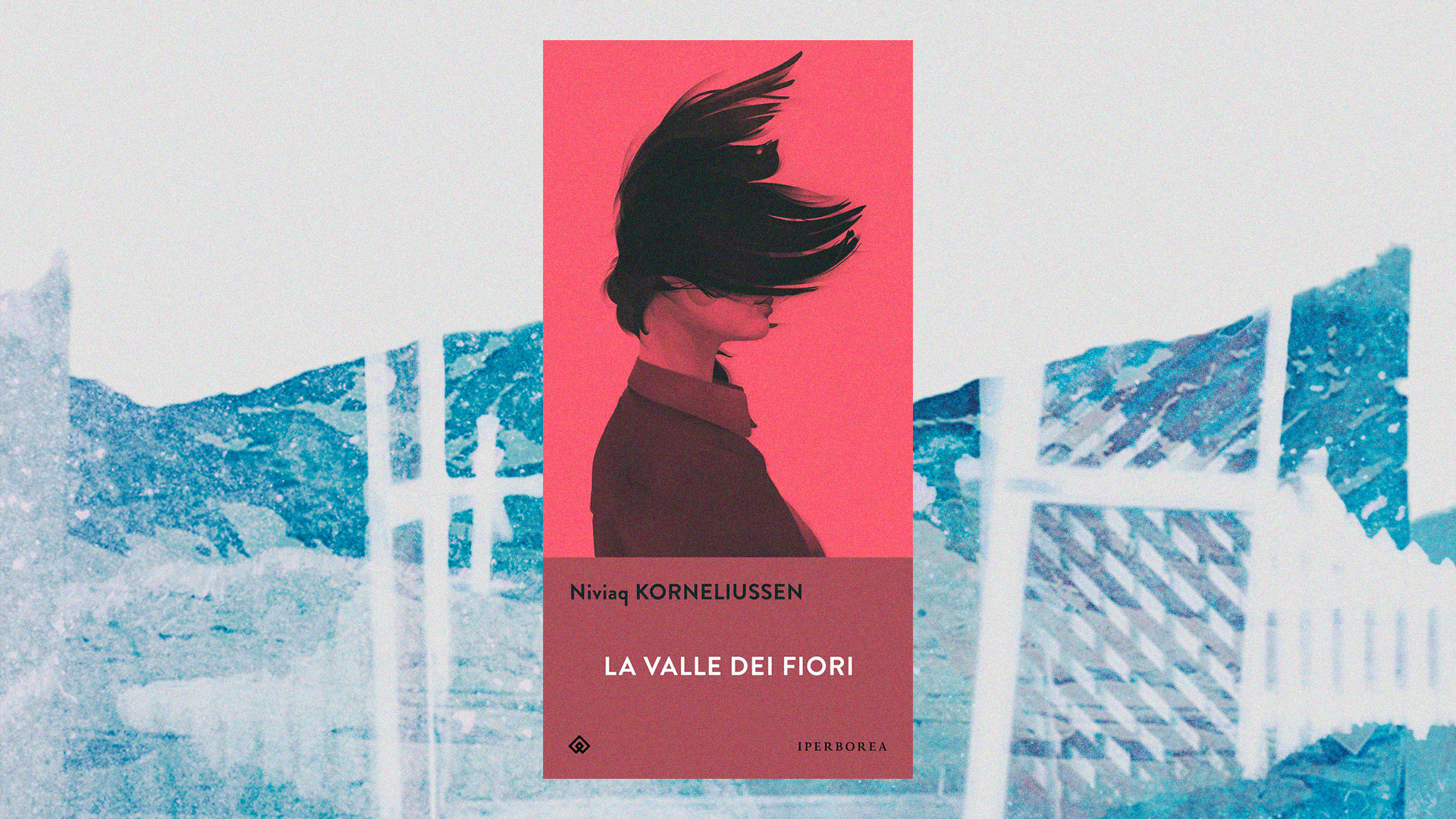
Si dice che una società si industrializza in duecento o trecento anni, ma per noi è successo in venti o trenta anni, è stato tutto estremamente veloce. Il modo di vivere è stato completamente rivoluzionato in sole due generazioni. Questo ha avuto un impatto decisivo sulla società e ha dato il via a molti suicidi, e a molte aggressioni sessuali.
Se si guardano i numeri, il numero dei suicidi era praticamente a zero fino al 1955, e poi è aumentato esponenzialmente fino alla metà degli anni Ottanta. Oggi, credo, sta iniziando a scendere di nuovo, ma molto, molto lentamente.
Il problema è che ci sono ancora così tante questioni irrisolte , come la violenza sessuale, l’abuso di minori, l’alcolismo, la poverà, che l’attenzione generale si è rivolta principalmente a questi, e soprattutto ai bambini, trascurando il problema dei suicidi.
Ci sono molti giovani che si suicidano perché non gli è mai stato detto che non è una cosa necessaria da fare. È stato un fenomeno così tanto normalizzato nella nostra società che nessuno se ne preoccupa realmente, per questo lo chiamo “cultura”.
Negli anni della scuola, per esempio, molti miei amici si sono suicidati. Se non ricordo male, nella mia classe, in una scuola pubblica, cinque o sei persone hanno commesso suicidio. E molti altri miei coetanei si sono suicidati nel corso degli anni. Il mio primo compagno di classe si è suicidato quando avevamo 13 anni.
È un’età molto precoce e nessuno ce ne ha parlato. I nostri genitori non ne parlavano. I nostri insegnanti non ne parlavano. Non ne abbiamo parlato perché non sapevamo come parlarne. L’unica cosa di cui parlavamo era: come ha fatto? Come si è suicidato? Si è sparato? Si è impiccato? Ma dato che nessuno ne parlava, pensavamo che fosse normale. E quando la gente si suicida dappertutto, si comincia a pensare che quello sia un modo normale di reagire a un momento difficile.
È ancora molto normalizzato nella nostra società perché nessuno ci dice che è anomalo.
È un tabù e siamo così silenziosi su questo argomento che molte persone con pensieri suicidi non hanno il coraggio di parlarne con nessuno e il sistema non è in grado di aiutare questi giovani che hanno pensieri suicidi. Non hanno la capacità di salvarli.
Pensi che qualcosa stia cambiando a questo proposito? Il tuo libro ha influito a incentivare il dibattito?
Dipende da quando me lo chiedi. A volte mi sembra che non sia cambiato nulla, ma a volte sento che qualcosa sta cambiando.
Non per il mio libro, ma per il fatto che il mondo si sta aprendo a parlare di malattie mentali. Le persone su TikTok parlano di sentirsi sole, di non avere amici, di essere vittime di bullismo e di avere genitori divorziati, tutto è disponibile su Internet.
Penso che i giovani groenlandesi stiano iniziando a capire che non sono soli quando si tratta di avere problemi a casa o soffrire di disturbi mentali, ma comunque c’è una grande differenza tra chi ha la fortuna di avere un background familiare più solido e chi, soprattutto nelle piccole comunità, non ha ancora un linguaggio per parlare dei propri sentimenti.
Non si riesce a vedere la Groenlandia come un’unità, quindi dipende da dove ci si trova. In generale però stiamo diventando sempre più consapevoli dei problemi che abbiamo, perché stiamo riflettendo su ciò che è accaduto nella nostra storia, nella nostra storia coloniale, su ciò che è accaduto a tutte queste donne, ma anche a tutti questi uomini che sono stati obbligati ad andare in Danimarca per lavorare.
Anche qui ho un esempio vicinissimo alla mia famiglia. Mio padre è stato mandato in Danimarca e per tutti gli anni che ha vissuto e lavorato là gli è stato detto che non era degno di un danese. E questo lo si vede bene in lui oggi. Ha 70 anni e ha dei problemi di cui non si libererà mai.
Tutti i personaggi principali dei tuoi romanzi appartengono alla comunità LGBTQIA+ di cui tu fai parte in modo partecipato come attivista. Qual è la sensibilità in Groenlandia rispetto a questa tematica?
In questi ultimi anni ho viaggiato molto e ho sperimentato la vita delle persone queer nelle diverse società Paesi.
In Groenlandia non è totalmente accettato, ma abbiamo molti diritti come persone queer, per esempio, se sei lesbica puoi adottare, puoi rimanere incinta con un donatore di sperma e la tua compagna diventerà ufficialmente mamma.
“Penso che i giovani groenlandesi stiano iniziando a capire che non sono soli quando si tratta di avere problemi a casa o soffrire di disturbi mentali, ma comunque c’è una grande differenza tra chi ha la fortuna di avere un background familiare più solido e chi, soprattutto nelle piccole comunità, non ha ancora un linguaggio per parlare dei propri sentimenti”.
In Italia la situazione è decisamente peggiore.
Sì, lo so. In merito a questo argomento noi siamo molto più aperti e difficilmente avvengono crimini dettati dall’odio di genere, però c’è ancora molta discriminazione nei confronti degli omosessuali maschi nella nostra società, soprattutto tra le giovani generazioni. È un problema, ma non se ne parla apertamente. Se si incontrano persone omofobe, sono molto riservate, non esprimono pubblicamente la loro opinione.
Se si considera però la nostra cultura e il nostro modo di vivere prima della colonizzazione, nelle piccole comunità la sessualità e l’orientamento sessuale erano molto fluidi. Ci sono storie di persone dello stesso sesso che, all’interno di comunità anche molto piccole, avevano una relazione.
È stato quando è arrivato il cristianesimo che siamo diventati sempre più chiusi nella nostra sessualità perché ci è stato insegnato che tutto ciò che vivevamo prima era sbagliato.
Oggi abbiamo ancora molta strada da fare, soprattutto per quanto riguarda i diritti degli omosessuali maschi. Ma credo che, rispetto ad altri Paesi, la nostra sia una società molto più aperta e accogliente.
Un argomento di stringente attualità riguarda l’apertura dell’aeroporto internazionale a Nuuk, che faciliterà i collegamenti con l’isola e probabilmente aumenterà il tasso di turismo. Questo è un punto complicato perché da un lato i turisti, com’è stato ad esempio per l’Islanda, potrebbero contribuire alla crescita del PIL e a una progressiva indipendenza economica dalla Danimarca, dall’altro lato però c’è il bisogno di un sistema di infrastrutture e regole che possano contingentare l’afflusso di persone sull’isola. Come viene percepita in Groenlandia questa notizia?
È un argomento realmente complicato. Da un lato per noi è una notizia molto bella, perché finalmente avremo voli diretti con il resto del mondo. Ma quando si dice un aeroporto internazionale forse si esagera un po’. È un aeroporto molto, molto piccolo. Ci sono solo due grandi aerei che atterrano ogni giorno in alta stagione. In bassa stagione, c’è solo un volo per la Danimarca al giorno, forse un volo per New York ogni due settimane e alcuni voli diretti per Reykjavik, in Islanda.
Per la popolazione locale, le infrastrutture sono un grosso problema. Ad esempio, io e un mio collega dovevamo andare a Uummannaq, nel nord della Groenlandia, a gennaio, per tenere un workshop con i giovani. Per raggiungerla abbiamo dovuto fare due soste durante il viaggio. Durante la nostra prima tappa nella Groenlandia settentrionale, noi siamo rimasti bloccati per cinque giorni, ma altre persone sono rimaste bloccate lì per circa tre settimane e hanno trascorso il Capodanno e il Natale in albergo perché non potevano tornare a casa a causa del meteo o di problemi tecnici, tipo il malore di un pilota o cose del genere. Gli spostamenti sono complicati e si corrono molti rischi quando si decide di viaggiare con voli nazionali.
In più è estremamente costoso viaggiare da Nuuk al resto della Groenlandia, o da Nuuk a qui, per esempio. Cosa significherà tutto ciò per Nuuk o per le città che avranno questi grandi aeroporti?
Penso che ci siano delle restrizioni e alcune leggi che ci aiutano a proteggere la natura. Non credo diventerà un problema come in Islanda. Perché è molto più complicato arrivare in Groenlandia che in Islanda. In Islanda puoi arrivare a Reykjavik, prendere una macchina e guidare per tutta l’isola. Non è lo stesso in Groenlandia. Quando arrivi in un posto puoi rimanere bloccato lì per settimane.
Quindi il turismo potrebbe diventare in futuro un problema?
A mio avviso, il vero problema del turismo non saranno gli aeroporti internazionali, ma le navi da crociera che arrivano già durante l’estate. Durante l’alta stagione attraccano in Groenlandia un paio di navi al giorno con a bordo circa 3.000 passeggeri.
Questo in primo luogo disturba la vita marina, e i pescatori sono costretti a portare le proprie barche molto più al largo per riuscire a catturare qualcosa, in secondo luogo comporta un grosso problema di inquinamento dovuto a litri e litri di carburanti che le navi rilasciano nell’oceano. I turisti che arrivano con le navi da crociera poi visitano la città, ma non spendono soldi nei negozi locali, tornano a bordo per mangiare.
Credo che in ogni caso i groenlandesi non siano interessati al turismo di massa come in Islanda. Siamo più interessati ai turisti che arrivano per la natura, che vengono a scalare una montagna o a stare in tenda in un fiordo.
Dopo Trump però ci sono stati molti americani in città che viaggiano da New York e vengono a trovarci per sapere che paese stanno comprando. Questo è molto spaventoso e penso che la situazione peggiorerà durante l’estate.
Trump infatti ha cercato di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca già nel 2016, quando era presidente, e ora che è stato rieletto ha espresso nuovamente la volontà di “comprare” l’isola per assicurare l’economia degli Stati Uniti. Ma già dopo la Seconda Guerra Mondiale l’America con l’amministrazione Truman aveva offerto alla Danimarca 100 milioni di dollari per entrare in possesso della Groenlandia. Come vivete questa situazione?
Fa paura. Qualche settimana, per esempio, Donald Trump Jr, è arrivato sull’isola con questo enorme Boing nero con la scritta “TRUMP” sulla fiancata e si è fermato per circa quattro ore poi è andato via.
È l’era dei miliardari in America e nel mondo. Penso ci saranno molti turisti di questo tipo che verranno in Groenlandia. Prima dell’aeroporto di Nuuk, non c’era traccia di turisti miliardari. Veniva ogni tanto Leonardo DiCaprio, ma non lo vedevamo in città perché l’aeroporto era chiuso e completamente diverso.
Non so come influirà sulla nostra economia, ma con Trump è tutto molto spaventoso. Perché lui non scherza. E approfitta delle nostre complicate relazioni con la Danimarca, che comunque è un Paese molto, molto piccolo rispetto agli Stati Uniti. A Trump non importa di nulla e di nessuno. Non so se sia effettivamente possibile per lui comprare la Groenlandia, ma ha molto potere, ed è terrificante che sia così vicino e che stia facendo così tanta propaganda negli Stati Uniti. Ma abbiamo voi e deve pur valere qualcosa.

La cover di questo articolo è uno scatto di Angu Motzfeldt.