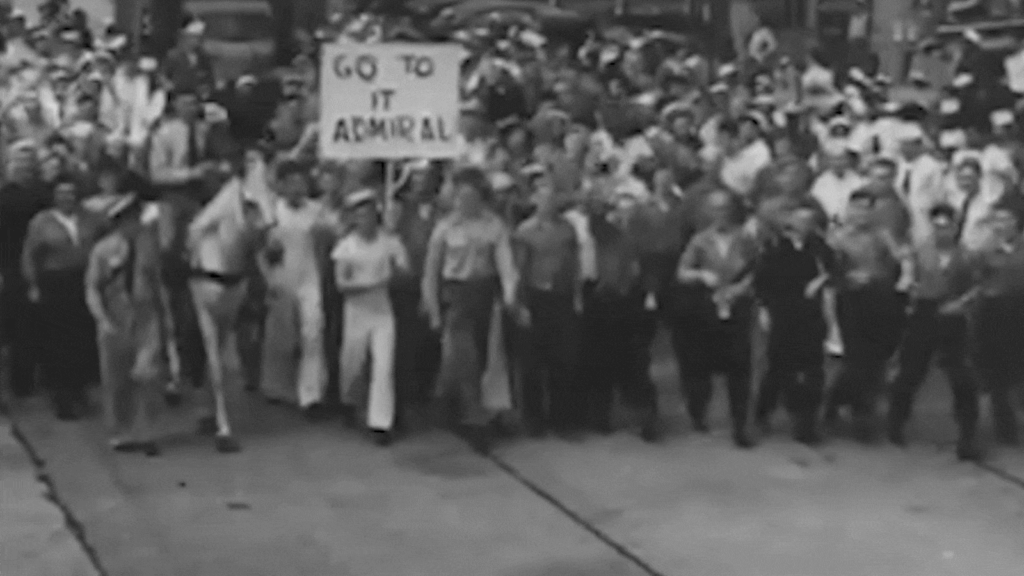Viola Stefanello
La rabbia femminile è ancora un tabù

17 Novembre 2023
La rabbia è un’emozione familiare a tutti, ma che le donne spesso non sono incoraggiate a esprimere. Se le cause sono molteplici, quello che rimane è un senso di frustrazione politico, di genere, personale. Le rage room, luoghi predisposti allo sfogo della rabbia che stanno aumentando nelle città di tutto il mondo, possono aiutare. Forse.
Viola Stefanello
Viola Stefanello è giornalista. Ha collaborato con «Repubblica», «Internazionale» e altre testate. Fa parte della redazione de «Il Post».
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati