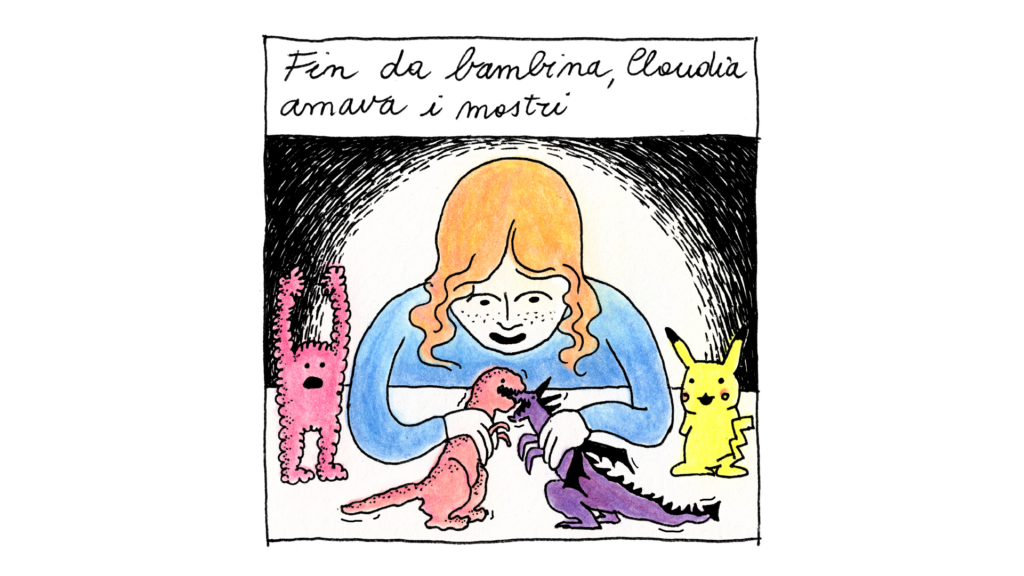Francesca Mastruzzo
La salute mentale delle donne attraverso gli spot degli psicofarmaci

19 Febbraio 2024
Donne soffocate da lavori domestici, mogli infelici con i propri mariti, figlie isteriche, madri esauste. A partire dalla seconda metà del Novecento le pubblicità degli psicofarmaci miravano a curare la frustrazione legata al ruolo di genere femminile attraverso la chimica. Oggi invece cosa cerchiamo di curare con ansiolitici, antidepressivi e antipsicotici?
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati