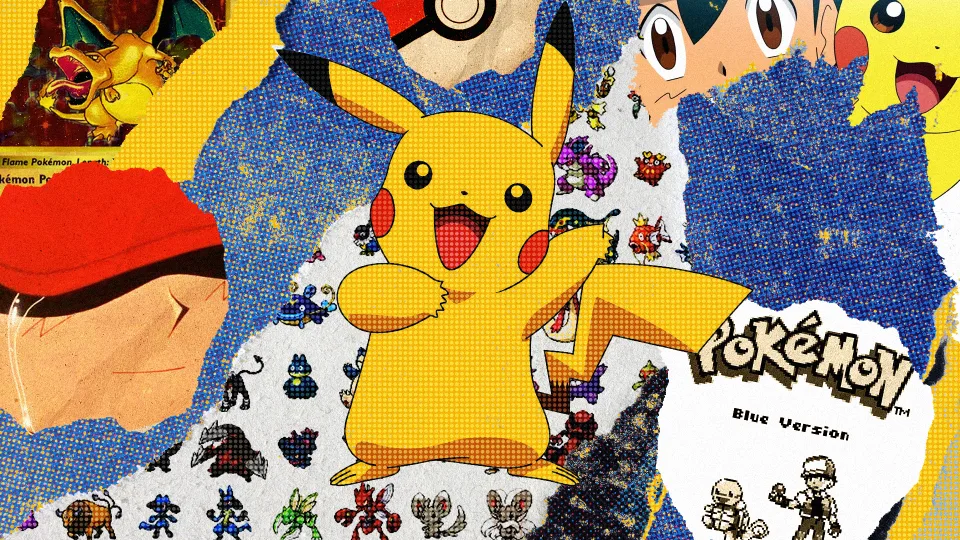La scrittura? È un tradimento. I bianchi? Una noia mortale. Jamaica Kincaid è una delle più importanti autrici al mondo e, come spesso accade con le etichette, quella di “scrittrice postcoloniale” le sta stretta. Che parli del romanzo, della lingua inglese o della sua famiglia, non è mai banale.
La noto subito, è più alta di quanto mi aspettassi e meno eccentrica di quel che mi era stato anticipato. Incontro Jamaica Kincaid sotto i portici di Bologna, mentre entrambe ci dirigiamo verso l’hotel in cui avevamo appuntamento per questa intervista. Non ho avuto molto tempo per prepararla e, come sempre quando non so le cose alla virgola, sono in ansia. Lei sembra non avere a care in the world, con la sua maglietta bianca Team Harry and Meghan, mentre con voce soffice dice che da ragazza non ha mai indossato il rossetto, perché aveva un’idea peculiare di cosa significasse essere una scrittrice: essere seria, seriosa, composta, composita, bando alle frivolezze.
Alla fine di questa chiacchierata, tra un’ora, mi chiederà quanti anni ho, e mi risponderà che sembro così giovane — ci separa quasi mezzo secolo, eppure le persone come me, o noi, come dirà più avanti Kincaid sono ancora incredibilmente consapevoli del proprio aspetto e della percezione che può generare il modo in cui è agghindato. Tutte le nostre madri sapevano cucire, come le nostre nonne, del resto il vestito giallo con cui si apre l’ultimo libro di Kincaid tradotto in Italia è stato realizzato proprio da sua mamma, e sarà lei stessa, anni dopo, a cucire “insieme a mano il pizzo nero e grigio” per il costume di contessa di Dracula della figlia. Insomma, avere il vestito appropriato — qualunque cosa rappresenti — è un’idea che mi è stata cucita addosso. Disfarsene non è mai stato semplice.
Quando ci occupiamo della migrazione con una prospettiva familiare, non è possibile non notare un filo rosso di legami madre-figlia spezzati. Mi sembra che questo, in generale, sia evidente nella letteratura femminile caraibica. E in Autobiografia di mia madre tu introduci la nozione di un legame inesorabile tra una madre che incarna una parte della storia e persino del futuro della figlia. Mi chiedo quale sia il ruolo del linguaggio in questo genere di relazione — della madrelingua: la relazione di Xuela con sua madre sembra essere il risultato dell’alienazione dalla propria madrelingua, il Creolo. È quasi un’interpretazione letterale del concetto di madrelingua.
Quando pensiamo al colonialismo più in generale e alla soggiogazione di un popolo da parte di un altro, quale lingua dovremmo usare per parlare di questi eventi politici? Se non ricordo male è stata Audre Lorde ad aver detto che non puoi usare la lingua dei padroni per smantellare la casa dei padroni. Non lo contesto, ma penso che se ti preoccupi troppo della lingua, finisci in un altro guaio. Bisogna utilizzare la lingua che si conosce, che è possibile fare propria, che puoi plasmare. Penso che ci sono così tante lingue nei Caraibi che sono una mescolanza tra quelle europee e differenti dialetti. Quindi io non mi faccio prendere molto dall’uso della lingua perché puoi sempre far sì che significhi ciò che vuoi che dica. Ma il linguaggio tra una madre e una figlia — quello si rivela essere piuttosto universale, dal momento che gran parte del mondo, gran parte della civilizzazione sembra essere patriarcale. Così anche la comunicazione madre-figlia è influenzata dal patriarcato. Non mi occupo davvero di quello, del patriarcato. Eppure è un fatto che ciò che accade in una relazione madre-figlia è determinato dalla cultura in cui credono: la madre vuole, per lo più, che o la figlia segua le regole del patriarcato — che sia per rinforzare quelle regole oppure per rinforzale, perché si adatti ad esse, oppure vi si ribelli senza mettere sé stessa in pericolo.
“Lei sembra non avere ‘a care in the world’, con la sua maglietta bianca ‘Team Harry and Meghan’, mentre con voce soffice dice che da ragazza non ha mai indossato il rossetto, perché aveva un’idea peculiare di cosa significasse essere una scrittrice”.
Direi che nel mio caso la lingua è stata molto influenzata dal modo di agire inglesi, che erano patriottici.
Qual è il tuo rapporto con l’inglese?
Assolutamente perfetto, andiamo decisamente d’accordo.
Ma la consideri la tua madrelingua? E come il tuo inglese comunica con le lingue pidgin o il creolo, o gli altri tipi di inglese?
Questa è una domanda molto interessante. Perché mio nipote era venuto a trovarmi l’altro giorno, e stavamo parlando della nostra famiglia, e io ho ripetuto qualcosa che mio fratello, che è morto, mi aveva detto. Lo stavamo prendendo in giro, e io sono scivolata nel patois, nel broken English. Mio nipote ha riso, dicendo che era la prima volta che mi sentiva parlare in quel modo, e davvero penso di non sapere più parlare così. Quando ritorno in Antigua, devo allenare il mio orecchio a sentire perché ci sono tutti questi modi che le persone hanno di chiamare le cose che io ho dimenticato, o che loro hanno inventato di recente. Non mi rende triste, nulla di simile, è solo che, beh, non so più come funziona.
Per gran parte della mia infanzia mi è stato insegnato a non parlare il broken English — lo definivamo un cattivo inglese, in francese lo chiamano patois o creolo. Mia madre, che veniva da Dominica, che è stata un dominio francese fino al diciannovesimo secolo credo, quando è diventata inglese, ma hanno continuato ad avere un patois francese, può parlare con persone provenienti da Guadalupe o Martinica. Sai, ritengo che il linguaggio sia una di quelle cose utilizzate contro di noi, e che ci fanno pensare di dover intraprendere un percorso verso la purezza e l’espressione di noi stessi.
Quando ho lasciato casa, mia madre mi ha detto di parlare in questo modo, di parlare come se fossi in una un programma radio della BBC. Ora non posso più liberarmene, e questo è persino il modo in cui penso.
Pensi che all’inizio fosse una sorta di performance linguistica?
Lo si può dire ora, ma allora non era quello che avevo in mente, ero solo impaziente di sopravvivere, desiderosa che le persone mi capissero.
Devo confessare che la premessa a questa intervista è che di recente ho letto una raccolta di racconti dell’autore vietnamita Nam Le, intitolata The Boat. Ecco, la storia metanarrativa con cui si apre vede protagonista lo stesso Nam Le, uno scrittore che cerca di rispettare una deadline dell’Iowa Writers Program e allo stesso tempo sta tentando di raccontare il passato traumatico in Vietnam del padre. L’autore si chiede, in questo processo, se non stia svendendo “la cosa vietnamita”, la cultura e il passato, se non li stia sfruttando. Mentre lo leggevo, mi è venuto lo stesso dubbio: mi chiedevo se ti sei mai posta il problema, se te ne sei mai preoccupata.
Uno scrittore è un traditore. Quando ti siedi a scrivere, stai tradendo. È il motivo per cui uccidono gli scrittori: non uccidono i fioristi, neppure i dentisti, e neanche ogni altro genere di lavoratore. Ma la scrittura, nella sua interezza, è sacra — e non devi fedeltà a niente e a nessuno, se non alla tua scrittura. E, in ogni caso, il primo errore che ha fatto lo scrittore vietnamita è partecipare al workshop in Iowa.
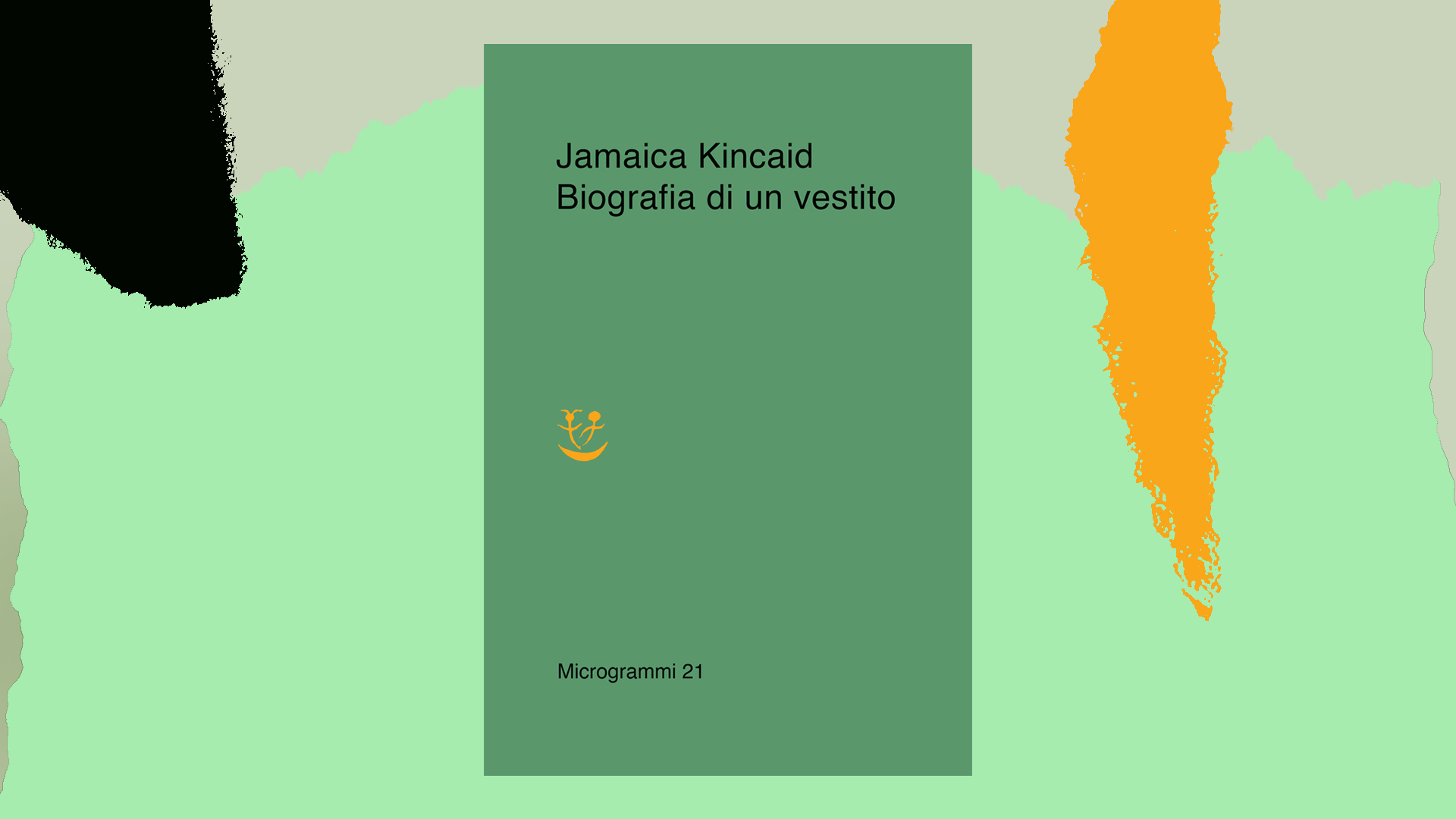
Perché la pensi così?
Perché nessuno ti può insegnare come scrivere, no? Ho appena scoperto che [Giorgio] Morandi diceva di non poter insegnare [“l’Arte”]. Perché la scrittura non si insegna, viene da dentro. Ma poteva insegnare l’incisione [all’acquaforte], perché è un meccanismo, una tecnica. Invece andare a un corso di scrittura creativa è l’inizio della tua rovina — e sono sicura che l’idea di tradire, non tradire, di cosa è giusto arrivi dagli stupidi corsi di scrittura creativa. Quando scrivo, uso qualunque cosa. Se mi trovassi bloccata nel finire una frase e il diavolo in persona si presentasse per dirmi “Se mi vendi la tua anima, ti aiuterò,” io gli venderei la mia anima.
“Quando ritorno in Antigua, devo allenare il mio orecchio a sentire perché ci sono tutti questi modi che le persone hanno di chiamare le cose che io ho dimenticato, o che loro hanno inventato di recente”.
L’unica ragione per andare in una di quelle scuole, è per avere qualcosa che ti supporti quando sei giovane. È invece sempre più difficile per i giovani trovare il coraggio di essere poverigiovani. Bisogna avere il coraggio di essere poveri, di non avere cose belle, di non avere un bel frigorifero, vestiti alla moda, e tutte quelle cose lì. La scrittura non ha a che fare con il comfort.
Il fatto è che scrittori provenienti da alcuni background sembra che siano fortemente incoraggiati a scrivere in un certo modo e di certi argomenti: è questo quello che viene problematizzato da Nam Le. Quindi si trovano a fare un compromesso tra l’essere autentici a sé stessi e il successo commerciale.
La scrittura non ha a che fare con nulla se non con noi stessi. Quindi l’autore vietnamita — sono interessati a quel tipo di storie in questo momento, ma cosa farà quando non lo saranno più: continuerà a scontrarsi con l’assenza di interesse per le storie vietnamite o continuerà a scrivere? Sai, penso che gli afroamericani siano un ottimo esempio per le persone che pensano di provenire da gruppi marginalizzati (e davvero detesto quella parola: marginalizzato da chi — da te stesso o dagli altri? Beh, lascia che marginalizzino, non bisogna partecipare al gioco della marginalizzazione, ma solo essere sé stessi). Nel contesto americano esiste una moda per tutto, e al momento c’è una tendenza per voci diverse. Ed è tutto molto bello, ma non ha nulla a che fare con la scrittura. Cioè, quando ho cominciato a scrivere, non avevo idea che ci fosse una tale richiesta: scrivevo ma non sapevo che cosa fosse il mercato. Ho scritto per questo magazine bianco, scrivevo della mia famiglia e delle persone nere. Non sapevo però che fossero nere, erano soltanto la mia incasinata famiglia. L’idea che qualcosa di così speciale e sacro come la scrittura possa essere parte di una tendenza, è per me qualcosa di orribile, e anche irrispettoso nei confronti dell’atto di pensare, di un intellettuale.
“Per me la narrativa è un arazzo di verità e finzione. Eppure la differenza tra qualcuno come me e uno scrittore europeo è che nessuno chiederebbe a uno scrittore europeo se quello che scrive è accaduto realmente”.
Tu prendi ispirazione dalla tua famiglia, dal tuo passato, dalla tua identità. Se non ricordo male però in un’intervista hai suggerito di non prendere tutto ciò che scrivi per oro colato: potrebbe essere vero, potrebbe non esserlo.
Quello che intendevo quando ho detto così è di non prendere ciò che scrivo come una prova da presentare dinnanzi a una corte. E invece spesso le persone fanno proprio quello, specialmente quando gli scrittori somigliano a me o a te — pensano che non abbiamo davvero un’immaginazione. Non è vero che dipendiamo da qualcos’altro, nella stessa misura in cui non lo era Madame Bovary o Proust non dipendeva dalla madeleine — ma da dove diavolo arrivava la madeleine, quali sono i suoi ingredienti?
In Annie John, il personaggio vive un periodo di transizione in cui è malata per molto tempo. Questo non è accaduto nella realtà, nonostante il personaggio sia basato sulla mia relazione con mia madre. Quella malattia non è accaduta quando avevo undici anni, ma quando ne avevo sette. Ho comunque usato quell’esperienza come fonte d’ispirazione, e questo è il modo in cui io manipolo la realtà ogni volta. Per me la narrativa è un arazzo di verità e finzione. Eppure la differenza tra qualcuno come me e uno scrittore europeo è che nessuno chiederebbe a uno scrittore europeo se quello che scrive è accaduto realmente. Anche quando provengono dall’ex Unione Sovietica o dalla Germania, e sono scrittori che mettono in scena personaggi che vivono una determinata società “chiusa”, nessuno chiede loro — sei tu? Parla di te?
Sì, c’è sempre un impulso a sminuire le persone come noi, a sminuire la nostra immaginazione. Lasciamo che lo facciano, sono così noiose, le persone bianche, solo così noiose. Soltanto le persone che definiscono sé stesse bianche, presenti esclusi.