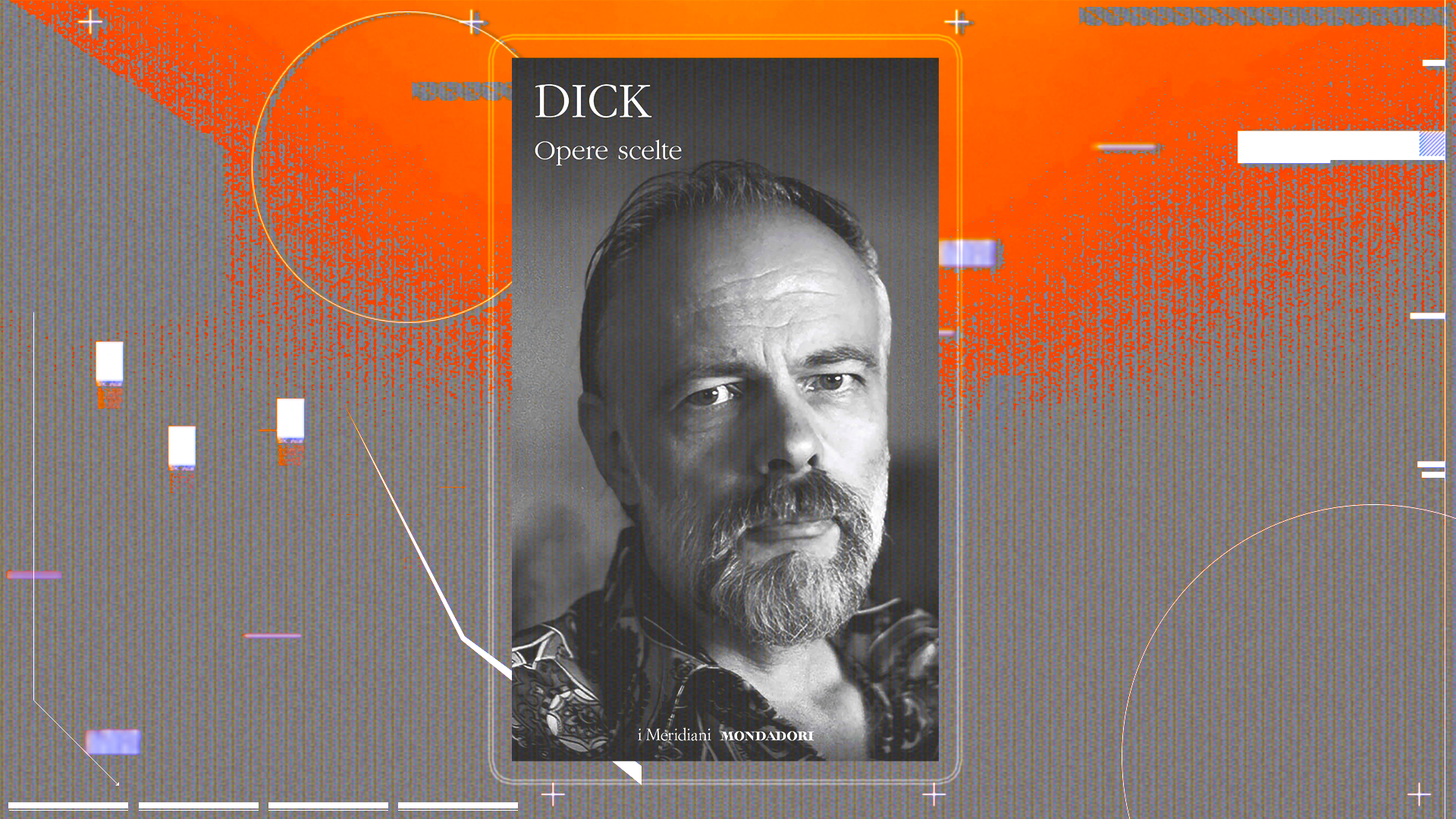Fino a pochi decenni fa l’eventualità che uscisse un Meridiano dedicato a Philip K. Dick era impensabile. Questa pubblicazione epocale ci spinge a interrogarci su come intendiamo il canone oggi e, soprattutto, su come la grande letteratura sia sempre in grado di mostrarci scenari ulteriori.
Dopo l’uscita del “Meridiano” dedicato a Dino Campana, un’altra effrazione s’è prodotta nel continuum del Canone. Se sino a oggi Campana era “fuori”, per la sociopatia terminale di un personaggio perseguitato in vita da una serie traumatica di esclusioni, la sua poesia da un pezzo era “dentro”, avendo nutrito di sé tanta parte della migliore lirica successiva. Pubblicare nella collana ammiraglia della nostra editoria Philip K. Dick, invece, impone una riflessione su cosa siamo arrivati a considerare “letteratura” oggi, e cosa si considerava tale non più d’una ventina di anni fa. Per la mia generazione è semplicemente un sogno pensare che esista un “Meridiano” (due, anzi!) di Philip Dick. Forse non è un caso che la data d’uscita sia stata fissata al primo aprile; mentre parlo col suo curatore il libro di carta non l’ho ancora visto, e magari si deve solo a un’allucinazione, perfettamente dickiana, l’annuncio di Mondadori che tanto mi ha emozionato.
A testimoniare lo statuto mutato dell’autore, la cura minuziosa (come da tradizione di collana) di un’edizione che nelle premesse poneva non pochi problemi filologici (e già fa strano parlare di “filologia” per uno come Dick). Chi ha letto Dick – o ne è stato psichicamente invaso, piuttosto – negli anni Settanta (come Trevi) od Ottanta (come me), lo ha fatto collezionando, in qualche caso raccattandoli dall’immondizia, i vecchi “Urania”: libretti esili e spiegazzabili, dalla carta ruvida e grigiastra, la cui memorabile grafica di copertina è stata celebrata dalla penna di Michele Mari, ma che a posteriori non si potevano certo considerare dei modelli di accuratezza testuale: per rientrare nel format interi capitoli venivano tagliati, sunteggiati o proprio bellamente saltati, con la conseguenza che certe trame dickiane – già di per sé intermittenti e bucherellate – diventavano del tutto incomprensibili.
Una revisione complessiva di quelle traduzioni era già stata proposta, per le cure di Carlo Pagetti con la collaborazione di Luca Briasco e Mattia Carratello, dall’editore Fanucci fra il 2000 e il 2017 (lo stesso Fanucci nel 2015 s’è sobbarcato l’edizione italiana della monumentale antologia curata da Pamela Jackson e Jonathan Lethem dell’Esegesi: milletrecento pagine sulle ottomila totali di autocommento alla propria opera, iniziato da Dick all’indomani della visione da lui chiamata “2-3-74”), impostata dunque prima della consacrazione (e della revisione appunto filologica) rappresentata dall’edizione in tre volumi delle opere di Dick nella Library of America, curata da Lethem fra il 2007 e il 2009. Anche su questa base, a partire dal 2021 il lavoro è stato continuato da Mondadori con una serie di cinque “Oscar” ritradotti da Marinella Magrì e confluiti nel “Meridiano” (L’uomo nell’alto castello, Le tre stigmate di Palmer Eldritch, Gli androidi sognano pecore elettriche?, Ubik e Scorrete lacrime, disse il poliziotto), appositamente per il quale sono stati ritradotti altri quattro romanzi (Occhio nel cielo, Valis, L’invasione divina e La trasmigrazione di Timothy Archer) da Paolo Parisi Presicce: che firma una minuziosa bibliografia di più di cento pagine e, insieme a Emanuele Trevi, le centocinquanta di Notizie sui testi. Bonus non da poco dell’edizione, poi, sono le quaranta pagine di Cronologia di Emmanuel Carrère, desunte – scrive lui – dalle ricerche fatte nei primi anni Novanta in vista di Io sono vivo e voi siete morti (Theoria 1995, Adelphi 2016). Ma qui mi preme soprattutto parlare del saggio introduttivo, cento pagine firmate da Emanuele Trevi.
Andrea Cortellessa: Il nodo delle traduzioni è un buon modo per affrontare il tema dello statuto di Dick. Già l’edizione Fanucci recuperava una traduzione “d’autore”: quella di Un oscuro scrutare (A Scanner Darkly, 1977) fatta per Cronopio, nel 1993, da Gabriele Frasca (poi fra il molto altro curatore di Beckett nei “Meridiani“). Fu quello – almeno per la nostra cultura letteraria – il primo segnale di una possibile ascrizione di Dick alla “letteratura”. Almeno così lo presi io allora (devo aver letto quel libro, che mi era sfuggito nell’accanito fandom adolescenziale, più o meno quando venni folgorato dalla poesia di Gabriele – con Lime dunque, che è del ’95). Ora quella versione (insieme a quella di Gianni Pannofino di Tempo fuori luogo) completa il canone del “Meridiano” (undici romanzi su un totale di una cinquantina, purtroppo invece nessuno dei 135 racconti censiti: alcuni dei quali sono dei veri capolavori, come Impostore o Essere un Blobel).
Emanuele Trevi: Io invece l’ho letta da Fanucci, nel ’98; ma è vero, a posteriori quella traduzione ha rappresentato una soglia.
AC: Per me la soglia fu, nell’82, Blade Runner. A quattordici anni ero già un devoto di “Urania”, ma quel film lo vidi dodici volte di seguito (non lo stesso giorno, certo, ma nel giro di un paio di settimane… lo programmava la sala parrocchiale davanti al mio liceo a San Lorenzo, gestita dall’insegnante di religione col quale discutevo accanitamente per ore; oggi quella sala è il Tibur, un “normale” cinema di prima visione). Da quel momento Dick s’installò al centro del sistema.
ET: Certo, quel film fu un evento; lo annunciò la rivista di Sparagna, «Frigidaire», creando un’attesa spasmodica in tutto il mondo underground. Ricordo che a Roma, al cinema Empire, ebbero l’idea geniale di farne un’anteprima dopo la proiezione di un film “normale” (Firefox, volpe di fuoco con Clint Eastwood, una roba stupidissima da guerra fredda). Lethem ha raccontato la stessa storia in un cinema di Brooklyn. A vederlo andava la stessa gente che si vede su YouTube ai corsi di Deleuze a Vincennes, gli scoppiati anni Settanta, i punkettoni, quelli che andavano ai concerti di Lou Reed o dei Cure, la fauna descritta da Tondelli in Un weekend postmoderno. Non a caso i terreni di coltura della prima vera popolarità di Dick sono stati la Francia (il famoso convegno di Metz del ’77, di cui tanto parla Carrère nel suo libro) e l’Italia.
Certo Dick non è il solo autore notevole nel campo della fantascienza, però mi fa riflettere il fatto che la generazione di Lethem, che è poi la stessa di Carrère, di Mari e anche la mia, abbia letto Dick prima di quel film, rovistando nelle bancarelle e nelle edicole… io quegli «Urania» e quei «Millemondi», con le famose copertine di Karel Thole, li ho salvati da tutti i traslochi. Certo, dopo il film di Scott è cambiato tutto, ed è un peccato che Dick non lo abbia visto; fa in tempo a vedere una ventina di minuti di girato e lo apprezza, con qualche normale ambivalenza. In fondo il romanzo dal quale è tratto, Do the Androids Dream of Electric Sheep?, è molto più di fantascienza del film, l’intuizione fondamentale di Ridley Scott è stata quella di farne un noir, un crossover di generi…
AC: … Scott enuclea dall’immaginario di Dick quella componente postmoderna che tu sottolinei nell’introduzione ai “Meridiani”. Non a caso a lui sin dagli anni Sessanta si appassionano personaggi come Thomas Pynchon (che nel ’73 ricalca Tempo fuori luogo nell’Arcobaleno della gravità) e Fredric Jameson. Come dici tu, riletti con occhi postmoderni anche i libri più scassati di Dick possono rientrare in questa archeologia.
ET: Prima del film di Scott, e prima della morte di Dick (marzo ’82), lo statuto della fantascienza era inimmaginabile per i parametri odierni. Una persona per la quale ho nutrito grande ammirazione, Elémire Zolla, lo avrebbe certo potuto apprezzare, ma lui – come altri miei amici di quella generazione, i Citati, i Garboli e i Siciliano – non ci pensava nemmeno, a leggere una roba del genere.
Prima ancora delle traduzioni, era la stessa lezione dei testi a necessitare di una revisione. Un episodio incredibile è quello dell’edizione francese di Scorrete lacrime, disse il poliziotto (1974, da noi inizialmente tradotto come Episodio temporale), che si basava su una versione provvisoria del testo, mandata per sbaglio all’editore dall’agente di Dick. Per quanto riguarda «Urania», però, vorrei spezzare una lancia per il lavoro pionieristico, già alla fine degli anni Cinquanta, di Fruttero & Lucentini (nonché per quello dell’altro pioniere, l’editore Nord, che negli anni Settanta e Ottanta fece traduzioni fondamentali di libri come Do Androids Dream of Electric Sheep? e appunto Flow My Tears, The Policeman Said). Già allora s’intuiva il significato “letterario” di questi libri; e indicativa in tal senso era già l’evoluzione delle edizioni originali: la confezione di The Man in the High Castle, nel ’62 da un editore di tutto rispetto come Putnam, non ha più nulla del Grand-Guignol “pulp” dei libri precedenti. La soglia è fondamentale: Dick è reduce da un momento di totale disperazione e frustrazione, si vede recapitare dall’agente una montagna di dattiloscritti, i suoi romanzi mainstream rifiutati da tutti gli editori, e con uno dei suoi colpi di testa decide di occuparsi di gioielleria (ne resta traccia nella trama dell’Uomo nell’alto castello) abbandonando la scrittura. Ma lui è come Kafka o Flaubert, scrivere è l’unica cosa che può fare. L’edizione simil-mainstream dell’Uomo nell’alto castello non ha il successo sperato ma vince il premio Hugo, il Pulitzer della fantascienza; a quel punto gli editori specializzati tornano alla carica, ripubblicano gli altri libri e cominciano a considerarlo un classico in vita. Inizia da lì il viaggio che avrebbe portato Dick sino al monumento della Library of America.
AC: Cronologia di Carrère a parte, anche il tuo Profilo di Philip K. Dick intreccia la sua opera alla biografia dell’autore, mostrando come diversi personaggi siano modellati su certi tratti del suo carattere, e questo ben prima che nell’ultimo periodo – nella cosiddetta Trilogia di Valis, pubblicata negli ultimi due anni di vita – autore e personaggio tendano a fondersi in quella che, più che un’immedesimazione, è una vera e propria transustanziazione. Un aspetto fondamentale della sua storia psichica è proprio la percezione di sé, da parte di Dick, come autore. Sino a The Man in the High Castle, Dick si percepiva come un “artista di merda” (Confession of a Crap Artist, scritto nel ’59, viene pubblicato con questo titolo nel ’75), prigioniero delle convenzioni della fiction “di genere” nonché del culto appiccicoso del fandom, e cercava di sfuggirne scrivendo in parallelo una serie di romanzi “realistici”, quelli che definiamo mainstream, quale è appunto Confessioni di un artista di merda. Viveva una scissione insomma fra un sé ideale, il narratore esistenzialista californiano, e un sé tristemente reale, lo sfigato scrittore “di genere” pagato pochi centesimi a parola dalle riviste pulp. Invece noi oggi pensiamo che la prima fosse un’ambizione bovaristica e ben poco “realistica”, mentre quello che amiamo è lo scrittore visionario e fuori di testa che, sino a un certo punto, disprezza sé stesso. Negli anni Sessanta questa scissione, se non una riconciliazione definitiva, conosce diciamo un’omeostasi (che prevede sempre intermittenze, ronzii e rumori di fondo, bucherellamenti vari) e Dick, insomma, comincia a prendersi sul serio. Cura maggiormente la scrittura, si documenta meglio, dismette i ritmi di scrittura forsennati del decennio precedente, e significativamente smette di scrivere romanzi mainstream. Poi, a partire dalla Visione del febbraio ’74, c’è un ulteriore giro di vite: da quel momento in avanti Dick non solo si percepisce come uno scrittore a pieno titolo, ma anche come il depositario di Verità Nascoste da rivelare al mondo. Questi tre stadi nella percezione di sé mi pare individuino anche tre fasi precise della sua opera.
“Chi ha letto Dick – o ne è stato psichicamente invaso, piuttosto – negli anni Settanta (come Trevi) od Ottanta (come me), lo ha fatto collezionando, in qualche caso raccattandoli dall’immondizia, i vecchi ‘Urania’: libretti esili e spiegazzabili, dalla carta ruvida e grigiastra, la cui memorabile grafica di copertina è stata celebrata dalla penna di Michele Mari”.
ET: È una buona periodizzazione. La fase giovanile è segnata da una grande ingenuità: nel decennio che va dall’esordio nel ’52 alla pubblicazione dieci anni dopo dell’Uomo nell’alto castello (da noi circolato col titolo, secondo me bellissimo, La svastica sul sole), avendo già un crescente consenso come scrittore di fantascienza, Dick coltiva l’equivoco di albergare dentro di sé una specie di compagno segreto infelicissimo che vorrebbe invece fare della “letteratura”, e si nutre di Sartre, Dos Passos e Steinbeck con un’idea di un realismo esistenzialista che troverà poi autori ben più convincenti di lui nel John Williams di Stoner e nel Richard Yates di Revolutionary Road (anche lui ebbe poca fortuna in vita, ma per noi oggi il suo libro è il Madame Bovary della letteratura americana). Ma per questo tipo di scrittura Dick non ha un senso della forma adeguato, ha ragione Mattia Carratello a definire “opachi” i suoi libri mainstream: opaca è la vita della piccola borghesia americana frustrata del dopoguerra, ma opaca è anche la scrittura del narratore che la ritrae. Non si rendeva conto, a quel tempo, che il suo campo d’azione non è il mondo com’è, ma il mondo come potrebbe essere. È questo che accende la sua scintilla poetica: investire la realtà di un dubbio ontologico. È davvero reale quella che consideriamo “realtà”? E sono davvero io quello che credo di essere?
La soglia successiva è quella delle visioni dalle quali viene visitato Dick nel febbraio-marzo del ’74. Possiamo chiamarle allucinazioni oppure considerarle vere esperienze mistiche: la vita del mistico ruota sempre attorno a quello che Paul Celan definisce un «meridiano», un perno del tempo che discrimina la sua vita fra un prima e un dopo. Dick si convince di essere entrato in contatto con un’Entità divina che si manifesta all’inizio con un raggio di luce rosa, e che gli rivela una serie di Verità: che noi viviamo ingannati da quello che gli Gnostici chiamano il “dokos”, il grande inganno percettivo intessuto dal Cattivo Demiurgo, un velo di Maia che ci impedisce di vedere che siamo rinchiusi, in realtà, in una «prigione nera di ferro». In questo Dick era un vero gnostico, la salvezza per lui non viene dalla Redenzione bensì dalla Conoscenza (la Gnosi trasforma Cristo da Redentore a Maestro – il che spiega come mai non abbia fatto breccia nei cuori dei popoli, è una religione di filosofi). Spiega Dick nell’Esegesi come quel segnale divino fosse stato preceduto da una serie di annunci oscuri: appunto i romanzi di fantascienza da lui scritti sino ad allora.
AC: È convincente il parallelo che fai con Pasolini. Comune ai due è l’idea “figurale” con la quale a un certo punto rileggono la propria opera passata quale profezia di verità – trascendenti o politiche, o le due cose insieme… – destinate a essere scoperte solo in seguito. Gli anni Cinquanta, quelli della giovinezza di entrambi, rivelano a posteriori la loro natura illusoria (è il mondo di Tempo fuori luogo, come verrà ripreso da Peter Weir e Andrew Niccol in The Truman Show).
ET: Le autoesegesi sono sempre tendenziose, spesso in cattiva fede, e il critico deve maneggiarle con circospezione. Una delle letture per me più formative, all’Università, fu il commento di Domenico De Robertis alla Vita Nova, che faceva capire come una cosa fossero i sonetti giovanili, e ben altra la loro autointerpretazione da parte di Dante. Forse l’esempio più impressionante sono le Prefazioni di Henry James per la New York Edition delle sue opere. Dick passa dallo statuto di Messaggero Inconsapevole a quello di Iniziato. Scrive nell’Esegesi: “invece che leggere: Ubik, di Philip K. Dick, mettiamola in questo modo: Philip K. Dick di Ubik. In un certo senso sto scherzando, ovviamente, ma in un altro no”. E poi: “io non scrivo i miei romanzi nel vero senso della parola: essi provengono da qualche parte di me che non sono io”.
Le autointerpretazioni di Dick sono talvolta geniali, e Paolo Parisi Presicce e io le abbiamo riportate con abbondanza nel commento, lasciando al lettore la possibilità di procedere nella lettura come seguendo le tappe di una rivelazione progressiva. Non posso non chiedermi in prima persona, però, se debba accettare questa prospettiva. E se nell’introduzione mi permetto un atteggiamento diciamo scettico è anche perché ho capito quanto fosse scettico, al riguardo, lo stesso Dick.
AC: Questo mi pare l’aspetto più nuovo della tua interpretazione. Ricordo che più grandicello, avrò avuto ventisei o ventisette anni, andai ad ascoltare Fredric Jameson che teneva una conferenza su Dick a Roma. Dovevo avere appena letto Un oscuro scrutare nella traduzione di Frasca e che uno come Jameson, già allora per me fra i massimi punti di riferimento teorici, si appassionasse a sua volta a Dick rappresentava una conferma. Ad ascoltarlo ci saranno state sei o sette persone. La sua era una lettura brillante del primo capolavoro di Dick, L’occhio nel cielo (Eye in the Sky, 1957), in cui il paradiso concepito dalla mente di un personaggio corrisponde all’inferno di quello degli altri coi quali è in una sorta di comunione telepatica. Alla fine della conferenza, gli obiettai che nel suo discorso non citava mai gli ultimi romanzi di Dick, la Trilogia di Valis, in cui di religione si parla in modo esplicito e tutt’altro che parodico. Lui rispose che Dick quei romanzi li aveva scritti dopo essere impazzito, e dunque non andavano considerati testi letterari ma meri documenti da cartella clinica. Mi ritirai in buon ordine, e mi sorprese che poi il grande Jameson venisse a cercare quello studente sbruffoncello per raccomandargli di non leggere più quell’immondizia. Resta per me un autore fondamentale ma quella sua scelta di campo mi pareva, e mi pare, davvero miope (solo tanti anni dopo, leggendo l’Esegesi, vidi che lo stesso Dick se la prendeva coi “marxisti” attoniti per le sue preoccupazioni metafisiche – mi chiedo se non si riferisse proprio a Jameson –: “mi sono dimostrato un idiot savant e questo li ha disgustati molto”).
ET: È una scemenza. Ammesso e non concesso che la Visione di Dick sia stata indotta da un’alterazione psichica, è come se ci rifiutassimo di leggere le Poesie della Torre di Hölderlin, o più o meno tutto Artaud! Jameson è stato un grande critico del Novecento ma, come quasi tutti i suoi pari del resto, tendeva a escludere quanto non rientrava nei suoi schemi interpretativi. Soprattutto non tiene conto della struttura del Doppio nella Trilogia di Valis. A quell’altezza Dick non è più scisso fra l’io ideale mainstream e l’io reale fantascientifico, ma fra l’Illuminato – Nicholas Brady, o Horselover Fat – e un deuteragonista chiamato “Philip Dick”, che nega la verità della rivelazione sostenendo che funziona benissimo, invece, come spunto per i suoi romanzi.
AC: E in effetti non prende mai le parti né dell’Illuminato né dello Scettico.
ET: Nella Vana fuga dagli dei c’è un saggio di James Hillman sulla paranoia, dove si dice che in fondo non è possibile distinguere fra la “rivelazione” e il “delirio”. Non è facile spiegare perché alcuni hanno fondato delle religioni, e altri sono finiti in manicomio. Il libro più bello di Carrère è quello su San Paolo, Il Regno, dove l’uomo è solo con la sua rivelazione, e non sa nemmeno lui se è pazzo o se davvero è entrato in possesso di una verità. L’unica cosa di cui è certo è il dovere di rivelarla. A questo dilemma di Paolo, Carrère arriva attraverso quello di Dick.
AC: Anche in questo si può trovare una somiglianza con Pasolini, un altro fissato con Paolo di Tarso… A un certo punto del suo obituary in morte di Dick (nella parte colpevolmente non tradotta da Feltrinelli, del suo Archaelogies of the Future del 2005), parla Jameson della sua capacità di “interpretare la storia” illustrando fenomeni già esistenti al suo tempo (il consumismo, il “tardo capitalismo”, quella che Debord chiamerà la “società dello spettacolo”), e in generale della capacità della fantascienza non di ritrarre “inimmaginabili futuri” bensì “il nostro presente storico” (quello cioè che verrà raccontato dagli storici del futuro). Sicché paradossalmente il vero scrittore “realista” non è quello mainstream, ma il visionario che dubita di sé stesso e delle sue rivelazioni. Un anno prima della morte, nell’81, Dick scrive una Definizione di fantascienza (è nella raccolta curata da Lawrence Sutin dei suoi saggi, Mutazioni, tradotta da noi da Feltrinelli nel ’97) che la riconduce a uno “shock del riconoscimento negativo”. Non lo dice, ma la formula capovolge lo Shock of Recognition di Melville: proprio perché non riconosciamo la realtà fattuale delle cose raccontate da Dick, per contrasto formuliamo mentalmente un’immagine più o meno fededegna di quanto quel racconto nasconde e, così, insieme rivela.
ET: Pensa a quanto è stato importante per Dick un testo come l’I Ching. Ancora oggi, e non solo in Cina, viene consultato per predire il futuro; ma in verità l’I Ching è un’immagine del momento presente, ti fa capire chi sei nel momento in cui ti poni quella domanda. L’aspetto predittivo è del tutto accidentale e illusorio, così come l’idea che la fantascienza sia “letteratura d’anticipazione”. È solo per caso che un racconto descrive qualcosa che si verificherà in seguito. Ricordo che ai tempi dell’ondata cyberpunk si elogiava Bruce Sterling perché in un suo libro aveva previsto il movimento No global. Ma scrittori come lui, o come William Gibson (tutti figliocci di Dick, comunque), sono interessanti a prescindere dalla realizzazione o meno di quello che hanno previsto.

AC: A proposito di profezie o pseudo-profezie, devo dirti che ogni volta che appare in scena Elon Musk vedo realizzarsi l’incubo di Palmer Eldritch. Anche in questo caso, però, non si trattava di profetizzare l’autocrate turbocapitalista, il tecnofascista del XXI secolo, ma di enucleare dinamiche già presenti negli anni Sessanta, e che sarebbero esplose nei decenni successivi. È la vocazione paradossalmente “realistica” di cui parla Jameson. Fai notare l’analogia fra uno dei più celebrati racconti di Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano, e l’immaginario di Dick (il quale poteva averlo letto alla fine degli anni Quaranta, quando lo traduce in inglese l’amico Tony Boucher), ma con una differenza fondamentale: l’universo gnostico di Borges è integralmente metafisico mentre nella fantascienza, e in Dick in particolare, “ogni conoscenza è un’arma, e dunque un potere, che sia o no consapevolmente esercitato”. Dunque la fantascienza, al di là della sua qualità letteraria, ha una vocazione squisitamente politica (il che, con tutta l’ammirazione, non si può dire di Borges…).
ET: Il protagonista di un racconto di Dick, The Golden Man (da noi tradotto come Non saremo noi), abita tutti i futuri possibili; ma se in Borges questa è un’allegoria della conoscenza, in Dick si tratta di un mutante che può portare all’estinzione del genere umano.
AC: Forse la profezia più interessante che si può trarre dall’opera di Dick è di carattere letterario. Non il mondo che ci mostra Dick, ma il modo in cui ce lo mostra. Si diceva dei tratti postmodernisti da lui anticipati; uno di essi è la presenza del narratore all’interno della trama (un aspetto che riguarda, oltre che Carrère, anche te come autore). Non si può forse parlare di Dick come di un antesignano dell’autofiction, ma certo nei suoi ultimi libri è molto accentuata una dialettica dell’io-che-scrive. La dialettica fra il Profeta inconsapevole e l’Illuminato consapevole si può declinare anche in chiave letteraria: fra lo scrittore che sa cosa sta facendo e quello che, come diceva Debenedetti di Pascoli, fa una “rivoluzione inconsapevole”.
ET: Carlo Pagetti ha interpretato il titolo del romanzo che Dick progettava di scrivere dopo la Trilogia di Valis, Il gufo alla luce del giorno, come l’allegoria di chi è confuso: non essendo abituato a una luce troppo intensa non vede e non comprende quanto accade intorno a sé.
AC: Il gufo sarebbe il Dick illuminato, abbagliato dalla piena luce della rivelazione, che invece si muoveva con più sicurezza quando era immerso nel buio… davvero A Scanner Darkly… pensando a Carrère e alla lezione che ha tratto da Dick, mi pare che tutto ruoti attorno a un interrogativo che tormentava Giorgio Manganelli, un’altra nostra passione comune. Se lo ripete più volte, il Manga, specie nel commentare Yeats (non Richard Yates, William Butler Yeats!), un altro visionario che viaggiava in universi paralleli. Credeva Yeats in quello che scriveva? E, in generale, “che cosa significa credere?”. A Metz si chiedeva Dick come mai tutti gli domandassero se credeva davvero di aver avuto la Visione, e non se quella Visione corrispondeva al vero. Forse la sua grandezza maggiore è stata quella di porre nel modo più potente questa questione radicale: cosa significa, per chi scrive, credere in qualcosa? E per chi legge?
ET: Quello che vedo è allucinazione o realtà? L’una rispecchia l’altra in forma rovesciata, e il soggetto è colui che non sa distinguere fra le due. Il tema del doppio, nella Trilogia di Valis, introduce questo margine di dubbio, con una venatura fortemente ironica. Nella Trasmigrazione di Timothy Archer il soggetto si proietta in una figura femminile, autrice di un romanzo sulla figura di un illuminato (il personaggio che dà il titolo al libro, modellato sulla controversa e allora famigerata figura del vescovo episcopale californiano James Pike). È l’ultimo libro scritto da una persona che muore d’infarto all’improvviso (alla stessa età di Pasolini, cinquantatré anni); se è un testamento, dunque, è del tutto involontario. Però non può non colpire che la parabola di Dick si chiuda così. Accettare la vita significa convivere con questa contraddizione fra delirio e profezia, per dirla con Hillman. Sono due facce della stessa medaglia, ma come nell’I Ching è il movimento della medaglia che conta. Almeno finché siamo vivi.
AC: Questa identificazione col femminile, nell’ultimo Dick, può essere letta alla luce della sua cultura junghiana. La “trasmigrazione” è anche una ricerca dell’Anima?
ET: Più precisamente è la ricongiunzione del polo maschile con quello femminile nel senso che ha studiato Mircea Eliade, la ricerca del divino in forma androgina che tanto affascinava gli alchimisti, l’integrazione in una nuova realtà che Jung chiama sizigia. Nel penultimo romanzo, Divina invasione, il principio maschile della divinità, Manny, deve integrarsi con un principio femminile, Zina.
AC: Non è un caso che è il libro che hai scritto con tuo padre Mario si intitoli Invasioni controllate…
ET: Dice il Cristo gnostico: entrerete nel Regno dei Cieli quando in voi non ci saranno più il maschio e la femmina. Questo sublime filosofo in cui gli gnostici hanno trasformato Cristo predica la sintesi di tutte le contraddizioni. Ma la tradizione alchemica ci mostra che questo processo non ha mai termine: raggiunto il culmine il mondo si ridivide nei suoi elementi, torna alla degradazione necessaria al movimento ulteriore della ruota che risale, non è mai ferma. In Dick non si arriva mai a una “saggezza”, ogni sintesi viene sempre riscomposta nei suoi elementi, non c’è nessun patto con la vita che non sia una somma di ipotesi contraddittorie.
“A proposito di profezie o pseudo-profezie, devo dirti che ogni volta che appare in scena Elon Musk vedo realizzarsi l’incubo di Palmer Eldritch. Anche in questo caso, però, non si trattava di profetizzare l’autocrate turbocapitalista, il tecnofascista del XXI secolo, ma di enucleare dinamiche già presenti negli anni Sessanta”.
AC: È il tema della penultimità, che affascinava anche Gilles Deleuze.
ET: La penultima verità s’intitola un romanzo scritto da Dick nel ’64 e pubblicato tre anni dopo. Se ci fermiamo su una casella, su una sola faccia della medaglia, restringiamo le nostre possibilità di comprendere la realtà. Io per esempio sono portato a identificarmi col contraltare “scettico” della Trilogia; quando leggo della Visione mi sento un illuminista quasi volterriano, mi rifugio in un materialismo ironico; eppure leggere Dick m’induce a un dubbio sistematico, mi costringe a un’ambivalenza che non posso risolvere in modo univoco.
AC: In clausola alla tua introduzione citi una formula bellissima dell’Esegesi, “la vita possibile”. In fondo tutta la letteratura non è altro che l’invenzione di una vita possibile.
ET: Probabilmente l’ultima convinzione di Dick è quella che gli è passata per la testa nel momento in cui è morto. Noi non siamo altro che questo. Qualunque posizione pensiamo di prendere nella vita è invasa, beneficamente aggredita da qualcosa di esterno che ne allarga il perimetro. Ancora oggi, quando incontro persone molto giovani che leggono per la prima volta Le tre stimmate di Palmer Eldritch e Ubik, o anche Valis e La trasmigrazione di Timothy Archer, capisco che questi libri sono dei potenti congegni di liberazione.
AC: Se Dick è un autore politico è perché ci insegna che il possibile, a dispetto di tutto, fa ancora parte del nostro orizzonte.
ET: Ripenso a quello che dicevi di Elon Musk… queste forme agghiaccianti del potere esemplificano l’idea tragica dell’ineluttabilità: che il mondo debba finire nelle mani di questi mostri non-più-umani è una parodia orribile del divenire hegeliano. Con Dick invece si apre sempre, in questa “prigione nera di ferro”, la crepa del possibile. Può sempre darsi che arrivi un’informazione dall’esterno. Magari dubbia, magari incredibile, ma c’è sempre qualcuno che ha il coraggio di raccoglierla, e trasmetterla a sua volta.