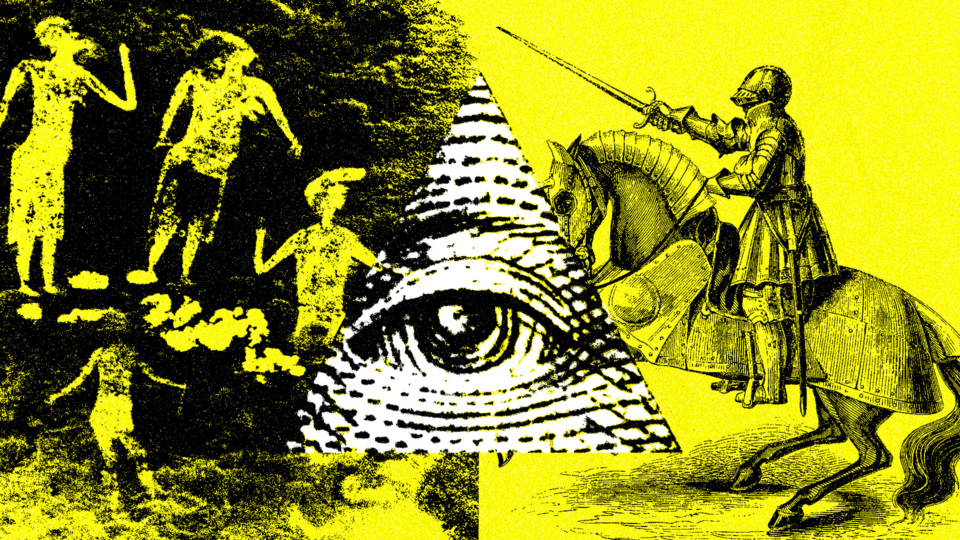Siamo narratori nati e con le storie abbiamo costruito le civiltà umane. In epoca di fake news e complotti sempre più popolari, questa capacità sembra però ritorcersi contro di noi e minare la stabilità delle società contemporanee. Come se ne esce?
C’era questa tempesta che stava arrivando a quel punto è intervenuto il Governo, con quelle cose che fanno… usano queste tecniche di inseminazione delle nuvole per rendere le tempeste più forti, perché quella è una zona dove forse volevano estrarre del litio, una cosa in cui potrebbe avere degli interessi il marito di (Kamala) Harris…
Questa storia (qui riassunta per ragioni di spazio, ma ne potete ascoltarne un resoconto più approfondito qui e altri dettagli collegati qui) è stata raccontata da una sostenitrice di Donald Trump a un giornalista del «New York Times» che le chiedeva un’opinione sulla risposta del Governo statunitense all’emergenza dell’uragano Milton. “Ma ci crede veramente?”, ha incalzato il giornalista. “Sì certo, lo sanno tutti”.
Fake news e teorie del complotto assumono quasi sempre la forma di narrazioni avvincenti, in cui appaiono i buoni, in questo caso Donald Trump, i cattivi, Kamala Harris, e il “conflitto”, ovvero gli interessi economici a spese della vita umana. “La struttura ideale di una storia prevede un protagonista che viene presentato all’inizio, di solito qualcuno che abbia elementi che ce lo rendono piacevole – una persona onorevole, o attraente e di bell’aspetto”, mi spiega Anne Hamby, professoressa associata del Dipartimento di Marketing dell’Università di Boise, negli Stati Uniti, autrice di alcune ricerche sulla struttura narrativa della disinformazione. “Il nostro protagonista poi va incontro a qualche conflitto. Il resto della storia racconta come l’eroe supera le difficoltà. Alla fine tutto si risolve e lui ne esce vincitore”.
Ma la struttura descritta da Hamby, con variazioni e altri elementi tipici, si ritrova praticamente in ogni storia che incontriamo, che sia un romanzo, un film, una serie televisiva, oltre che in miti e favole antiche. Tra i primi a illustrare questa struttura e i suoi elementi fu Vladimir Propp, studioso del folklore che si basò sull’analisi del corpus delle fiabe tradizionali russe. I risultati di questi studi vennero pubblicati nel suo arcinoto libro Morfologia della fiaba, del 1928. Qualche anno dopo anche Joseph Campbell, studioso americano di miti e religione, sviluppò il concetto del “viaggio dell’eroe” (illustrandolo nel suo L’eroe dai mille volti del 1949), per molti versi simile allo schema di Propp.
Gli studi di Propp e Campbell confermarono che le strutture delle narrazioni hanno origini antichissime. Le storie sono state per millenni uno degli asset vincenti della nostra specie, contribuendo allo sviluppo della civiltà umana, perché sono servite non solo a intrattenerci ma anche a tramandare cultura e tradizioni per generazioni, sicuramente almeno fino all’invenzione della scrittura – ma anche dopo, visto che fino a poco più di due secoli fa la maggioranza della popolazione umana era analfabeta. Oggi questo “superpotere di specie” potrebbe essere diventato la nostra kryptonite.
Ma per capire il presente, serve prima fare un breve viaggio nel passato.
Origini incerte
Quand’è che Homo sapiens inizia a raccontare storie? I racconti orali non fossilizzano e, per tutto ciò che è avvenuto prima dell’invenzione della scrittura, non abbiamo prove fisiche che ci permettano di ricostruire l’origine della narrazione. L’ipotesi più accreditata è che la nostra capacità di raccontare storie sia emersa contemporaneamente alla “rivoluzione cognitiva paleolitica”, cioè circa 45.000 anni fa, quando, secondo molti paleoantropologi, abbiamo iniziato a sviluppare il pensiero simbolico. I reperti materiali indicano che proprio a partire da quel periodo gli esseri umani iniziano a decorare il proprio corpo con colori, oggetti da indossare e abiti, a seppellire i morti e a dipingere o incidere pareti di roccia o manufatti portatili.
Non serve essere scienziati per intuire che a produrre uno qualsiasi fra i molti esempi di arte paleolitica giunti fino a noi, sparsi nei vari continenti (Chauvet, Altamira, Sulawesi…), sia stata una mente moderna, già simile alla nostra. Tuttavia, non basta il disegno di un cinghiale o un’antilope, per quanto magistrale, a implicare una “storia”. Potrebbe trattarsi di rappresentazioni realistiche della fauna preistorica, forse da mostrare la sera al lume delle torce ai giovani della comunità che si preparano alle prime battute di caccia. Serve qualcosa di più. Proviamo allora a spostare lo sguardo, per esempio, accanto al grasso cinghiale in ocra rossa dipinto 44.000 anni fa sulle pareti di una grotta dell’isola indonesiana di Sulawesi. Vedete quelle figure più piccole? Sono ibridi umani/animaleschi o forse uomini con maschere animali e, secondo alcuni studiosi, potrebbero essere la prima testimonianza di un racconto, perché rappresentano qualcosa che (forse) non esiste. Le prime figure mitiche, insomma.
“Non serve essere scienziati per intuire che a produrre uno qualsiasi fra i molti esempi di arte paleolitica giunti fino a noi, sparsi nei vari continenti (Chauvet, Altamira, Sulawesi…), sia stata una mente moderna, già simile alla nostra”.
Senza testimonianze scritte è difficile spingersi oltre le congetture, che vanno prese tutte con un ragionevole dubbio, ma immaginare questi uomini e donne mentre passavano le serate davanti al fuoco ascoltando storie, come noi davanti alla TV, non è poi così difficile.
Non fatevi ingannare, però: le storie non sono solo intrattenimento, anzi forse, nel corso della maggior parte dello sviluppo della nostra specie, sono state soprattutto qualcos’altro.
Un aiuto per la memoria
Uno degli assi nella manica degli esseri umani è la cultura, più precisamente l’accumulo culturale progressivo. “Il cervello di un Sapiens di 10 mila anni fa non era poi tanto diverso dal nostro, e con un’adeguata scolarizzazione avrebbe potuto progettare un supercomputer”, mi spiega l’archeologa Genevieve Von Petzinger, che da decenni esplora le caverne di tutto il mondo, alla ricerca di segni grafici paleolitici. “Avrebbe potuto”, ma non lo ha fatto: qual è dunque la differenza tra loro e noi? Quel che mancava allora, spiega Von Petzinger, era l’accumularsi progressivo di invenzioni e scoperte, senza il quale le grandi innovazioni tecnologiche del presente e del passato non avrebbero potuto verificarsi. Invenzioni come la scrittura, l’agricoltura, la ruota, i computer e internet. Ogni innovazione è più complessa della precedente e, affinché si realizzi, serve che un bagaglio culturale sempre più ampio venga tramandato ai posteri. La scrittura, un modo molto efficace di immagazzinare e tramandare l’informazione – e una grande invenzione essa stessa – è arrivata solo 5.000 anni fa. Per decine di migliaia di anni ne abbiamo fatto a meno, riuscendo comunque a sviluppare grandi civiltà. Come ci siamo riusciti?
Le storie non sono solo divertenti, sono anche facili da ricordare. Effetti di memoria di questo genere sono noti da sempre. Molte tecniche mnemoniche si basano sull’uso di storie per dare un senso all’informazione.
Anche la ricerca scientifica ha trovato diverse conferme su questi effetti di memoria. Qi Wang è una professoressa che dirige il laboratorio di Cultura e Cognizione della Cornell University. Qualche anno fa ha lavorato con bambini fra i 6 e i 7 anni. In una serie di esperimenti, i piccoli partecipanti dovevano raccontare una storia sulla base di figure contenute in un libro. Sei mesi dopo, Wang e colleghi hanno incontrato di nuovo gli stessi bambini. In questa seconda fase hanno misurato il ricordo della storia raccontata mesi prima da ciascuno. Coloro che inizialmente avevano codificato più informazioni nella narrazione e prodotto racconti più completi, complessi, coesi e coerenti, dopo sei mesi ricordavano la storia con maggiore dettaglio e accuratezza, indipendentemente dall’età e dalle abilità verbali. Insomma, i più bravi “racconta storie” erano anche quelli in grado di ricordare di più.
Anche Anne Hamby ha studiato questi effetti di memoria, dimostrando che storie con una marcata struttura di causa ed effetto aiutano a mantenere il ricordo di informazioni, anche se queste successivamente vengono smentite. Insomma, le storie ci fanno ricordare qualcosa molto a lungo, anche se ciò che raccontano non è vero, e questo, ovviamente, può essere un problema.
Tempi geologici
Prima ho scritto di quanto sia difficile risalire alle origini delle storie, dato che nella loro forma orale primitiva non lasciano tracce tangibili. C’è chi pensa, però, che non sia del tutto impossibile. Patrick Nunn è un geografo e antropologo che da qualche decennio confronta le informazioni contenute nei miti di alcune popolazioni tradizionali in tutto il mondo con i dati geologici. “Come geologo, i miti più facili da datare sono quelli associati alle eruzioni vulcaniche”, mi racconta, “ce ne sono molti ed è molto semplice attribuire una data a quelle eruzioni, spesso fino al giorno preciso.”
“Il miglior esempio documentato che conosco è quello del vulcano conosciuto come Monte Mazama. Circa 7.600 anni fa, il vulcano esplose e collassò, formando una conca, una caldera che si riempì d’acqua, oggi conosciuta come Crater Lake, in Oregon”, racconta Nunn. “Quando gli europei incontrarono per la prima volta la popolazione locale, i Klamath, questi raccontavano storie su quell’eruzione vulcanica. E non si trattava di un singolo racconto, ma di molte, moltissime storie con tanti dettagli”.
Ci sono, continua Nunn, popolazioni in tutto il mondo con esempi simili. Gli aborigeni australiani sono forse quelli che mostrano i casi più numerosi e interessanti. Per la maggior parte dei 75.000 anni in cui Homo sapiens è vissuto in Australia, le popolazioni sono rimaste isolate. I primi contatti infatti risalgono solo a 300 anni fa. Secondo Nunn, alcuni dei miti in Australia potrebbero avere più di 12.000 anni e avrebbero contribuito a tramandare informazioni cruciali per la sopravvivenza di queste popolazioni in un ambiente tra i più ostili al mondo, permettendo loro non solo di sopravvivere, ma addirittura di prosperare.
“Uno degli assi nella manica degli esseri umani è la cultura, più precisamente l’accumulo culturale progressivo”.
Naturalmente, ammette lo stesso Nunn, tutto questo va preso con un certo grado di approssimazione. Ci sono innumerevoli miti che raccontano cose senza alcun riscontro o semplicemente impossibili. È ragionevole pensare che eventi catastrofici possano essere stati oggetto di narrazione, ma molti altri miti potrebbero essere stati inventati di sana pianta, e anche quelli basati su eventi reali, in migliaia di anni e attraverso contaminazioni culturali (pensiamo alla nostra Europa, dove infinite culture si sono stratificate le une sulle altre), potrebbero essere stati alterati. Tuttavia, Nunn ritiene che eventi particolarmente drammatici, come le eruzioni vulcaniche, possano riuscire a sopravvivere nei miti per millenni e questo è favorito da alcune condizioni: “Fra i fattori che aiutano la sopravvivenza troviamo l’isolamento, l’attaccamento a una particolare area geografica, la lingua e l’esistenza, nelle comunità, di figure specializzate nel narrare e tramandare storie”.
Da supepotere a tallone d’achille?
“Siamo fondamentalmente creature che raccontano storie”, mi spiega Anne Hamby. “I bambini non hanno bisogno di essere istruiti su come raccontarle, lo sanno automaticamente. Siamo narratori nati”. Per Hamby, il motivo alla base di questa nostra caratteristica è che comprendiamo il mondo in termini di sequenze di causa ed effetto.
“Siamo talmente fissati con le storie”, continua Hamby, “che le vediamo anche dove non esistono. Un esempio è un famoso studio in cui gli autori hanno utilizzato forme geometriche, come triangoli e punti, che si muovevano sullo schermo, e hanno chiesto alle persone: cosa vedete?”.
“Tutti hanno visto una storia“, continua la scienziata. “Abbiamo bisogno di dare struttura e significato al nostro mondo anche dove non esistono, e questo può causarci dei problemi”.
Il problema delle storie, secondo Hamby, è che ci portano a una sospensione della realtà e come già detto, le storie riguardano sempre un protagonista e sono dunque poste in maniera personale. “È difficile controbattere a qualcuno che ti racconta una storia su qualcosa che gli è successo”, continua Hamby. “E ai giorni nostri abbiamo internet e social media, dove questo tipo di narrazioni, nelle mani di agenti manipolatori, possono davvero causare molti danni”. Lo abbiamo visto tutti durante la crisi pandemica, dove la disinformazione ha prodotto vittime ed enormi sprechi di risorse pubbliche, e lo vediamo allo stesso modo anche oggi per quel che riguarda la crisi climatica. Lo abbiamo visto anche durante la campagna presidenziale negli Stati Uniti dove uno come Trump si fa “nonno” e rievoca storie sul passato di un america benevola e prospera (Make America Great Again) che non è mai esistita, inventandosi sostanzialmente una narrazione che omette fatti incontestabili, per esempio la segregazione razziale, che le stesse comunità latine e afroamericane staunitensi – che pure non sono affatto ignoranti sulla realtà dei fatti – oggi preferiscono omettere, sospendendo la realtà.
Quest’ultimo esempio pare particolarmente significativo: pur essendo la verità dei fatti davanti agli occhi di tutti, la narrazione “creativa” ha la meglio. Una cosa molto simile accade quando si tratta di contrapporre i fatti della scienza alle disinformazione.
Scienza: tutta un altra storia
Se le strutture narrative che conosciamo funzionano così bene, perché allora non le sfruttiamo per raccontare i “fatti della scienza”, giocando ad armi pari contro la disinformazione? Non è che nessuno provi a farlo, ma è una tattica che può spingersi solo fino a un certo punto, perché la natura stessa del dato scientifico si oppone a un certo tipo di narrazione.
Innanzitutto: scienziati e scienziate sono estremamente restii nel tracciare legami di causa ed effetto quando osservano una correlazione. È per questo che ci sono voluti decenni di studi prima che la comunità scientifica si esprimesse sulla natura antropogenica del riscaldamento globale. Qualcuno ricorderà forse il 2007, l’anno della pubblicazione del quarto rapporto dell’IPCC, quello del Nobel per la Pace, che probabilmente ha segnato un punto di svolta. Ma era dalla metà del secolo precedente che si indagava sulla questione. Oppure pensate a quando osserviamo – sempre più spesso – eventi meteorologici estremi: è raro – forse impossibile – che qualche ricercatore o ricercatrice indichi con certezza il riscaldamento globale come causa di un singolo evento. Anche se ci sembra “sensato”, la scienza non funziona così, e quando parla attraverso ricercatori e ricercatrici, si prende delle responsabilità. Immaginate cosa potrebbe succedere se un medico dicesse che un vaccino è sicuro al 100% e poi qualcuno morisse per una reazione avversa grave?
Un’altra cosa che non si sposa bene con la comunicazione dei fatti della scienza è il ricorso a figure di eroi solitari. Questo non perché scienziati e scienziate non possano peccare di vanità o protagonismo, ma perché la scienza si costruisce per forza sul consenso di battaglioni di ricercatori e centinaia di studi. Avrete sentito parlare di replicabilità, che è anche una bella grana per chi fa ricerca: se la tua osservazione non viene ripetuta, possibilmente più volte da qualcun altro, vale ben poco. E anche quando la scoperta c’è, prima di poterla comunicare passano anni di verifiche. Pensiamo al classico iter clinico per approvare un farmaco: a differenza delle cure miracolose che spuntano come funghi ovunque ti giri, servono decine di anni per rendere disponibile una nuova terapia. Più che un viaggio dell’eroe è una lunga attesa di risultati parziali, a volte non decisivi, fallimenti e piccole vittorie.
Nel processo scientifico poi non c’è un villain, almeno di non includere la scarsità di fondi per la ricerca. Non esiste un malvagio che impedisce agli scienziati di portare avanti la propria linea di ricerca e non esiste nemmeno lo scienziato o la scienziata “controcorrente” che “non ce lo dicono”. E se esiste, puzza sempre di fuffa.
Niente da fare insomma: risultati scientifici vanno nella maggior parte dei casi comunicati in maniera sobria, precisa, e soggetta una serie di vincoli davvero poco elettrizzanti.
La plasticità ci salverà?
È una battaglia persa, quindi? Probabilmente no, ma non la si vincerà con facili formulette, qualche intervento miracoloso anti-fake news o, peggio, con forme di censura.
Periodicamente, qualcuno propone misure per arginare e contrastare il dilagare della disinformazione: marchi di qualità sull’informazione, controlli a tappeto dei post sui social (magari tramite l’intelligenza artificiale), potenziamento e rafforzamento dei curricula scientifici nelle scuole dell’obbligo, interventi di censura varia. Tutti provvedimenti utili (con qualche dubbio sulla censura), ma che non sono di per sé risolutivi. L’impegno deve essere strutturale, costante, e sarebbe meglio se si mantenessero toni più pacati, evitando di inasprire gli animi.
Dovremo anche metterci l’animo in pace, perché non sarà mai possibile eliminare del tutto la disinformazione; ciò a cui possiamo aspirare è che il nostro spirito critico e la capacità di riconoscerla siano sempre più allenati. In fondo, si tratta di cambiare il nostro modo di reagire alle storie, frutto di millenni di evoluzione. Non succederà dall’oggi al domani. Tuttavia, ciò non significa che sia impossibile. Noi, o meglio, il nostro cervello, possiamo cambiare.
Anche se il nostro DNA è lo stesso di 100.000 anni fa, il nostro cervello oggi non è esattamente lo stesso di allora. La cultura che abbiamo creato proprio con il cervello stesso (anche grazie alle storie) è in grado, a sua volta, di modificarlo profondamente e farlo funzionare diversamente.
“Dovremo anche metterci l’animo in pace, perché non sarà mai possibile eliminare del tutto la disinformazione; ciò a cui possiamo aspirare è che il nostro spirito critico e la capacità di riconoscerla siano sempre più allenati”.
Un esempio: fino a 5.000 anni fa non esisteva la scrittura, e nel nostro cervello non vi erano circuiti in grado di elaborarla. Abbiamo dovuto inventarla (non è successo in un giorno e per opera di una sola persona), e oggi, nella testa delle persone alfabetizzate, esistono aree talmente specializzate che se vengono danneggiate da un trauma o una malattia compromettono le funzioni legate alla lettura e alla scrittura.
Il nostro cervello è plastico e, finora, si è dimostrato capace di adattarsi all’evoluzione della nostra civiltà. Chissà, dunque, che non possa succedere lo stesso con la disinformazione (a patto che tutto non cambi troppo rapidamente e drasticamente). Non perderemo il gusto delle storie, ma, chissà, magari svilupperemo l’area cerebrale delle fake news che ci farà distinguere una bella storia da una bufala.