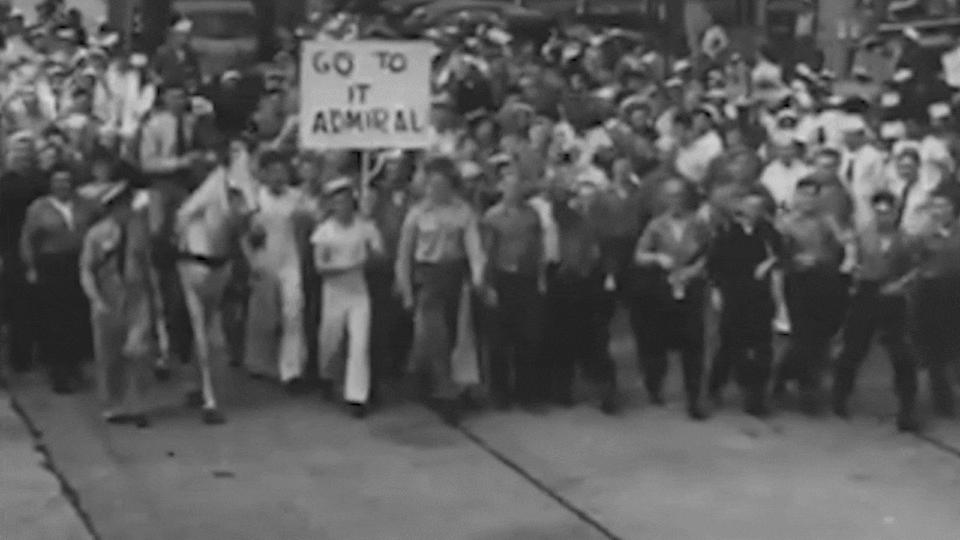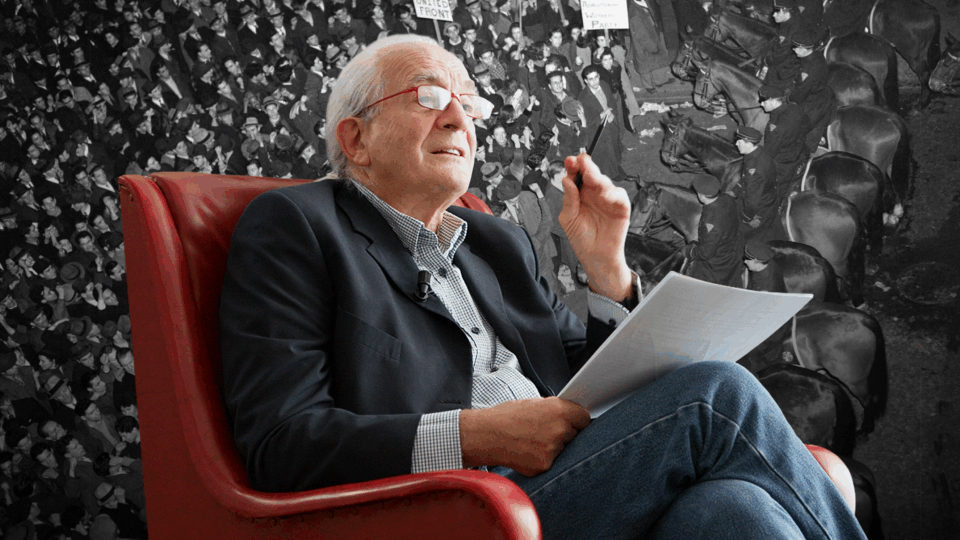Poche cose raccontano l’evoluzione e i cambiamenti delle nostre società meglio del cibo. La storia del mondo si può riassumere così: c’è la fame e c’è l’abbondanza. E però, in mezzo, ci sono tante contraddizioni, posizioni diverse, scenari incerti, equilibri demografici che cambiano e un pianeta che a causa nostra non se la passa benissimo…
E lo so, ci piacciono tanto i ragionamenti accesi e alati, eppure se mettessimo da parte la riluttanza a parlare delle cose terra terra, potremmo riassumere la condizione umana senza troppe astrattezze. Basta usare uno strumento agronomico: il grano. Con questa pianta la storia si semplifica perché il grano divide la storia del mondo in due paesi: da una parte Pinocchio, dall’altra Masterchef.
Pinocchio, lo sappiamo, è la storia di un burattino, scritto a partire dal 1881 a puntate, poi espanso perché il finale cruento era risultato ostico ai poveri bambini di allora, per non parlare delle atmosfere gotiche e oniriche della prima versione, e poi infine risistemato e pubblicato nel 1883. Tralasciando per il momento le innumerevoli interpretazioni, perché si sa, per dirla alla Compagnon, a partire dagli anni Settanta il demone della teoria si è impadronito di parecchi critici, possiamo perlomeno concordare su un aspetto: Pinocchio è un libro che ci parla della fame e della miseria. Tutti i personaggi di Pinocchio hanno fame, tutti sognano di andare in un paese dove tutto è a disposizione di tutti. Bene, questo paese ora ce l’abbiamo: è il paese di Masterchef.
Quanto è durato il paese di Pinocchio, cioè il paese della fame? Da quanto dura, invece, quello di Masterchef, quello dell’abbondanza? La misurazione potrebbe causare già dalle prime righe un abbandono coatto – proprio per questo vorrei prendere un solo parametro: la mortalità infantile, un indicatore significativo perché i valori bassi, in questo caso, sono impossibili da ottenere senza una combinazione di diversi fattori.
Quando ero piccolo – ricordo – visitavo il paese di mia mamma, Sant’Agata dei Gori, e spesso passeggiavo insieme a delle mie vecchie zie e incrociavo sempre una statua della Madonna sul cui volto erano disegnate delle lacrime: la Madonna piangeva – neanche voglio qui ricordare le preghiere che da bambino ho recitato affinché la Madonna non mi chiamasse in cielo.
Quando abbiamo cominciato a fare gli agricoltori, ebbene, allora la mortalità infantile era altissima, lo sappiamo dai resti fossili, almeno un bambino su cinque moriva, nei casi più gravi uno su tre, e nei primi 365 giorni di vita. Di conseguenza la vita media era molto bassa, intorno ai 35 anni di vita. Se andiamo avanti al 1900, all’inizio del XX secolo, in alcune zone del napoletano, alcuni quartieri, come l’Arenella (dove sono nato), Vicaria, Sanità, nelle zone costiere della nostra penisola, colpite dalla malaria, insomma, ancora nel 1900 la mortalità infantile era la stessa del neolitico e l’aspettativa di vita intorno ai 35 anni.
E ora? Nel paese di Masterchef? Ora la mortalità infantile tende a zero. Più precisamente, è bassissima in quei paesi che hanno dimensioni molto ridotte (popolazioni inferiori a 10 milioni di abitanti) e certo, è più difficile mantenere i valori bassissimi nelle società numerose e con un livello di immigrazione alto, ma nella sostanza a livello globale la mortalità infantile è molto bassa – resta altissima, e insostenibile, solo in una dozzina di paesi dell’Africa subsahariana (60 bambini su 1000, quanto l’Europa 100 anni fa).
Di conseguenza la vita media è altissima; in Italia siamo a 83 anni, una specie di record che condividiamo con alcuni paesi come il Giappone e i Paesi Bassi. Certo, poi bisognerebbe indagare su un fatto: stiamo aggiungendo vita agli anni o solo miseri anni alla vita? Io penso la seconda, ma accontentiamoci e facciamoci un lieve applauso di incoraggiamento.

Dunque, fatti i conti, visto che solo a partire dal 1950 in Europa la mortalità infantile è stata ridotta di molto, possiamo dire che il paese di Pinocchio è durato 10.000 anni, e quello di Masterchef è arrivato, in buona parte del mondo, da appena 80 anni.
Ora, i fanatici dello storytelling avranno già stigmatizzato queste righe piene di dati. Dunque, per non abusare della vostra pazienza ecco a tutti il maggior rappresentante del paese di Pinocchio. Signore e signori, ecco a voi mio nonno Antonio, contadino. Il tipico rappresentante di quel mondo. È nella media, senza alti né bassi.
La foto che conservo lo ritrae col vestito buono. Ma non era suo, era un bene collettivo, apparteneva a più famiglie contadine, nelle occasioni se lo scambiavano. Una volta che lo indossò, visto che c’era, posò anche per la foto. All’epoca non è che avesse molti usi, cioè non si metteva a corredo dei curriculum ma si conservava, così che quando morivi avevi perlomeno una bella immagine da mettere sulla lapide. Comunque, quando indossò il vestito era per un matrimonio, tornando a casa la sera dopo questo cerimoniale lunghissimo, vestito di tutto punto, il cane non lo riconobbe: lo aggredì.
Non era solo il vestito buono a mancare nell’armadio. Pure la collezione di scarpe non era abbondante: un solo paio. Le calzò anche quando fu spedito, 18 anni appena compiuti, alla Grande guerra (classe maledetta, 1899), sul Piave. Solo che si congelò le dita dei piedi e tre di queste gli furono amputate. Appena arrivato, poi, un tenente piemontese gli disse di non bere l’acqua di un torrente perché gli austriaci l’avevano avvelenato e lui niente, bevve lo stesso e il tenente si fece afferrare per pazzo: voi disobbedite agli ordini, così andate in infermeria e non in trincea dove siete destinati, e mio nonno là stava andando, alla corte marziale, finché il tenente piemontese in un sussulto di umanità capì l’equivoco, mio nonno non aveva disobbedito agli ordini, non li aveva capiti: era un uomo a chilometro zero, che non conosceva nemmeno il paese confinante e parlava un dialetto stretto, un italiano regionale.
Del resto, all’altezza dell’Unità d’Italia solo una persona su dieci parlava italiano; abbiamo fatto uno Stato senza che ci fosse una lingua comune.
“Certo, poi bisognerebbe indagare su un fatto: stiamo aggiungendo vita agli anni o solo miseri anni alla vita? Io penso la seconda, ma accontentiamoci e facciamoci un lieve applauso d’incoraggiamento”.
Mio nonno se fosse stato trasportato con una macchina del tempo nel 1600 nemmeno se ne sarebbe accorto che era cambiata un’epoca. Noi abbiamo dati abbastanza significativi per dimostrare che l’agricoltura è stata una dimensione pressoché immobile per millenni. Basta considerare la resa media dei cereali. Il rapporto si ricorda facilmente, da un ettaro, in epoca romana, tardo impero, tiravamo fuori una tonnellata di cereali: uno a uno.
Dobbiamo aspettare la Seconda guerra mondiale per vedere cambiare il rapporto, uno a tre, uno a quattro, uno a cinque e così via. Dobbiamo aspettare gli anni Cinquanta del Novecento per garantirci l’entrata nel paese di Masterchef.
Sul perché l’agricoltura sia rimasta stabile per millenni, tanto da rasentare la noia abissale e far riflettere qualcuno sul no sense della vita, sempre identica a sé stessa, gli agronomi e gli economisti si sono interrogati. Il fatto è che il mondo di Pinocchio è stato anche il mondo del maggese. Una vecchia tecnica agronomica ora non più in uso, tranne in qualche zona difficile del mondo. Si trattava di lasciare il terreno incolto, per un anno. Perché? Perché era il modo che mio nonno, rappresentante perfetto del mondo di Pinocchio, ha utilizzato per affrontare fin dall’inizio, cioè fin da quando lui e la sua comunità prese questa (insana) decisione di stipulare il patto col grano e scegliere un’esistenza da agricoltore.
Mio nonno si è trovato di fronte a un dato di fatto, che la sua intelligenza empirica gli ha fatto saltare subito all’occhio: da una parte una coltivazione regolare accresce enormemente la produzione, dall’altra il terreno tende ad esaurirsi rapidamente. Bel problema, a una gioia seguiva una disgrazia, a un’abbuffata un vuoto di stomaco. Quindi, per ottenere una produzione stabile bisognava seminare su un nuovo pezzo di terra. Cosa scocciante, se non ce l’avevi ti toccava fare una guerra, magari inventando un casus belli, e comunque sempre costruendo una retorica – o chiamiamola “epica” per darci un tono–, oppure, se non volevi guerreggiare, dovevi mettere il terreno a riposo, il maggese appunto.
Quando entriamo nel mondo di Masterchef cambia tutto. E cambia dopo millenni, perché arrivano sostanzialmente tre innovazioni, non che prima non ci fossero ma non erano condizioni sufficienti per scatenare un cambio di fase: chimica, meccanizzazione, genetica, la bestia nera del mondo di Pinocchio (nel senso che ne decretano la fine) e i cavalli di battaglia di quelli che contestano l’agricoltura moderna – comunque mio nonno grazie a una di queste innovazioni, e cioè la meccanizzazione, si è sposato. Per la precisione, grazie alla spandiletame. Una macchina per lui risolutiva, che l’ha affrancato dalla gestione pervasiva del letame che ti costringe a lavorare prima in stalla poi nei campi. Le mani – e non solo – puzzano di stallatico e le donne se ne stanno alla larga.
Mio padre invece ha studiato grazie al trattore, che faceva per lui il lavoro dei campi e gli permetteva di frequentare con continuità la scuola.
C’è un grafico elaborato da Robert W. Fogel, Nobel per l’economia nel 1993. Mette in correlazione la crescita della popolazione con l’innovazione tecnologica. Parte da molto lontano da quando, cioè, abbiamo fatto il patto col grano. All’epoca, 10.000 anni, fa al mondo c’erano solo 10 milioni di persone. Ciò voleva dire che producevamo abbastanza cibo e usavano energia per sostenere solo 10 milioni di persone. Ma sono calcoli ottimisti. Probabilmente eravamo la metà.
Se seguiamo la traccia di Fogel, la storia demografica del mondo è molto noiosa: nonostante alcune innovazioni niente male, la popolazione non cresce. Accade tutto nel XX secolo, per Fogel “secolo notevole, meraviglioso”. Che poi uno gli dovrebbe chiedere: scusa un attimo Fogel, ma che ci sta di meraviglioso nel XX secolo? Due guerre, un genocidio. Però Fogel non ha dubbi, anzi insiste, dice che è stato il secolo durante il quale abbiamo sconfitto la fame, la carestia, la malattia, la morte prematura dei bambini.
Perché? Perché abbiamo mangiato meglio, e con un corpo più nutrito, un apparato immunitario più forte, con qualche bagno piastrellato in più, discreti impianti fognari, mani insaponate e, soprattutto, grazie ad antibiotici e vaccini, abbiamo ridotto quasi a zero la mortalità infantile e alzato l’aspettativa di vita. La più grande svolta della storia dell’umanità. Risultato? Nasco nel 1966, allora eravamo 3,4 miliardi, quando mio nonno è nato, nel 1899, a stento eravamo un miliardo e mezzo, nel 1974 siamo passati a 4, a 5 nel 1987, a 6 nel 1999, a 7 nel 2010 e ora siamo 8 miliardi e andiamo verso i 10, da qui al 2050.
Nel XX secolo è cambiato tutto, abbiamo voluto un mondo migliore dove i bambini non morissero più, le Madonne, perlomeno quella di Sant’Agata dei Goti smettessero di piangere? Ebbene, ce l’abbiamo fatta, ora questi bambini sono cresciuti – alcuni so’ diventati adulti stronzissimi – ed eccoci qui, dal sogno di un mondo migliore nasce l’incubo di un mondo popolato da tanti io con i loro desideri e la conseguente richiesta di energia per soddisfarli.
“Mio nonno non aveva disobbedito agli ordini, non li aveva capiti: era un uomo a chilometro zero, che non conosceva nemmeno il paese confinante e parlava un dialetto stretto, un italiano regionale”.
Nemmeno poi dovremmo sottovalutare il fatto che dall’alto della curva guardiamo tutti con supponenza, pur tuttavia il nostro apparato emotivo decisionale, importantissimo per deliberare, quell’apparato è rimasto giù in basso, al paleolitico. Nella sintesi, brutale, di questo mondo non ci capiamo più niente. Il mondo è fatto di tante scatole nere, noi parliamo del contenitore e mai del contenuto, perché per farlo ci vorrebbe tempo e capacità d’analisi – e non abbiamo né l’una né l’altra cosa.
Questi dilemmi stanno delineando due scenari. Il primo analizzato dagli antinatalisti, il secondo dai realisti. Ognuno dei due movimenti di pensiero non è immune da contraddizioni, ma come – più o meno – cantava Giovanni Lindo Ferretti, anima bella che stai lassù in montagna metti i piedi per terra e sentirai che elettroshock.
Gli antinatalisti sono un movimento ancora poco raccontato ma che scommetto fra poco vedremo in molti talk televisivi. Prendendo spunto anche dal pensiero di Peter Zapffe (che poi è il padre nobile di molti ecologisti) sostengono che mettere al mondo un figlio significa aumentare il carico di insensatezza (oltre che l’impatto demografico su risorse già scarse). E già la vita presenta ogni giorno il suo carico di assurdità, dunque perché moltiplicarsi? Visto che poi l’aspettativa di vita si alza e si alzerà ancora. Trattasi di tendenza generale: oltre al Giappone, che vanta il record seguito dall’Italia, 83 anni, salgono Corea del Sud, India, Etiopia, Sudafrica.

Nel frattempo, capite bene che i ruoli tradizionali saltano, ognuno ha le proprie ambizioni, ognuno vuole dire: io ci sono e appunto ognuno di noi vivendo più a lungo e celebrando la seconda, terza e quarta età, i nuovi amori, i viaggi anche a 80 anni, i selfie sulle scogliere, sulle barriere coralline, sulle Ande etc., ecco, tutto questo andazzo, e le celebrazioni della vita – dicono gli antinatalisti – impatteranno sul pianeta: meglio non celebrarla troppo, la vita. Veramente a questo siamo destinati? Crescete e moltiplicatevi? Non è che seguire il precetto religioso abbia fatto male al pianeta? Per fare cosa poi? Creare una famiglia disfunzionale che arrechi danni alle copie di noi stessi?
Eccerto, rispondono i realisti, e le pensioni? A parte che la demografia non è un problema, anzi: sul lungo periodo decrescerà. Si parla o non si parla di inverno demografico? Sia da destra sia da sinistra si commenta questa singolare e preoccupante tendenza, e in genere, sia da destra (richiamo ai valori della famiglia, qualche volta della nobile stirpe etc.) sia da sinistra (inesistenza degli asili, sussidi mancanti etc.).
I demografi definiscono il tasso di fecondità totale come il numero dei figli avuti da una donna nel corso della sua vita. Il limite naturale al tasso di fecondità è posto dalla durata del periodo fertile (suppergiù le donne hanno tra le 300 e 400 ovulazioni, che vanno tarate poi sul numero di gravidanze e in parte sul periodo di allattamento che riducono la possibilità di concepimento) e, comunque fatti i calcoli, una donna potrebbe spingersi fino a 24 figli. Una volta erano evidenti i benefici di un elevato tasso di fecondità. Ho donato il mio utero al duce, cioè alla Patria, diceva una mia vecchia zia.
Poi per fortuna a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento una serie di scoperte e invenzioni hanno migliorato notevolmente le condizioni sociali e promosso una (seppur larvata) ascesa sociale, e dunque il tasso di fecondità si è abbassato. Pure troppo, tanto è vero che si parla di inverno demografico. Si invertirà? Per farlo bisognerebbe mantenere il tasso di fecondità intorno all’1.7 per cento. La Francia e la Svezia, tanto per dire, nel 2019 si attestavano intorno all’1.8. Se si finisce sotto l’1.5 per cento non ci sta niente da fare (diciamo che è come il conto in banca con le nuove entrate: i nati non riescono a compensare le uscite, i morti). Italia, Spagna, Romania hanno fatto segnare per molti anni il record (siamo all’1,3 per cento), in Giappone, Ucraina, Grecia e Croazia all’1.4 per cento.
Quindi? Quindi invece di preoccuparsi della demografia occidentale, dovremmo fare in modo che i più poveri diventino meno poveri. Perché è importante fermarsi perlomeno a dieci miliardi. In alcune nazioni si fanno ancora sei figli, ma prima di questi, quattro morivano, ora, e per fortuna, ne muoiono solo due. Quindi, vedremo un mondo con più africani e più asiatici: difatti, gli americani sono meno di un miliardo, così gli europei, gli africani 1,5 miliardi e gli asiatici 4,5: nella sostanza, se il continente europeo nel 1900 ospitava il 18 per cento della popolazione mondiale, ora siamo al 9.5 per cento.
Sembra facile, ma per portare un miliardo di persone fuori dalla povertà e garantire un sano sviluppo ai restanti in via di sviluppo, ci vuole energia nuova e le transizioni energetiche sono lentissime, scoperte rivoluzionarie per l’energia nonostante i proclami che si leggono di tanto in tanto.
Tra il fervore di entrambi i gruppi e considerate le complicazioni e le difficoltà che ancora debbono venire, a chi dobbiamo ispirarci? Sarei per scegliere una terza via che unisca il meglio delle due posizioni e su questa strada mi muoverei per esaminare altri aspetti di questo terribile, intricato, complicato mondo: e cioè il pessimismo.
Il pessimismo è uno strumento di osservazione del mondo che nasce proprio dal nostro patto con il grano. Più il grano ci ha dato forza, più ci siamo accorti che eravamo deboli, feriti. La ferita è ancestrale, riguarda il senso della vita, molto difficile da scovare e, a un’analisi più attenta, il senso altro non è che un tentativo di pompare ordine in un mondo insensato. Il pessimista si considera un ferito della “Grande guerra della vita”, delle pene che la coltivazione del grano ci ha affibbiato ed è portato a guardare la ferita degli altri sotto la coltre di storie: il pessimista in funzione della nostra ferita ha capito che il senso della vita è fare il pane.
“Mio nonno grazie a una di queste innovazioni, e cioè la meccanizzazione, si è sposato. Per la precisione, grazie alla spandiletame”.
Mio nonno sul letto di morte chiese un pezzo di pane. Mio padre dovette uscire di notte e cercare un forno e, intanto, si stupì che in mezzo a una campagna qualcuno faceva il pane nel cuore della notte mentre il mondo con le sue storie girava e girava. Quando mio nonno assaggiò il pane, ebbe quella che in gergo viene chiamata la “miglioria della morte” e, cioè, un attimo di miglioramento prima della fine, un’altra caratteristica di noi umani che i pessimisti hanno imparato a notare e sottolineare.
Sta di fatto che assaggiando il pane, la sua madeleine, gli vennero in mente dei ricordi e nel deliquio parlò della sua vita che quando mai l’aveva fatto, scontroso e burbero com’era. Raccontò, per esempio, che era un ragazzino senza scarpe e fu spedito in capo al mondo e camminò a lungo al freddo, tanto che i piedi gli si congelarono. Tre dita amputate e poi un tenente gli disse una cosa che lui non capì e si sarebbe vergognato tutta la vita e meno male che poi il tenente lo prese al cuore e lui e altri coscritti della Grande guerra.
Raccontò anche che era fuggito il 24 ottobre con mezzo battaglione perché sia gli austriaci sia i tedeschi erano entrati e scapparono finché in un fosso non videro dei cavalli e degli asini che quelli di prima avevano abbandonati lì, mezzi morti, ancora bardati di pesi e mio nonno, come una visione, riconobbe negli asini mezzi morti nel fosso il suo asino, che affettuosamente chiamava Pasqualino e pare fosse bizzoso, tipo che mentre lavorava si fermava all’improvviso e non voleva camminare tanto che bisognava prenderlo a morsi e litigare a parolacce e bestemmie, ma ora Pasqualino stava nel fosso e mio nonno, che poi era un ragazzo di 18 anni, insieme ad altri si fermarono e tirarono fuori gli animali e si dissero da qua non ci muoviamo, dobbiamo proteggere Pasqualino che a sua volta era un asino che trasportava il grano e col grano avevamo fatto un patto.

Raccontò anche di un’altra fuga, quella dopo l’armistizio, l’otto settembre del 1943, quando – di nuovo a piedi – dal Veneto tornò a casa, sotto il fuoco incrociato dei nazifascisti e degli alleati, via Adriatico, poi scavallò mezzo Appennino e ce la fece, perché altri contadini come lui, con gli asini identici a Pasqualino gli offrirono il pane e il pane, si sa, è il miglior motivatore al mondo.
Raccontò questo e altre cose, in un deliquio e finì dicendo: se qualcuno mi dicesse, vorresti tornare su questa terra con tutte le privazioni che hai avuto io direi di sì, e solo per assaggiare questo pezzo di pane che è costato tanta fatica.
Il pessimista è quello che ha capito che il senso della vita non c’è, ma fare il pane perlomeno è fondamentale per vivere, anche se poi vivere significa analizzare con realismo le contraddizioni, perché contraddittoria è la nostra natura, che poi sempre dal pane dipende.