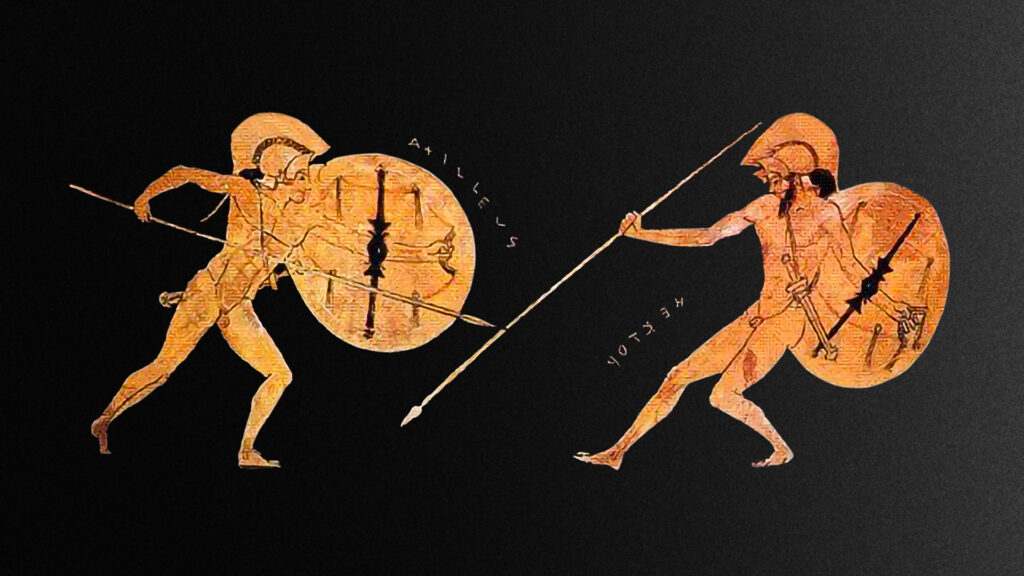Nicola Lagioia
Contemplare l’universo con un cervello di gatto
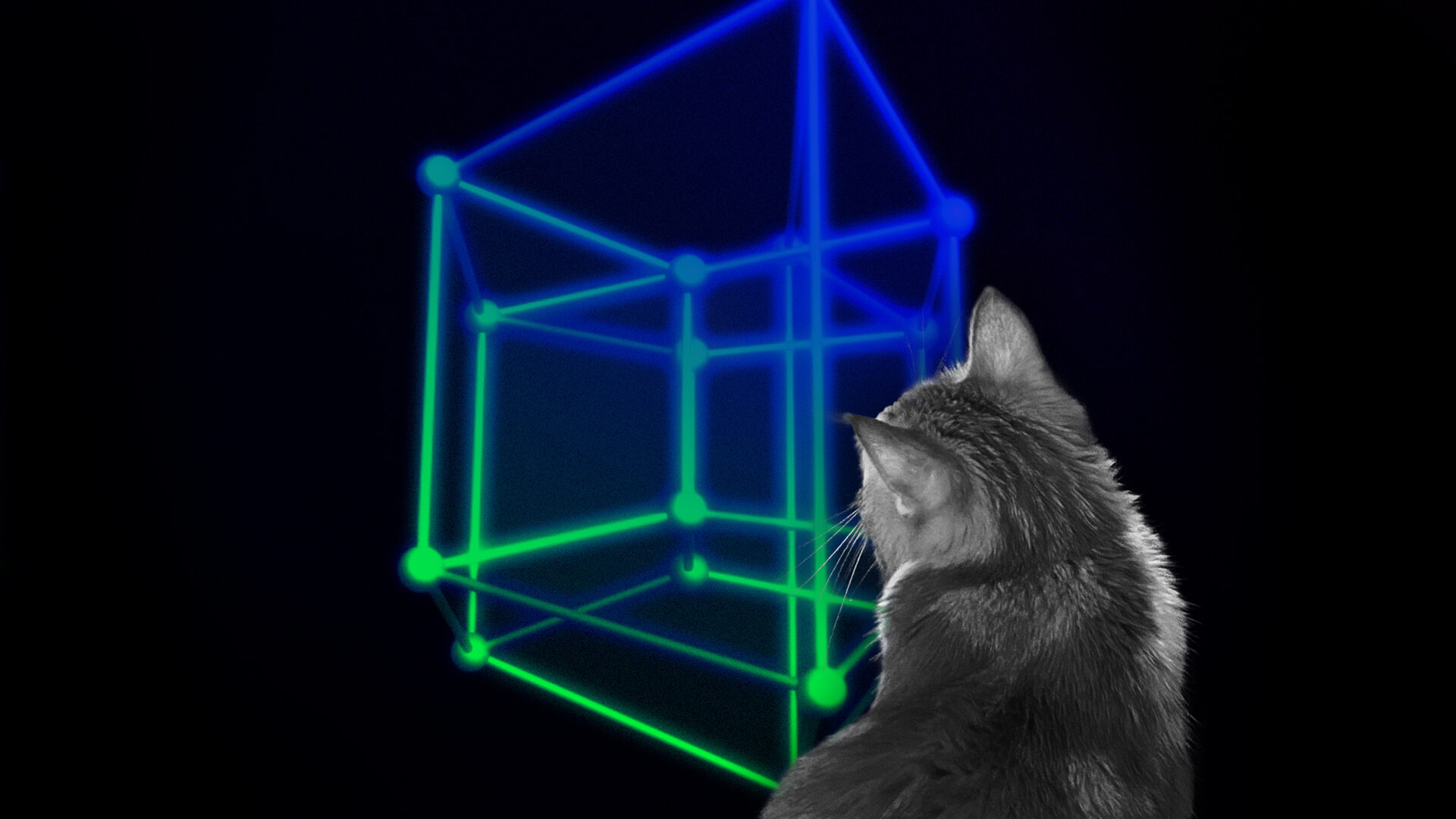
06 Marzo 2023
Scienza e metafisica, etica e sacrificio, Bucarest e il mondo fuori dalla nostra limitata capacità di percepirlo: Mircea Cărtărescu, uno degli scrittori più interessanti della sua generazione, si racconta.
Nicola Lagioia
Nicola Lagioia è scrittore, sceneggiatore, conduttore radiofonico e direttore editoriale di Lucy. Il suo ultimo libro è La città dei vivi (Einaudi, 2020).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati