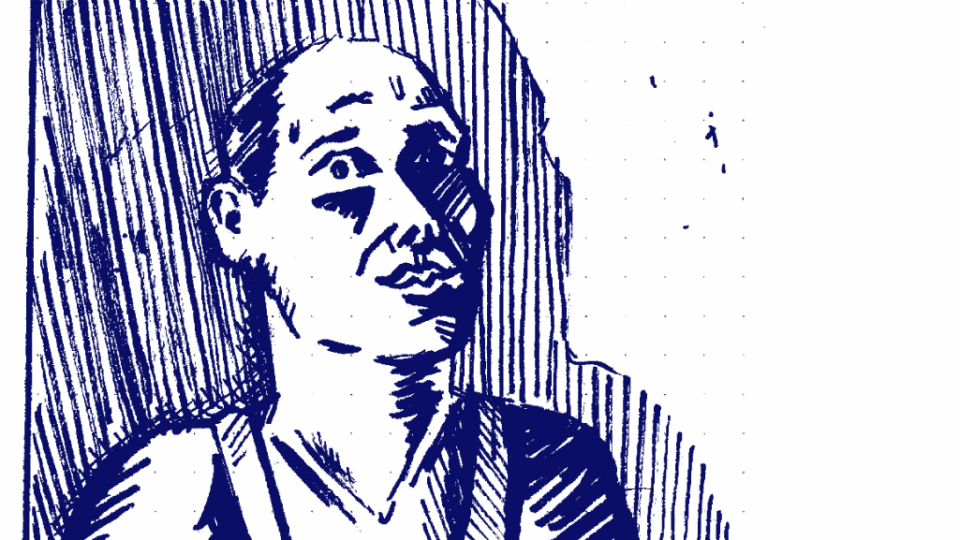Il romanzo amplia la mente, il romanzo non serve a niente: decostruire il romanzo per permettergli di rinascere.
Ogni tanto, a una tavola rotonda, a un dibattito pubblico intorno a questioni letterarie, capita di sentire il relatore di turno evocare in modo ironico, liquidatorio, quando non stizzito, un antico dibattito sulla presunta “morte del romanzo”. Si riferisce, senza esplicitarlo, a una querelle animata dalle avanguardie – soprattutto francesi – della metà del secolo scorso.
Ma non è così importante richiamare il contesto: perché la conclusione a cui il relatore vuole arrivare è che no, il romanzo non è morto. Sta benissimo. È in piena salute. Gli piace dirlo perché lui stesso ne scrive. E perché oggettivamente la parte del leone nella pur affannata editoria la fa la narrativa.
Forse non c’è epoca paragonabile a questa in quanto a produzione di quegli oggetti editoriali che chiamiamo romanzi. Il punto sarebbe leggerne più a fondo le specifiche, la natura, capire a quale pubblico parlano e possono parlare.
Ma devo notare che lo stesso relatore che, smentendo la presunta morte del romanzo, intende confermarne la presunta vita, raramente ha voglia di fare un passo oltre. Reagisce malvolentieri, insofferente, annoiato, a una sollecitazione come potrebbe essere quella – faccio un esempio – che propone nella prima pagina di La letteratura oggi. Romanzo, editoria, transmedialità (appena uscito per Einaudi) Giuliana Benvenuti: “Chiedersi quale funzione rivesta la letteratura oggi, a seguito dei rapidi mutamenti determinati dalle dinamiche dell’età globale e delle trasformazioni tecnologiche, può sembrare un’ambizione eccessiva…”.
Eccessiva, e tuttavia necessaria. Non per arrivare a una risposta univoca, ma per provare a mettere meglio a fuoco il posto del romanzo (delle diverse tipologie di romanzo) fra le forme di comunicazione ed espressione attive nel presente.
Sto difendendo – vale la pena dichiararlo – un presupposto di consapevolezza o iper-consapevolezza rispetto al lavoro della narrativa. Mi pare che un eccesso di spensierata spiritosa inconsapevolezza alligni oltremisura nell’ infinite jest dei social, ma più in generale nelle interviste dichiarazioni meditazioni pubbliche di molti autori e autrici. Forse, per non spaventare la platea, tendono a non indugiare sul senso di un gesto, sul perché e sul come. Spesso si limitano a circostanziare il cosa.
Forse non c’è epoca paragonabile a questa in quanto a produzione di quegli oggetti editoriali che chiamiamo romanzi.
Per questo l’eredità di pensiero sul romanzo – rivelatasi testamentaria – che lo scrittore inglese Martin Amis (1949-2023) ci consegna nelle oltre seicentocinquanta pagine di La storia da dentro (Einaudi, trad. it. di Gaspare Bona) mi ha dato l’impressione di essere un monumento alla propria stessa consapevolezza autoriale. Il che non significa cerebralità o capziosità, né freddezza.
Il lungo romanzo, che si congiunge idealmente a Esperienza (2000), è palpitante, mosso, ricco di momenti divertenti e di momenti commoventi, come è giusto che sia un romanzo.
Né si tratta in senso stretto di meta-letteratura: benché sulle prime si possa pensare all’interlocutore che ogni tanto Amis convoca come un’evoluzione più carnale e meno astratta del Lettore/Lettrice a cui si rivolgeva il Calvino di Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979). Citatissimo libro-game, di cui poco si è colto il fondo di disperata e ossessiva ricerca di fede ulteriore: nel romanzo, nel linguaggio (in Palomar, l’ultimo libro, pubblicato nel 1983, Calvino mette in discussione il linguaggio stesso, la sua funzione e necessità).
Per tornare ad Amis: appena comincia a raccontare (a parlare), il narratore tira in ballo Nabokov, il discutibile diritto di scrivere un’autobiografia; rievoca una divertente/imbarazzante lezione fatta nella scuola di sua figlia. Durante la quale finisce per dire che nessuno più di un adolescente può capire cosa sia uno scrittore. “In beata solitudine vi trastullate coi vostri pensieri e sentimenti, e a volte sui pensieri e sentimenti degli altri. In solitudine”.
E non siamo ancora oltre il preludio che Amis ci ha già detto perché i veri romanzi sono più delicati perfino delle raccolte di poesie, dei memoir, delle autobiografie: “Perché mettono in luce chi sei veramente”.
Mi è bastato arrivare qui per commuovermi, e mi rendo conto che possa apparire esagerato, ma il fatto è che si avverte subito l’intenzione di Amis. Comporre via via un’elegia (struggente) per quest’arte, e più ancora per chi a essa si è votato in un certo modo – quel modo misterioso per cui scrivere un romanzo significa, può significare appunto rivelare chi si è.
Amis dà indicazioni precise al suo lettore-interlocutore. Gli dice che può saltare le pagine, che può leggere a intermittenza o andando avanti e indietro. E pure questo rimanda, mi pare, a una precisa volontà di domandarsi ancora una volta – per l’ultima volta – com’è che si imposta un rapporto tra l’io che scrive (un certo tipo di romanzo) e l’io che legge (un certo tipo di romanzo).
Amis immagina un lettore attento e disponibile, giovane (uno che sarà vecchio nel 2080) e curioso del cantiere, della tecnica. Il che subito mi pone il problema di una endogamia che spesso fingiamo di non vedere: chi legge un certo tipo di romanzo finisce per diventare uno che scrive un certo tipo di romanzo.
Non si ferma cioè alla stazione del lettore “puro”: che legga Woolf, Bellow, Vargas Llosa o Bolaño, finirà per tentare di scrivere. Proprio perché legge Woolf, Bellow, Vargas Llosa, Bolaño o Martin Amis. E Amis lo sa. Parla al suo lettore speciale come a uno scrittore in potenza.
Gli racconta dei suoi incontri con Saul Bellow, gli spiega “cosa la narrativa non può fare” (capitolo geniale così intitolato: una dispensa d’autore per TUTTI i corsi di scrittura presenti e futuri). Gli dice di stare attento quando racconta i sogni, il sesso, l’ideologia, la religione. Gli chiarisce quale sia la differenza tra una storia e una trama. Gli spiega come nascono gli sperimentalisti, i romanzieri che scommettono tutto sul linguaggio: da quale fragilità storica.
E arriva a una distinzione spiccia ma efficace, mutuata da Anthony Burgess, fra romanzieri di tipo A e romanzieri di tipo B. “I romanzieri di tipo A sono interessati alla narrazione, al personaggio, alla motivazione e all’analisi psicologica, disse Burgess, mentre i romanzieri di tipo B sono interessati soprattutto al linguaggio, al gioco delle parole”. Qualche rigo oltre, arriva la sentenza: “Oggi, in ogni caso, il romanzo di tipo B è morto”. Qui potrebbero essere d’accordo anche quelli che non sopportano i discorsi sulla morte del romanzo. Ma Amis non si limita al funerale. Va più a fondo:
C’è stata anche una chiara riorganizzazione del rapporto fra scrittore e lettore (un rapporto, anche nei periodi più banali, di inesauribile complessità e profondità). “Ci piacciono i libri difficili”, proclamavano i littérateurs; e questa supposta preferenza divenne il grido di battaglia per la causa dell’Alto Modernismo. Forse è vero che c’è stato un tempo in cui ci piacevano i libri difficili. Ma adesso non ci piacciono più. I romanzi difficili sono morti.
Almeno in parte, non corteggiamo più la difficoltà perché il rapporto lettore-scrittore ha cessato di essere anche solo minimamente collaborativo. Qualunque cosa tu faccia, non aspettarti che il lettore deduca qualcosa.
Chi legge un certo tipo di romanzo finisce per diventare uno che scrive un certo tipo di romanzo.
Può essere scambiata per una considerazione snob, o elitaria. È una constatazione quasi inoppugnabile. Può essere scambiata – da eventuali residuali romanzieri di tipo B, impegnati sul fronte di un opaco e superfluo sperimentalismo – per una difesa della loro resistenza. Non lo è.
Amis sembra sviluppare la lezione sulla leggerezza calviniana come lezione sulla coazione alla semplicità: “Prendi nota: ogni informazione vitale deve essere enunciata in linguaggio elementare; quando c’è da dedurre o congetturare, i lettori non hanno più gli strumenti”. Li sta sottovalutando? “Il narratore inaffidabile (un tempo espediente popolare e spesso molto fruttuoso) è stato sostituito dal lettore inaffidabile”.
Se si fermasse qui, non sarebbe il geniale scrittore che è, ma solo un uomo sconcertato dal cambiamento del paesaggio antropologico e dunque culturale. Invece è uno scrittore geniale; e pur consapevole del fatto che non esista – o sia pesantemente erosa – la pazienza dei lettori, “il loro zelo, il loro entusiasmo autodidatta”, pur accettando che i romanzi privi di intreccio/saggistici/ricchi di digressioni sono in coma, Amis cerca un’altra pista. Una possibilità.
“Nascosto in mezzo a questi necrologi letterari, scorgiamo l’orgoglioso annuncio di una nascita. In realtà il nuovo arrivato è con noi da un bel po’ – dall’inizio del secolo – e il fanciullo prospera sempre più. Mi riferisco al romanzo aerodinamico, affusolato, accelerato“.
Forse è vero che c’è stato un tempo in cui ci piacevano i libri difficili. Ma adesso non ci piacciono più. I romanzi difficili sono morti.
Amis è convinto che il romanzo accelerato sia la risposta a un mondo accelerato. E aggiunge che (osservare la bellezza, la bellezza stilistica, di questo passaggio) “Il mondo non rallenterà, quindi, la poesia cederà altro terreno (come prima o poi potrebbe succedere anche al romanzo letterario), diventando un campo di interesse minoritario, più ombroso e più appartato… Se vogliamo, possiamo immaginare con affetto Phoebe in un albergo a ore, in una strada semideserta, in un ristorante con il pavimento coperto di segatura e gusci d’ostrica: Phoebe che riconsidera la sconfitta della poesia – ben le sta – e schiocca soddisfatta le labbra prima di mostrare la feroce perfezione dei suoi denti”.
Si può non essere d’accordo con Amis, naturalmente. E stare dalla parte di Phoebe. Ma è difficile non cogliere la posta in gioco. La possibilità di travasare – in una forma aerodinamica, affusolata, accelerata – una certa idea di romanzo letterario.
Il relatore da cui sono partito, quello insofferente alle teorizzazioni, ha gioco e applauso facile se e quando decide di concludere il suo ragionamento con la negazione dello scopo della letteratura. Amis impugna le domande seguenti: “Che cosa c’è di buono in un romanzo, che cosa realizza, a che cosa serve?”.
I progressisti/funzionalisti che pretendono abbia una funzione sociale e migliori la condizione umana potrebbero illudersi e avere torto. Ma gli altri – quelli convinti che il romanzo non abbia nessuno scopo – non possono avere ragione, dice Amis.
“Ma può essere privo di scopo, monotonamente privo di scopo per l’intera vita adulta, un romanziere? O chiunque di noi? Mi sembra una questione di pressante interesse. Qual è lo scopo della mia giornata media? […] Speri di dilettare, e anche di istruire. Istruire in un modo che possa stimolare la mente, il cuore, e, sì, l’anima del lettore, rendendo più pieno e più ricco il suo mondo. La mia ambizione è riassunta da un personaggio minore del tardo romanzo di Bellow Il dicembre del professor Corde: è un cane randagio nelle strade di Bucarest, i cui irrefrenabili latrati sembrano ‘una protesta contro le limitazioni dell’esperienza canina (per amor del cielo, aprite l’universo un po’ di più!)'”.
Basterebbe questo. Basterebbe chiedersi se siamo ancora disposti a pensare che un romanzo, un certo tipo di romanzo – un romanzo che corteggia la difficoltà – possa aprire l’universo un po’ di più. Ma Amis non si ferma qui. Non si limita a un enunciato. Forse gli pare bello sì, ma consolatorio (per chi scrive).
Mentre teorizza mette in pratica, mette in pratica e torna a teorizzare, fa, avanza e ragiona sul suo stesso fare, elabora una curiosa esuberante lezione in cui teoria e pratica sono – quasi come in una scuola guida – quasi un tutt’uno. E articola una digressione da defunto romanzo digressivo e la interrompe in uno sghignazzo o in un moto di stizza. E scivola nel memoir e subito lo contraddice scrivendo di sé in terza persona. E si chiede se ci sia davvero “un nesso tra la nostra vita erotica e il modo in cui vediamo la storia”. E appena se lo è chiesto, scrive una scena – fitta di dialoghi e dettagli – che vale più di una risposta concettosa.
Parla di malattie allo stato terminale e di poeti che rimorchiano, e qualche pagina dopo si chiede come sarebbe fare visita a James Joyce, maestro dello sperimentalismo. Non puoi che ritrovarlo “in un lontano retrocucina, dove ti offre un barattolo pieno di latticello e una ciotola di rape e anguille”.
Tira in ballo padre (lo scrittore Kingsley) e matrigna (Elizabeth Jane Howard) per provare a fare il punto su come diavolo si comincia un romanzo. E per dire che scrivere un romanzo è un’esperienza didattica. Dà consigli sui dialoghi (ridurre all’osso la punteggiatura, la gente parla per frasi brevi) e ti mostra come li scrive lui.
Basterebbe chiedersi se siamo ancora disposti a pensare che un romanzo, un certo tipo di romanzo – un romanzo che corteggia la difficoltà – possa aprire l’universo un po’ di più
Torna alla “tenaglia del cancro”, e intanto apre l’universo un po’ di più, e corteggia la difficoltà, continuamente, continuamente, mette insieme Phoebe e T.S. Eliot, e ragiona sul vivere la morte, e confessa che ci pensa in continuazione, è sempre nei suoi pensieri, “come una canzone indesiderata”.
Congeda il lettore-ospite dicendo che uno scrittore non deve giocare a fare il bambino. Non deve giocare a fare l’innocente. Poi dice: “Adesso devo prepararmi per andarmene”.