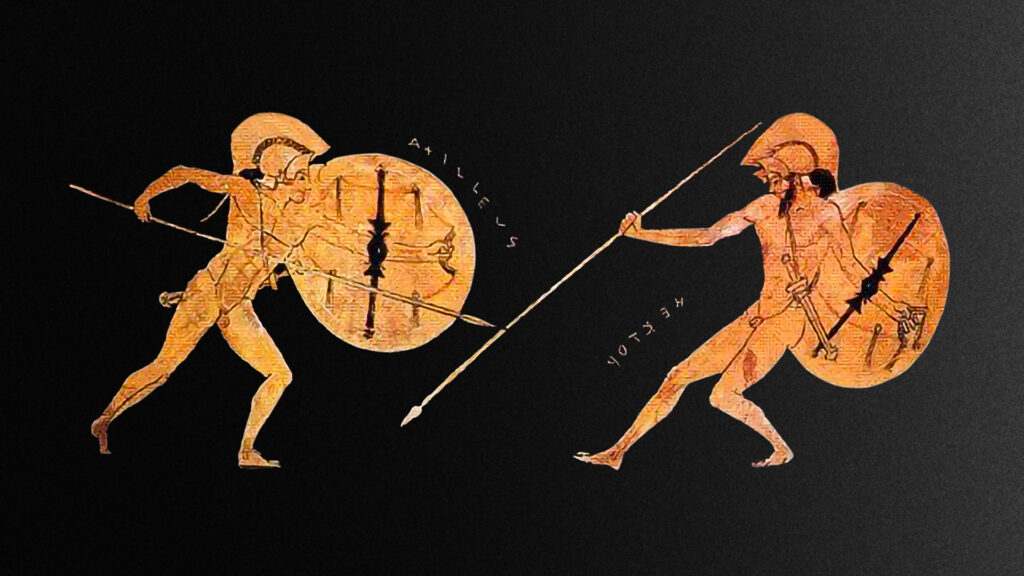Andrea Batilla
In difesa del cattivo gusto

13 Marzo 2023
Quando è nato il "cattivo gusto" e cosa dice di chi lo usa come metro di giudizio?
Andrea Batilla
Andrea Batilla è autore e consulente strategico per marchi del lusso e critico di moda. Collabora con «Domani». Il suo ultimo libro è Come ti vesti. Cosa si nasconde dietro gli abiti che indossi (Mondadori, 2022).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati