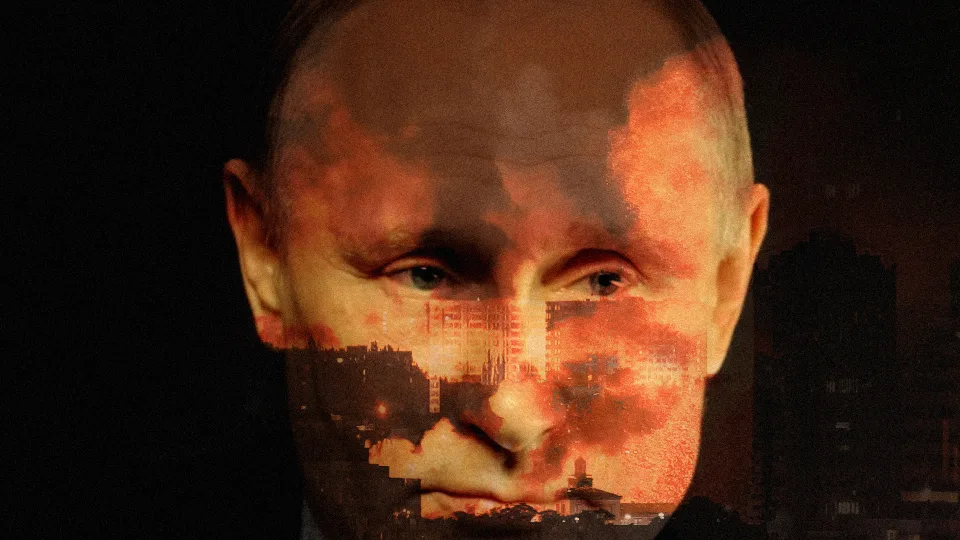Su un tema così delicato, la prima cosa da fare non è vietare o terrorizzare, ma educare e informare, anche nelle scuole: conoscere la storia delle sostanze, gli effetti, il loro rapporto con i sistemi economici. Ma il governo, che ha appena lanciato una nuova terrificante campagna, e il leader della Lega sembrano non capirlo.
Sono nato nel 1977, qualche anno dopo l’on. Salvini, e pare che lui abbia frequentato lo stesso liceo milanese che ho frequentato io. Non ho nessun ricordo di Matteo al liceo classico Manzoni nella prima metà degli anni Novanta. La scuola era un bastione della sinistra radical meneghina, in anticipo sulla sinistra ZTL che di lì a pochi anni avrebbe occupato, e ridotto, il campo della politica progressista. Ricordo un paio di fascisti che goffamente, e quasi eroicamente, cercavano di opporsi al trend politico di un intero istituto. Uno di loro si chiamava Benito, l’altro non ricordo, ma non era Salvini. Probabilmente come tutti anche lui all’epoca s’immolava al potente conformismo del liceo per cui se non vestivi in un certo modo e se non proclamavi certe idee eri inevitabilmente uno sfigato. Probabilmente come tutti anche lui si è ritrovato al centro, anzi nell’epicentro, dell’esplosione del consumo di canne che ha caratterizzato quegli anni e quella generazione (parco Sempione, piazza Vetra, per dire due luoghi emblematici). Fu un momento cruciale per la diffusione della cannabis, precedente e propedeutico a quello (ancora in corso) della progressiva legalizzazione o depenalizzazione e che, come un po’ tutto ciò che succede tra i giovani, è stato attraversato da eccessi e sregolatezze. Quello della diffusione della cannabis tra gli studenti degli anni Novanta resta un capitolo importante della storia della cultura materiale in Italia e in Europa, un capitolo forse poco raccontato: fu il momento in cui questa sostanza ha iniziato a diventare mainstream.
Il fatto che Salvini conduca da molti anni un’accanita crociata contro la canapa, persino nella sua versione non psicoattiva (CBD) e quindi perfettamente innocua, potrebbe essere la traccia del passato, la reazione a un trauma, una sofferenza vissuta in quegli anni? Il liceo era spietato. O è solo il risultato di un calcolo opportunistico? Ancora esiste una discreta percentuale di elettorato perlopiù over 60 convinta che la canapa sia una sostanza pericolosa e che dallo “spinello” si passi automaticamente all’eroina. D’altronde la più rigida legge in materia degli ultimi anni, la Fini-Giovanardi muoveva proprio dall’assunto che “nessuna droga è leggera” (se ricordo bene all’epoca una campagna di sensibilizzazione, per così dire, aveva riempito la città di manifesti con questa frase sullo sfondo di un occhio dalla pupilla dilatata) e che le droghe quindi vadano trattate tutte allo stesso modo: la droga è la droga.
Proprio in questi giorni il dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sotto l’egida del sottosegretario Alfredo Mantovano) ha messo in circolazione dei video terrificanti, nel senso che il loro unico scopo è terrorizzare per dissuadere dal consumo di sostanze psicoattive. I personaggi disegnati in questi video somigliano a morti viventi, e i peggiori effetti collaterali di ogni sostanza sono pompati per convincerci che moriremo, avremo il cancro, diventeremo psicotici “anche alla prima assunzione”. Ovviamente il tasso di pericolosità è praticamente identico per ogni sostanza, come se tra una canna e il fentanyl la differenza fosse sottile. La droga è la droga, appunto.
La campagna si chiama “Fermati. Pensaci un minuto”. Ma sarebbe meglio pensarci molto più di un minuto, in effetti. E soprattutto pensarci davvero. Perché quello che fanno questi video è solo terrorismo, non pensiero.
“Ancora esiste una discreta percentuale di elettorato convinta che dallo ‘spinello’ si passi automaticamente all’eroina. D’altronde la più rigida legge in materia degli ultimi anni muoveva dall’assunto che ‘nessuna droga è leggera’ e che le droghe quindi vadano trattate tutte allo stesso modo: la droga è la droga”.
Di sicuro l’isteria anti-cannabis delle destre non nasce da una riflessione sulle sostanze. Eppure gli studi al riguardo sono ormai numerosissimi, sia di carattere sociologico che farmacologico. Vorrei provare a fare un po’ di chiarezza non solo sulla cannabis, ma sul concetto di “droga” in generale e vorrei farlo proprio rivolgendomi a Matteo, il mio ex sconosciuto compagno di liceo, che continua anche oggi – immagino nelle vesti di Vicepresidente del consiglio, più che in quelle di Ministro dei trasporti – a portare avanti la sua battaglia, condivisa da tutta la destra parlamentare. Ho la presunzione di credere che queste righe possano essere molto più utili di quei video, anche e soprattutto ai giovani leghisti, se ne esistono ancora – e anche ai tuoi figli, Matteo, perché no.
Potremmo iniziare dicendo una cosa apparentemente provocatoria ma in fondo molto ragionevole: la droga non esiste. In inglese “drug” significa “farmaco”, e giustamente. Non esiste una categoria di sostanze unite da una o più caratteristiche comuni, tali da poterle tutte incasellare sotto l’unico termine e concetto di “droga”. Oppure, se questo insieme esiste, è così ampio da rendere perfettamente inutile la classificazione, almeno per gli scopi che si prefiggono quelli come te, cioè il proibizionismo demagogico. Dovresti vietare tutto.
Ma spieghiamo meglio.
Credo che il modo più semplice per delimitare il concetto di “droga” sarebbe quello di collocarla all’incrocio di tre variabili, vale a dire:
1) La capacità di una certa sostanza di creare dipendenza;
2) La capacità di una certa sostanza di alterare la percezione (il suo carattere psicoattivo);
3) La dannosità di una certa sostanza per il nostro organismo.
Il terzo punto è naturalmente legato al primo, perché la dipendenza conduce all’abuso e qualsiasi sostanza, anche la Nutella che tanto ti piace, Matteo, se assunta in quantità esagerate può fare molto male al nostro corpo.
Il secondo punto potrebbe da solo bastare a censurare una sostanza, almeno per i moralisti. Non a caso nel mondo islamico l’alcol è perlopiù vietato. Il Profeta non vuole che i suoi adepti siano alterati. L’unica alterazione possibile è quella mistica, e si raggiunge con la preghiera e la devozione. Anche una parte di puritanesimo cristiano professa la sobrietà assoluta e questa parte ha contribuito molto (almeno secondo il sociologo Max Weber) a creare quel clima di alacrità lavorativa all’origine del capitalismo nordeuropeo. Ayn Rand, una scrittrice e filosofa morta nel 1982 che ha ispirato un gran numero di importanti imprenditori (tra cui Elon Musk), nei suoi libri insiste ossessivamente sul fatto che devi essere assolutamente “focused”, focalizzato, concentrato, se vuoi avere successo.
I capitalisti hanno peraltro interpretato il precetto della lucidità a modo loro, e sostanze utili a essere lucidi, produttivi e focalizzati hanno finito col carburare il progresso dei nostri mercati. Parlo di stimolanti di varia natura, dalla caffeina alla cocaina (che per molto tempo è stata legale), fino ad arrivare a farmaci e molecole sintetiche come l’Adderal o il Ritalin che sono stati e sono ancora assunti, nella piena legalità, da moltissimi adulti che cercano di essere più produttivi e purtroppo anche da molti giovanissimi in età scolare che per qualche ragione sono considerati improduttivi. Persino certi psichedelici oggi vengono promossi come strumenti che aumentano la produttività.
“Potremmo iniziare dicendo una cosa apparentemente provocatoria ma in fondo molto ragionevole: la droga non esiste”.
D’altronde anche nel mondo islamico, accanto al divieto dell’alcol, si nota la tolleranza per altre sostanze tradizionali che aiutano a lavorare e a essere lucidi (ergogeniche): penso a stimolanti come il khat tra Africa orientale e penisola arabica, ma soprattutto al tè e ancora al caffè, che in certi luoghi vengono consumati in grandissime quantità. La caffeina è uno stimolante piuttosto potente e molti sono costretti a ridurne o interromperne il consumo perché impatta fortemente sul sistema cardiovascolare.
Secondo Michael Pollan, un autore statunitense che ha molto riflettuto sulle “droghe”, chi la mattina non è in grado di fare nulla senza prima aver bevuto un caffè è nella stessa condizione fisiologica di un tossico in crisi d’astinenza. Certo la crisi d’astinenza da caffè è meno violenta di quella da crack o eroina (e il caffè al contrario dell’eroina ci aiuta a essere socialmente attivi), ma è più forte per esempio della crisi di astinenza da cannabis, una sostanza che non genera forti dipendenze.
La capacità di una sostanza di creare dipendenza dovrebbe senz’altro essere al centro dell’attenzione di qualsiasi legislatore interessato a regolare la circolazione di determinate “droghe”. Il problema è che da questo punto di vista la nostra è una società molto drogata: siamo tutti addicted. Faccio un esempio che potrebbe sembrare fuori luogo ma non lo è: il telefonino non è propriamente una sostanza, ma è qualcosa che genera un tasso altissimo di comportamenti additivi. Potremmo dire che il telefono somministra sostanze simboliche altamente intossicanti. Eppure lo diamo ai nostri figli non appena passano alle medie, a undici anni, e anche prima. La cocaina è considerata tra le sostanze che provocano più dipendenza, almeno tra gli stimolanti, molte persone ne fanno uso o ne hanno fatto uso ma non gli verrebbe mai in mente di darla al figlio di undici anni. Invece il cellulare sì.
Il rapporto tra “droghe” e tecnologie è molto studiato, ed è al centro di un intero genere dell’immaginario letterario e cinematografico che si chiama cyberpunk. Matrix, pillola rossa o pillola blu: lo conoscerai pure tu, Matteo, quando è uscito avevamo vent’anni. Vivere in internet e sui social non è solo qualcosa che genera assuefazione, ma lo fa perché altera la nostra percezione del mondo. Non genera propriamente allucinazioni (anche se grazie alle immagini sempre più realistiche generate artificialmente stiamo entrando in una fase chiaramente allucinatoria del mondo digitale), ma quell’attimo di piacere che sentiamo quando riceviamo una notifica, un commento al nostro post, quel brivido di eccitazione che proviamo quando un nostro video viene condiviso, ecc. tutto ciò produce aumenti di dopamina e di altre sostanze nel cervello che ci portano a cercarlo di continuo. Insomma funziona esattamente allo stesso modo di molte “droghe” classiche. Ci fa stare bene: ci fa credere di stare bene. E genera dipendenza.
“La prima cosa da fare non è vietare o terrorizzare ma educare, informare, per esempio nelle scuole: in un mondo sempre più ‘drogato’ i ragazzi dovrebbero sapere che differenza c’è tra un sedativo, uno stimolante, uno psichedelico eccetera”.
Le sostanze che producono una più netta alterazione della coscienza (punto 2) sono i cosiddetti psichedelici, la maggior parte dei quali, a differenza degli stimolanti di cui abbiamo parlato sopra, sono del tutto innocui rispetto al rischio di dipendenza (punto 1) e molti dei quali hanno un impatto sul nostro organismo molto più basso di un’abbuffata di dolciumi o di una robusta bevuta di vino (punto 3).
Opporsi a queste sostanze significa soprattutto opporsi al tipo di alterazione che producono: è legittimo, ma almeno dev’essere chiaro che non è per altre ragioni. Quando nel 2020 l’ayahuasca è stata messa fuori legge è stato fatto in nome di un principio puritano: la coscienza deve restare lucida. Principio poco coerente con altri pezzi di legislazione che accettano non solo che qualcuno abbia le traveggole in seguito al consumo di alcolici, ma anche che questi ultimi possano essere mixati a energy drink pieni di taurina o caffeina producendo alterazioni ben più pericolose di quelle vissute da gente sdraiata sopra dei tappetini da yoga in una casa di campagna dopo avere bevuto un decotto di liana tropicale.
Il tabacco è una sostanza che produce un’alterazione della percezione piuttosto lieve, ma è molto cancerogeno e genera moltissima dipendenza. È una droga? La regolazione del tabacco in Italia è blanda: vietato a chi ha meno di 18 anni, vietato in luoghi pubblici. Ricordo che a un certo punto (se non sbaglio all’epoca eri ministro dell’Interno) tu facesti di tutto per impedire il diffondersi della sigaretta elettronica (con atomizzatore), molto meno dannosa per i polmoni della sigaretta normale in quanto non implicava alcuna combustione. Si diceva che il tuo comportamento fosse influenzato dalla potente industria del tabacco la quale, mentre sviluppava un’alternativa meno aggressiva alla sigaretta tradizionale (iqos e simili), cercava di limitare il diffondersi della sigaretta elettronica con dentro liquidi e aromi invece che tabacco.
Un grosso problema delle nostre società, conclamato in USA ma che potrebbe presto esplodere anche in Europa, è quello legato agli oppiodi sintetici. Non è questo il luogo per rievocare le guerre dell’oppio e l’uso che l’Occidente coloniale ha fatto di questa sostanza a scopi politici e commerciali. Oggi la Cina vende al Messico delle componenti chimiche che servono a produrre clandestinamente gli oppioidi che stanno mettendo in ginocchio un pezzo di popolazione americana, e girano dei meme che equiparano la vecchia guerra dell’oppio a questa nuova guerra chimica. L’amministrazione Biden sta provando in tutti modi a bloccare l’esportazione dalla Cina di quei farmaci ma ovviamente la Cina ha buone ragioni per usarle come leva di potere geopolitico. Più che le considerazioni morali dietro alle politiche sulla droga spesso si nascondono interessi giganteschi.
Spesso si diventa dipendenti da oppiodi sintetici dopo che questi sono stati regolarmente prescritti come antidolorifici. Molti farmaci regolarmente prescritti rientrano a pieno titolo nello schema a tre assi che ho immaginato sopra. Ho già nominato gli stimolanti usati per concentrarsi, ma cosa dovremmo dire dei diffusissimi regolatori dell’umore, antidepressivi, ansiolitici ecc? Quanto cambia la nostra percezione se da un’immagine triste del mondo, grazie a una pasticca di benzodiazepina, passiamo a una visione più serena e pacificata? Si tratta di un’alterazione della percezione, senza dubbio, e di un’alterazione importante. Quante persone dipendono da questi farmaci? E che effetti possono avere a lungo andare sul nostro organismo? Sono così diversi nei loro effetti immediati da sostanze come l’MDMA? E se non lo sono, perché vengono prescritte così facilmente mentre l’MDMA è classificato come sostanza pericolosa?
“La nuova campagna antidroga del governo si chiama ‘Fermati. Pensaci un minuto’. Ma sarebbe meglio pensarci molto più di un minuto, in effetti. Perché quello che fa questa campagna è solo terrorismo, non pensiero”.
La risposta è sempre la stessa: resistenze culturali, interessi economici.
Le “droghe” esistono da che esiste l’uomo, in ogni società: l’archeologia e la etnobotanica ce lo hanno insegnato. Persino gli animali assumono deliberatamente sostanze psicoattive, in determinate circostanze. “Drogarsi” è parte dell’interazione tra l’organismo animale e l’ambiente in cui vive, è uno modo per creare un’omeostasi, un equilibrio funzionale tra gli individui e il mondo che li ospita.
Noi viviamo in una società liberale e post-tradizionale. Questo significa che dovremmo affrontare il discorso sulle sostanze psicoattive basandoci sul principio di lasciare a ognuno la massima libertà possibile nella misura in cui questa libertà non danneggia gli altri, e soprattutto che dovremmo valutare la regolazione delle sostanze non sulla base di usi arcaici e tradizionali, o di “valori” estrapolati da questi usi, ma valutando caso per caso l’utilità e il danno che le sostanze possono arrecare ai nostri organismi e alle nostre società.
Aggiungiamo che la tecnologia (medica, biomedica, ma anche informatica, elettronica, ecc.) sta rendendoci sempre più “drogati”, non solo nel senso di “stimolati” (e quindi anestetizzati), ma anche perché sempre più dipendenti da costrutti artificiali capaci di modificare la nostra percezione “naturale” del mondo. In questo senso, indubbiamente, le nostre società saranno sempre più alterate e nulla potranno le politiche proibizionistiche, soprattutto quelle basate su calcoli elettorali e non su una reale preoccupazione per la salute pubblica. Come le tue, Matteo.
La prima cosa da fare non è vietare o terrorizzare ma educare, informare, per esempio nelle scuole: in un mondo sempre più “drogato” i ragazzi dovrebbero sapere che differenza c’è tra un sedativo, uno stimolante, uno psichedelico eccetera. Dovrebbero conoscere la storia delle sostanze per capire gli effetti che la loro diffusione ha avuto nelle società del passato. Il loro rapporto con i sistemi economici. Dovrebbero conoscere la differenza tra usi terapeutici e ricreativi. Dovrebbero capire l’importanza dell’origine delle “droghe” (da dove provengono), della posologia e dei vari effetti collaterali (i video della Presidenza del Consiglio dei Ministri parlano solo di abusi, non di usi), se sono sostanze testate o smart/designer drugs inventate apposta per aggirare le tabelle ufficiali e che quindi non hanno alle loro spalle ricerche e conoscenze (e pratiche) tali da permetterci di considerarle sicure. In mancanza di un reale interesse al consumo informato da parte dei governi esiste una diffusa citizen science che si esprime attraverso forum online e siti e associazioni come Erowid dove è possibile ottenere informazioni affidabili e confrontarsi con altre persone. Ma esistono anche governi che lo hanno capito e che lavorano seriamente, onestamente, in questo senso: per esempio in Olanda, tra le molte cose, hanno fatto dei video informativi, Drugslab. Fa un po’ impressione, Matteo, metterli a confronto con quelli del nostro governo.
Vietare per vietare (o per interessi elettorali) non è solo inutile, ma come tutti sanno sortisce effetti contrari, almeno tra i giovani che notoriamente amano trasgredire. Voler proibire un blando miorilassante (cioè una sostanza che ha effetti simili a quelli della camomilla) come la CBD è segno di una miopia che sbalordisce, soprattutto quando a guidare questa pseudo-battaglia è una persona cresciuta negli anni Novanta e che quindi dovrebbe avere uno sguardo un minimo smaliziato sulla canapa. Lo so, scusami se mi ripeto: la tua non è ignoranza ma interesse politico. Magari ci siamo pure trovati a fumare una canna nei cessi del Manzoni nel 1994 mentre imprecavamo contro Berlusconi. Non è da escludersi: mentre Benito appendeva di nascosto volantini sull’ubermensch, tu inneggiavi alla rivoluzione come tutti. Oggi hai deciso che ti conviene scagliarti contro la camomilla. E vabbè. La politica non è il luogo della verità ma per fortuna esistono altri spazi in cui confrontarsi e imparare: come appunto le scuole (e anche i loro cessi), certi libri, certi giornali, certi luoghi dell’internet, le feste (in Inghilterra le chiamano rave), o le strade dei quartieri veri, quelli vissuti, dove si incontrano i tossici che stanno male, ma anche le persone che sono disposte ad aiutarli. Tutti posti, insomma, dove di sicuro non incontreremo te, Matteo, e la gente come te, e in cui perciò vale la pena di andare, e vivere, per sforzarsi di capire il mondo.