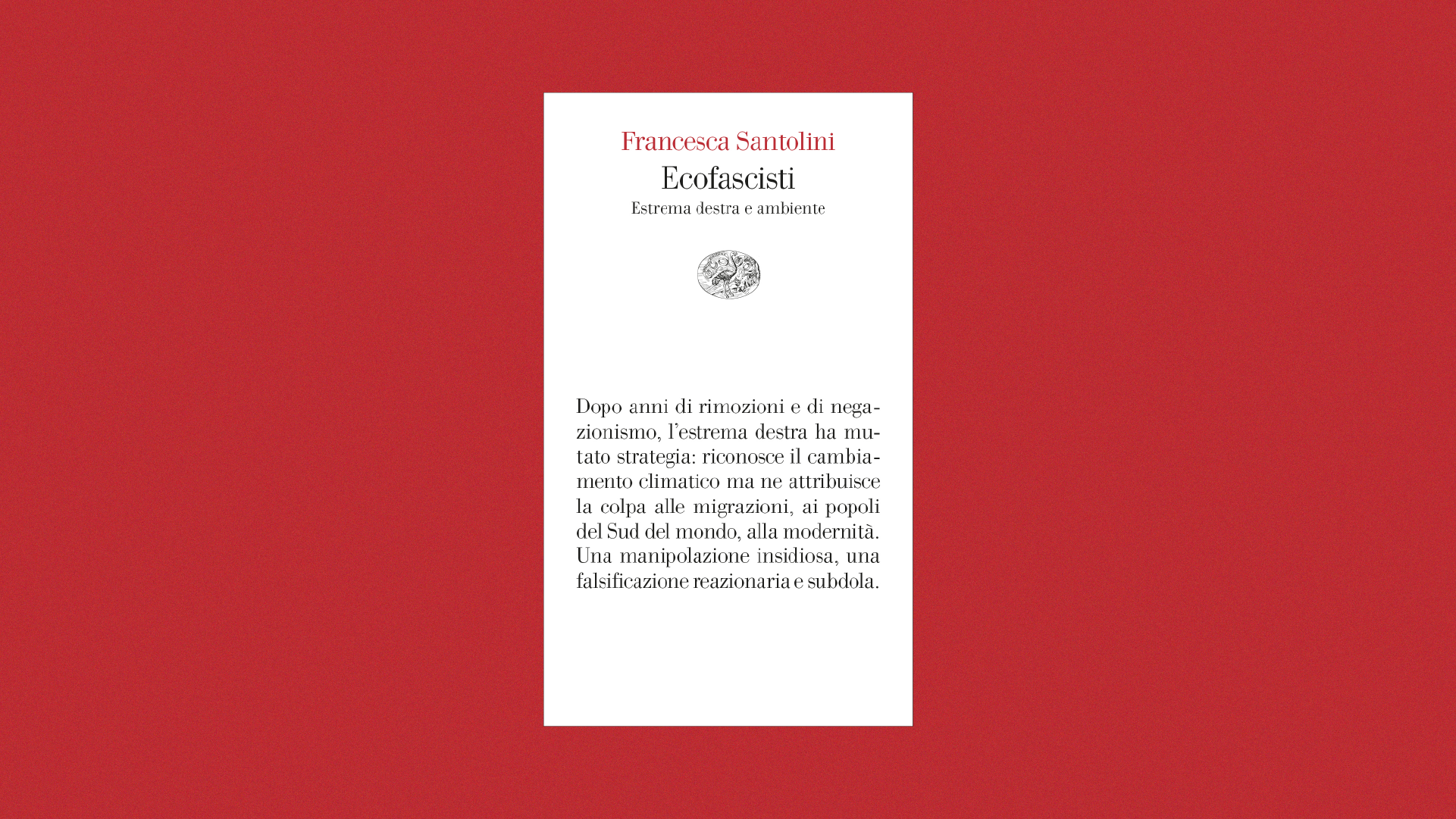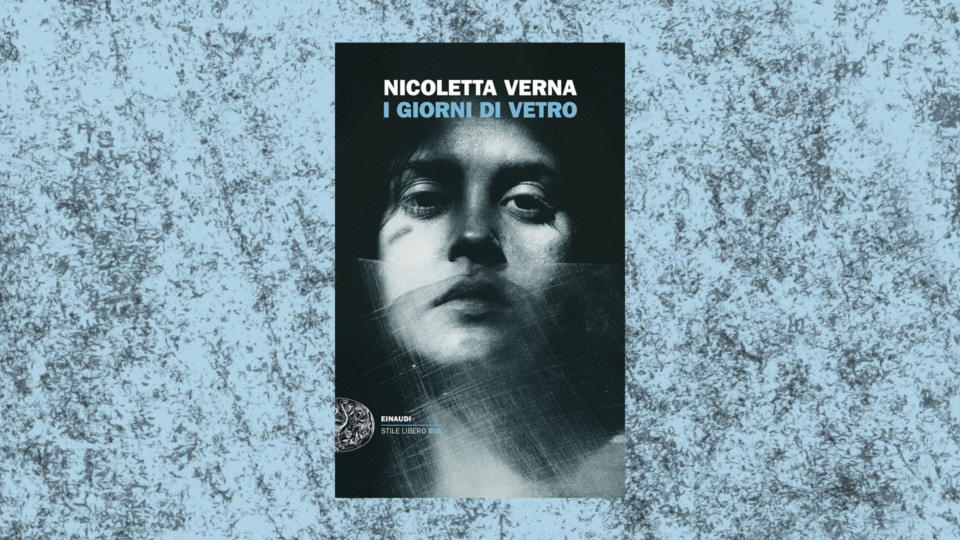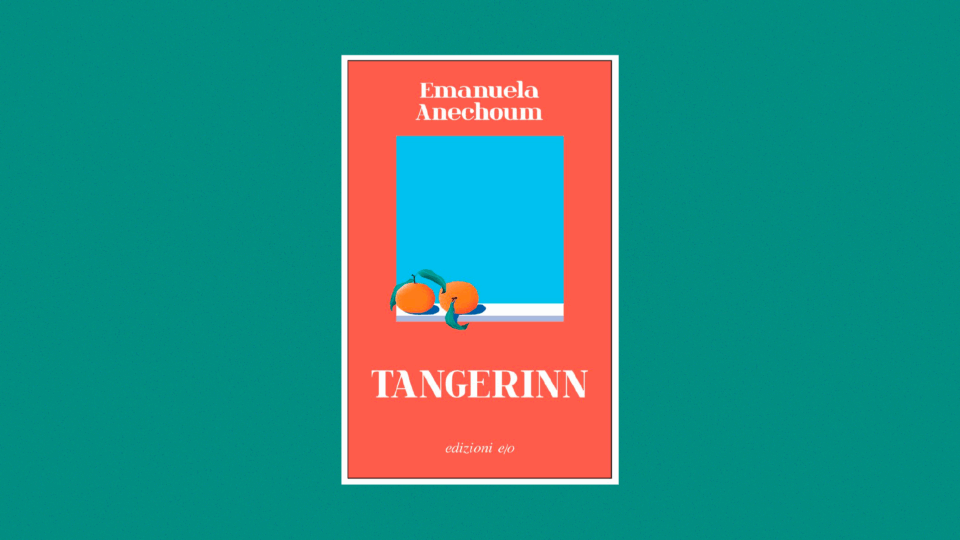Non scusarti per quel che hai fatto, la raccolta di Mahmud Darwish appena uscita da Crocetti sotto la cura di Sana Darghmouni e Pina Piccolo, appartiene all’ultima fase della produzione poetica dell’autore, comunemente riconosciuto non solo come uno dei più grandi poeti palestinesi della sua generazione, se non il più grande, ma più in generale come uno dei più importanti di lingua araba dell’intero Novecento.
Del resto Darwish, nato nel 1941, è morto nel 2008: e quindi Non scusarti, che risale al 2004, precede davvero di poco la sua scomparsa. Erano anni, come precisa il risvolto di copertina, caratterizzati “dalla transizione dalla fase rivoluzionaria e patriottica degli esordi (la ‘poesia della resistenza’)” alla “rielaborazione del dramma palestinese” attraverso una scrittura incentrata piuttosto “sulla complessità dell’esistenza, sul dialogo tra il sé e l’altro e sull’osservazione dell’umanità attraverso la descrizione di luoghi storici, mitici e del quotidiano”.
In effetti, Non scusarti può essere letta come una raccolta dai contenuti esistenziali e memoriali tout court. Monica Ruocco osserva nella prefazione: “Darwish affronta il tema dell’inesorabile declino dell’esistenza e del disfacimento del ricordo, che si fa sempre meno tangibile e sempre più immaginario”, come a voler ricostruire “una propria poetica dei luoghi e dei sentimenti”.
È così: i versi della raccolta sembrano tutti attraversati da un senso retrospettivo della vita, come di chi si volta a guardarla un’ultima volta, ripercorrendola dall’inizio – un senso non necessariamente nostalgico, ma comunque “ultimo” e definitivo. Ecco, è come se Darwish fosse stato già consapevole, mentre scriveva, del fatto che Non scusarti avrebbe rappresentato il suo commiato non solo dalla poesia ma anche dall’esistenza: lo rivela, in fondo, anche il tenore del titolo.
A ben vedere Darwish parla a sé stesso e con sé stesso, più che a noi che lo leggiamo. Ed è infatti a sé stesso, e non ad altri, che rivolge anche l’invito a non scusarsi per quel che ha fatto o non ha fatto. Se è vero, insomma, che non esiste poesia che non abbia un proprio “tu” d’elezione, in questo caso il “tu” della poesia di Darwish coincide, né più né meno, con il suo stesso “io”.
O meglio: con la molteplicità di “io” che ognuno di noi contiene, o avrebbe potuto contenere, nella propria vita. Pensiamo ad esempio, fra i molti, a versi come questi: “Quindi esci dal tuo ‘io’ verso il tuo altro /e dalla tua visione verso i tuoi passi” (p. 31); “sono io / davvero io?” (p. 97); “In Siria io sono io, / nessuno è il mio sosia o il mio fantasma. Il mio domani e / io siamo mano / nella mano e svolazziamo tra le ali di un uccello” (p. 141).
Conteniamo moltitudini, si sa; e quello che siamo è solo uno degli infiniti esiti di ciò che avremmo potuto essere, di ciò che saremmo diventati se le cose fossero andate diversamente. Cosa ne sarebbe stato, di noi, se avessimo o non avessimo fatto quel certo incontro? Se avessimo o non avessimo perso quella certa occasione? Ma è proprio questo il terreno sul quale la riflessione di Darwish risulta pur sempre inestricabilmente legata alla storia palestinese, per quanto rielaborata: è come se fosse quello, in ogni caso, il suo orizzonte ineludibile, lo sfondo di qualunque altra considerazione ed emozione.
“Cosa ne sarebbe stato, di noi, se avessimo o non avessimo fatto quel certo incontro? Se avessimo o non avessimo perso quella certa occasione?”
Per Darwish, domandarsi cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente significa anche chiedersi cosa sarebbe successo se la storia palestinese fosse stata diversa, e se il suo destino fosse stato diverso dall’esilio: non esiste, nel suo caso, nessuna distanza fra storia privata e storia collettiva, fra eventi e drammi individuali ed eventi e drammi di un popolo. Il suo “io” rimane sempre un “io” fortissimamente palestinese: anche quando, come in questa raccolta, sembra più ripiegato su un proprio sé esclusivamente privato. E questo per il semplice motivo che la sua vita sarebbe stata diversa, senza esilio.
Non deve stupire allora la pervasività, lungo tutta la raccolta, dei riferimenti al “mio altro io”. Ne troviamo, espliciti o impliciti, non in ogni pagina ma quasi: “Sussurrai dunque al mio altro ‘io’: / ‘È quello che eri una volta tu io?’. Ma distolse lo / sguardo da me /e i testimoni si rivolsero verso mia madre per farle/ testimoniare / che fossi lui …” (p. 27); oppure, “Cammino come se fossi un altro da me” (p. 53); o “Più si allunga la via, più si rinnova il significato / e mi sdoppio / in questa via: io… e il mio altro!” (p. 131).
Ma chi è questo “altro io” continuamente evocato se non l’io dello stesso Darwish alle origini? Se non l’io di un tempo passato, quasi primordiale, nel quale ancora poteva essere immaginato o sognato un altro futuro, un altro domani? Un domani che sarebbe andato “mano nella mano”, con quell’io non ancora dissociato: come “tra le ali di un uccello”, alto sulla Storia. E vuol dire, tutto ciò, che vivere è stato inutile? Che la vita, per come è stata vissuta, non valeva la pena di esserlo? Il tradimento inferto all’io dal suo “domani” è stato a tal punto insuperabile da condannare anche la morte, oltre che la vita? Da aver disperso a tal punto l’identità dell’autore? Da non consentire di ritrovarla o recuperarla neppure nella memoria e nel momento del commiato?
No: nonostante tutto, non sono queste le conclusioni. Darwish sembra chiedersi: chi sono, oggi? Chi sono diventato? E la risposta che si fornisce non è diversa da quella che, fra gli altri, si dava Elias Canetti nella Lingua salvata: “La mia identità è il mio linguaggio. Io … / io … / sono il mio linguaggio. Sono l’esiliato nella mia lingua”. È la medesima risposta, forse l’unica possibile, che possono darsi in definitiva tutti coloro che hanno conosciuto l’esilio e non hanno più una terra o non l’hanno mai avuta: tutti coloro che di sé stessi e della propria appartenenza conservano la radice, e nient’altro. Non una casa, non un campo, non un albero. Solo i ricordi, tutt’al più: appunto come quelli che danno corpo allo sguardo retrospettivo e memoriale di Darwish. Potrebbero essere ricordi disperati e disperanti, ma non lo sono: e non lo sono perché a venarli di dolcezza è proprio la consapevolezza che, nonostante l’esilio, l’identità è tuttavia salva almeno nel suo grumo originario, almeno nella lingua.
E non è solo salvezza del passato: è anche fondazione del futuro. Ha di nuovo ragione Monica Ruocco quando scrive che “L’impressione preliminare di commiato e resa a una inesorabile notte, diventa improvvisamente un luminoso scenario aperto sul futuro. Il poeta di al-Birwa sembra, in fondo, indicare ai suoi lettori un percorso di consapevolezza da cui non si può non uscire vittoriosi”.
E forse nessun altro verso lo dimostra come questi:
Un altro giorno verrà, un giorno femmineo,
alla metafora trasparente, compiuto,
diamantino, di visita nuziale, soleggiato,
fluido, allegro. Nessuno sentirà
alcun bisogno di suicidio o migrazione
La retrospezione e la memoria, alla fine, si sono trasformate in fiducia e speranza.