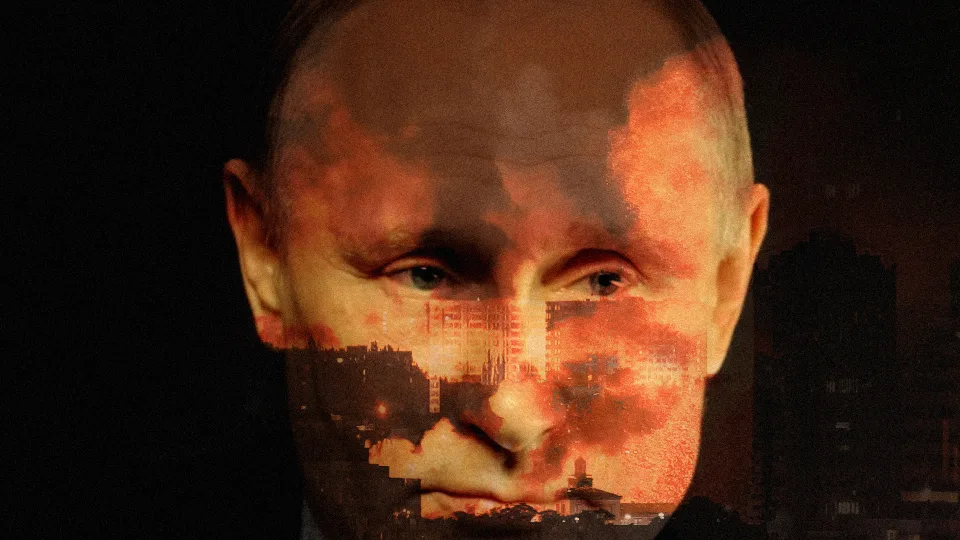Guardato con sufficienza, considerato prova della scarsa vena creativa del cinema contemporaneo, il biopic è però un genere molto frequentato dagli autori e amatissimo dal pubblico. Perché? Una riflessione sul tema in occasione dell'uscita in Italia di “Prima danza, poi pensa - Alla ricerca di Beckett”, il film che racconta la vita del grande scrittore.
“Il più disdegnato dei generi cinematografici viene sistematicamente accusato non solo di fare il tira e molla con la verità, ma anche, banalmente, di essere una noia mortale”, scrive Andrew Chan a proposito di Center Stage, film del regista hongkonghese Stanley Kwan incentrato sulla carriera dell’attrice Ruan Lingyu.
Eppure, il biopic sembra essere sempre di moda. Negli ultimi due anni, e solo tra quelli più pubblicizzati, la lista dei film ascrivibili al genere è lunga: Priscilla, Ferrari, Napoleone, Maestro, Oppenheimer, Jeanne du Barry. E ancora: Elvis, Blonde, Corsage, Gucci e ora anche Prima danza, poi pensa sulla vita di Samuel Beckett.
Se da una parte questa tendenza può essere letta come sintomo della perenne saturazione inventiva di Hollywood, dall’altra attesta la longevità e inesauribilità di un genere che, pur con tutti i suoi limiti e manierismi, continua ad attirare chi lo fa e chi lo guarda. E siccome stiamo parlando di biografie al cinema, tanto vale cominciare dall’inizio – che, come molti biopic insegnano (penso a Gandhi, per citare un classico), molto spesso significa partire dalla fine.
Da qualche tempo, per lavoro, mi devo saltuariamente occupare di contenuti di realtà virtuale. Scrivo “contenuti” perché detesto il mezzo e faccio fatica a considerare i suoi prodotti alla stregua di film tradizionali, anche se molti fanno ricorso a convenzioni narrative e formali tipiche delle opere cinematografiche (tanto da sviluppare già sottogeneri propri, come quello della “migrant experience”: Only the Mountain Remains, o Carne y Arena, ad esempio, dove la linearità della trama si appoggia al percorso di fuga del personaggio, sfruttando stereotipi dell’action movie e tecniche del cinema documentario – non diversamente da come faceva, per altro, il capolavoro di László Nemes Son of Saul).
Prima di acquisire familiarità col mondo VR, che è una specie di far west molto variegato, osservavo con avversione i potenziali produttori del nuovo mezzo, gongolanti all’idea di sfruttare “film” di quel genere per scopi del tutto inediti. In campo medico o terapeutico, ad esempio, oppure politico, sicuramente in quello educativo o sportivo: cioè utilizzando il formato per ottenere risultati concreti nel mondo reale. Raramente le nuove tecnologie finiscono per essere impiegate come ci si auspicava in origine, e quindi quel genere di entusiasmo smodato mi sembra sempre miope.
Riesco a comprendere questa visione solo paragonandola a quella dei pionieri del cinema, immaginandoli di fronte all’incredibile prodigio di poter registrare la realtà. Dopo l’iniziale stupore, però, chi rimane a guardare (pagando, addirittura) filmati di operai che escono dalla fabbrica o treni che arrivano in stazione? La magia di poter fissare lo scorrere del tempo viene rapidamente scalzata dalla possibilità di manipolarlo.

Ecco che, sul finire dell’Ottocento, a Parigi come a New York, compaiono ometti tarchiati e imprenditori da strapazzo che si sfregano le mani le mani all’idea di poter inscenare la passione di Cristo, l’uccisione di Giulio Cesare o la rivolta di Spartaco in una manciata di minuti o al massimo un paio di ore.
In un mondo ancora vergine rispetto al concetto di proprietà intellettuale, a fare gola non è tanto il repertorio di storie prive di copyright – cosa che oggi, invece, determina molti degli adattamenti cinematografici – quanto poter giocare sulla dimensione collettiva della narrazione epica, sulla portata ideologica e pedagogica di figure storiche, ora capitalizzabili anche come fonte di intrattenimento.
La Giovanna d’Arco di Méliès (1906) è tra i primi biopic che passano alla storia (sic), ma né il suo successo né la notorietà della vicenda scoraggia la realizzazione di un secondo rifacimento altrettanto se non più celebrato (quello del 1928 di Carl Theodor Dreyer), e poi tanti altri (nel 1948, di Victor Fleming con Ingrid Bergman, del 1957 di Otto Preminger, nel 1999 di Luc Besson, nel dittico del 2017-2019 di Bruno Dumont).
Adattamenti, rifacimenti, ricostruzioni, remake: i biopic sembrano sfidare o assecondare la nostra tolleranza alla ripetitività. A una superficiale mappatura delle opere più note o recenti, vediamo sottogeneri perlopiù interessati a ribadire lo status quo dei propri protagonisti in un certo campo di eccellenza. Più raramente, introducono unə illustre sconosciutə, con lo scopo di correggere fatti storici noti.
Ci sono politici, regnanti, uomini di potere (Lincoln, Berlusconi in Loro, JFK). Oltre alle dinastie di nobildonne inglesi, anche qualche statista femmina (The Iron Lady, Evita, Golda cioè Meir – ritratta nel 1977 da Ingrid Bergman e nel 2023 da Helen Mirren). Gli atleti, come Senna, I, Tonya, Borg vs McEnroe e i pugili, che hanno sempre i titoli più poetici, come Toro scatenato, Cinderella Man, Foxcatcher. Gente della musica e dello spettacolo come Barbara, Dalida, Bird, Ray, Walk the Line, I’m Not There, Rocketman. Gli attivisti, apprezzabili per la loro funzione divulgativa: Harvey Milk, Norma Rae, Erin Brockovich, Silkwood, I cento passi, e i fuorilegge, gruppo apprezzabile e basta: Lucky Luciano, Bonnie & Clyde, Nemico Pubblico. Non mancano i geni tormentati della scienza, come in The Imitation Game, A Beautiful Mind, La teoria del tutto e i reietti geniali di varia sorta come Tove (Jannson) o Man on the Moon (Charlie Kaufman).
Ci sono anche gli inventori, i letterati, gli esploratori… ma snocciolate così, queste categorie ricordano campi da barrare sotto la voce “chi vuoi diventare da grande” in un fantomatico formulario esistenziale, piuttosto che esempi d’eccellenza per esplorare vari settori delle nostre società. Perché spesso la persona al centro della rappresentazione sembra essere del tutto irrilevante. Almeno osservandolo dal punto di vista formale, il biopic è un genere che sguazza nel cliché, che applica indiscriminatamente stilemi narrativi simili a personaggi e contesti molto distanti tra loro. Effetto collaterale della necessità di sintesi o conseguenza della pigrizia di autori che considerano i loro soggetti unici al punto da invogliare la visione a prescindere?
A canonizzare il genere è, fortuitamente, un film che non vi appartiene. Citizen Kane di Orson Welles risponde al problema annunciato in sua apertura—“Seventy years of a man’s life – that’s a lot to get in a newsreel!”—inventandosi o perfezionando molti di quelli che diventeranno classici tic del biopic: la biografia a ritroso, con la morte del protagonista come incipit; il racconto in ripetuti flashback; le origini umili, ordinarie; la personalità irriverente ed eccentrica che si rivela con la maggior età; la resistenza e/o sfiducia da parte dei poteri forti (genitori, tutori, stato) di fronte a un progetto esistenziale; pochi adepti fidati, vinti con la forza del carisma o del genio; l’ascesa vittoriosa e conseguente accenno di hybris; lo sviluppo di manie inedite, dipendenze e/o tratti caratteriali dispotici con l’avvicinarsi al picco; l’avidità; l’adulterio; la caduta; l’abbandono dei fidati; la solitudine; la rinascita (con ripetizione dei segmenti positivi qui sopra, ma accelerati) o la misera morte.
Eppure, siamo di fronte a un film inclassificabile. Il bello è che Charles Foster Kane è un personaggio di finzione, magari “ispirato a”, ma di fatto mai esistito. Ne consegue maggior libertà per chi il personaggio l’ha creato, Welles e co., ma anche per chi lo guarda sullo schermo: il pubblico degli anni Quaranta e Cinquanta (quando il film gode di una seconda distribuzione in Europa) abituato a leader tirannici col disturbo della personalità, non vede l’ora di osservare da vicino la caduta di figure simili o identificarsi nella rivalsa dell’uomo comune. Soprattutto, nell’omologazione della società di massa, non vede l’ora di spiare nella vita privata dell’individuo che ce l’ha fatta.
“Il biopic è un genere che sguazza nel cliché, che applica indiscriminatamente stilemi narrativi simili a personaggi e contesti molto distanti tra loro. Effetto collaterale della necessità di sintesi o conseguenza della pigrizia di autori che considerano i loro soggetti unici al punto da invogliare la visione a prescindere?”
Fra tutte le sue novità, Citizen Kane esplicita la qualità più bizzarra del biopic: (tendenzialmente) sappiamo cosa succede, come finisce la storia. A tenerci incollati, allora, è un certo voyeurismo. Oppure una certa pedanteria. Applicare la verosimiglianza o l’aderenza alla verità come unico criterio di giudizio nella valutazione di una biografia è il modo più facile per decretarne il fallimento.
Al cinema poi, il tic – questa volta nostro – è ancora più letale se conduce alla domanda: ha offerto una metamorfosi convincente? Perché sulla gobba di Elio Germano in Il giovane favoloso non ci sono tracce della forfora del nostro poeta, come leggenda vuole? Com’è possibile che Willem Dafoe dica solo tre parole in italiano in Pasolini, e a chi è venuta l’idea che Riccardo Scamarcio potesse trasformarsi in un buon Ninetto Davoli? Sono quesiti che io stessa mi sono posta, ma non sono quelli giusti per valutare la riuscita di un biopic.
Forse la risposta alla domanda “perché molti adattamenti sono noiosi” è semplicemente: chi li realizza si preoccupa solo della verità e non della vita. La quale, come prima caratteristica, ha evidentemente di essere vitale.
La noia – nel guardare storie che già conosciamo o che conosciamo per la prima volta ma ci vengono raccontate secondo modalità trite e ritrite – si sconfigge stimolando il piacere della scoperta ma anche quello dell’immaginazione.
Prendiamo un esempio recente, Oppenheimer. La mia esperienza può essere sintetizzata così: prima della visione, noia preventiva nei confronti del dibattito polarizzato, disinteresse generico nei confronti del regista. Durante la visione: noia ad intermittenza per l’impiego di certi cliché narrativi (gli inizi tormentati prima, la devozione quasi autistica alla causa poi), ma anche confusione, empatia, apprendimento e messa in dubbio (di certi dettagli scientifici e storici), tensione (per certe soluzioni visive), indignazione, divertimento (per la forzatura volontaria di certi cliché, certi personaggi-macchietta). Dopo la visione: una sensazione quasi tangibile, come un retrogusto passeggero o un odore inedito, che aleggia nell’anticamera dei sensi e si protrae nel sonno, e poi nella memoria, come il ricordo di un evento che è realmente accaduto.
In questi casi, per qualche ora o anche per qualche giorno, si ha l’impressione di essere visitati da una presenza: è il fantasma del soggetto biografico o la visione – invadente, claustrofobica, megalomane, come nel caso di Christopher Nolan – di chi ce l’ha raccontata?

La risposta promette di essere altrettanto tediosa, ma i due poli che tocca forse spiegano l’interrogativo originario. Perché, nonostante tutto, i biopic continuano ad avere successo. Lo si vede nello swag di una delle prime sequenze de Il Divo, che introduce la squadra di Giulio Andreotti mentre “Toop toop” dei Cassius ancora riecheggia nelle orecchie: è un pastiche improbabile, che incapsula alla perfezione lo spirito del personaggio (la sua spietata sicurezza) e insieme decostruisce un classico motivo dei film sul potere (la ripresa dal basso dei passi concitati, stretti in scarpe eleganti, di un gruppo di uomini che si affretta nel corridoio di un edificio governativo). Effetto analogamente accattivante in una scena successiva, I migliori anni della nostra vita che rivela l’esperienza umana della solitudine, la mia uguale a quella di Andreotti, perché Renato Zero commuove entrambi.
Poi: la strana voglia di resuscitare i morti al cinema ha del tutto senso in Neruda, originale allucinazione di Pablo Larraìn, dove il poeta cileno è più un viveur sovrappeso che un lirista dalle parole leggerissime e finisce a seppellire il suo persecutore nel bianco oblio delle Ande, invece che a subire, malato e solo, l’esecuzione della dittatura.
E ancora: nel capolavoro di Miloš Forman, uno dei più capaci cine-biografi, la risatina di Wolfgang Amadeus Mozart è correlativo di una auto-consapevolezza che dev’essergli stata indispensabile per tollerare e canalizzare appropriatamente la portata del proprio genio, che infatti stemperava con eccellente umorismo scatologico.
Fantasie, distorsioni, camuffamenti, furti di identità, accostamenti impropri, sintesi idiosincratiche: sono i tratti distintivi dei biopic in cui la visione dellə cineasta anima una figura sullo schermo. È un fenomeno peraltro riscontrabile in grado massimo nelle biografie fasulle, su personaggi inventati ma presentati col rigore di un’esistenza realmente accaduta, come ad esempio il Martin Eden di Pietro Marcello, Tár, Forrest Gump, il film-nel-film di The Watermelon Woman. Lo fanno anche le “inversioni”, quegli ibridi meravigliosi che rivelano, nel loro ritratto di persone in carne ed ossa, la magia della loro esistenza, come Heaven Knows What, Boyhood, la Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel o An Episode in the Life of an Iron Picker di Danis Tanović.
“Com’è possibile che Willem Dafoe dica solo tre parole in italiano in ‘Pasolini’, e a chi è venuta l’idea che Riccardo Scamarcio potesse trasformarsi in un buon Ninetto Davoli? Sono quesiti che io stessa mi sono posta, ma non sono quelli giusti per valutare la riuscita di un biopic”.
Così, affianco alla visionarietà di unə regista, fa capolino l’altro motivo di attrazione dei biopic e cioè, il loro soggetto principale: banalmente, la vita. Se la narrazione di un’esistenza ci attrae in qualsiasi forma, col cinema – dato il rapporto speciale che intrattiene con la dimensione temporale – l’attrazione è più intensa, esplicita, incestuosa.
La percezione che abbiamo della nostra storia individuale nel tempo è la modalità di comprensione e conoscenza più comune e identificabile che ci sia. Ogni destino è unico; ma il modo di sentirlo è frutto di identici processi mentali ed emotivi.
Il nostro tracciato biografico, per come lo ricordiamo o lo raccontiamo a noi stessi e agli altri, è una linea solo apparentemente retta. In realtà è piena di increspature, nodi, ellissi: traumi, tempi morti, eventi memorabili. Se la scienza riuscisse a rappresentare visivamente la cognizione della propria esistenza, questa avrebbe probabilmente lo stesso volto, fosco in alcune parti e luminoso altrove, delle migliori opere del cinema biografico – o, per quanto valga, di qualsiasi forma espressiva a cui interessa raccontare una vita.
“Ora so”, scrive Catherine Lacey nel romanzo Biography of X, “che una persona supera e resiste sempre i limiti di una storia che la riguarda, e per quanto i confini stabiliti siano labili, la sua soggettività sgorga, fuoriesce dai bordi, e poi si disperde in fretta e furia. La gente è troppo complicata per starsene tranquilla all’interno di una narrazione sul proprio conto, eppure ciò non ha mai fermato nessuno dal tentativo, disperatissimo, di comprendere una vita dentro a delle pagine”. O a dei fotogrammi.
Questo contenuto è stato realizzato in collaborazione con BiM Distribuzione, che distribuisce in Italia Prima danza, poi pensa – Alla ricerca di Beckett, di James Marsh, al cinema da oggi, giovedì primo febbraio.