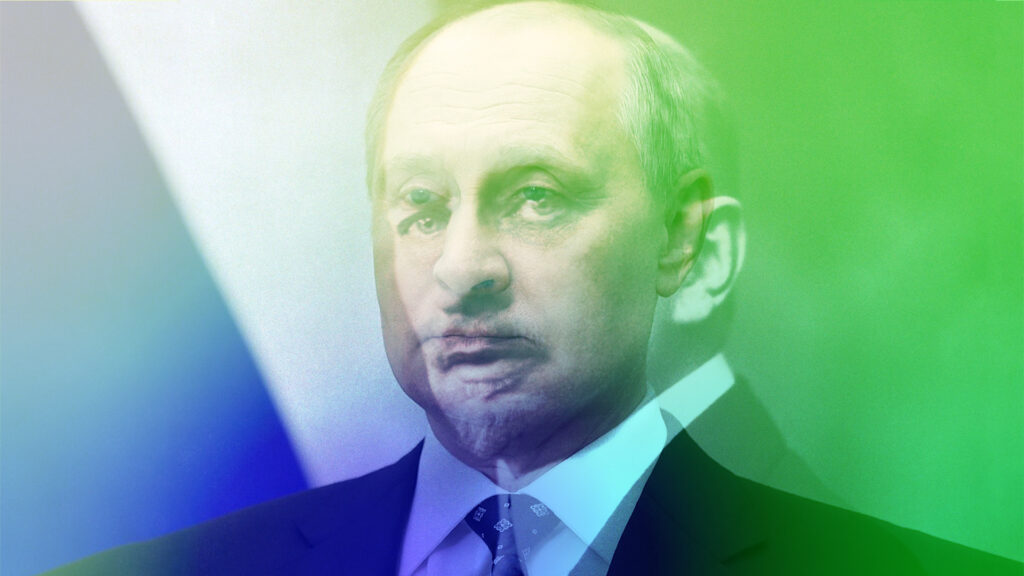Giulia Cavaliere
Ti riconosco dalla voce
17 Febbraio 2023
Diventare un altro per essere se stessi, camuffarsi per trovare una nuova identità artistica: spesso nella musica maschere e alter ego non servono solo a nascondere, ma a svelare.
Giulia Cavaliere
Giulia Cavaliere è giornalista, critica musicale e autrice. Collabora con «Domani» e altre testate. Il suo ultimo libro è Romantic Italia. Di cosa parliamo quando cantiamo d’amore (minimum fax, 2018).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati