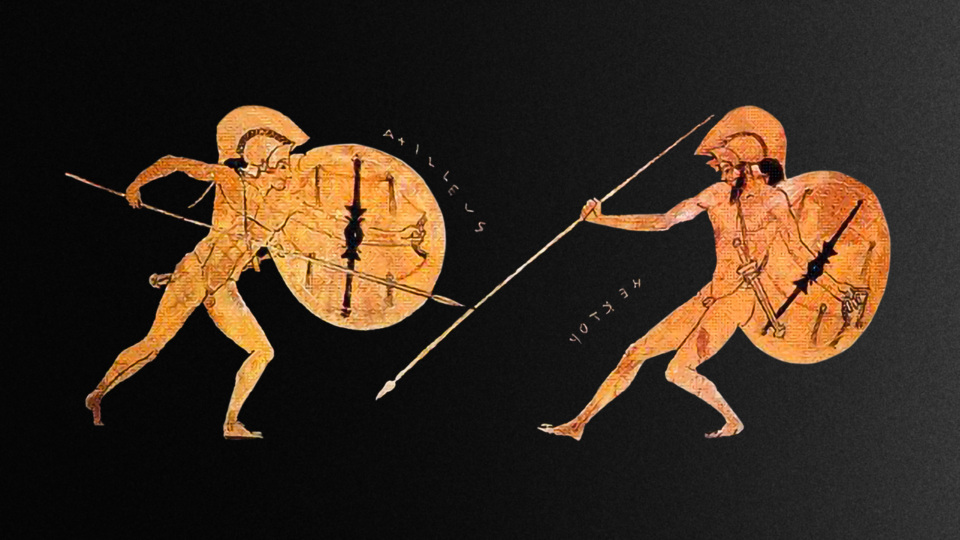Quando si diventa "grandi"? Forse quando si ha il coraggio di assumersi la responsabilità della propria ferocia.
Ogni sera, quell’inverno, il ragazzo ripeteva ad alta voce, con il capo affondato nel cuscino: “Alle quattro e mezzo! Alle quattro e mezzo!”, finché era sicuro che quelle tre parole fossero penetrate e gli si fossero impresse nel cervello. Poi si addormentava di colpo, come se avesse abbassato una saracinesca; e dormiva con il viso rivolto verso l’orologio per poterlo vedere per prima cosa al risveglio.
Ogni mattina si destava alle quattro e mezzo in punto e abbassava trionfante la levetta della suoneria della sveglia, felice d’essere ancora una volta riuscito a precederla: mentre lui dormiva tranquillo una zona remota della sua mente era rimasta desta e vigile tutta la notte, contando le ore. Poi si rannicchiava sotto le coperte, per goderne ancora per qualche istante il tepore, lasciandosi tentare dall’idea di rimanersene a letto, almeno per quella mattina. Ma lo faceva soltanto per il piacere di constatare che era una tentazione cui poteva resistere senza sforzo, così come la sera caricava la sveglia per il piacere che avrebbe provato il mattino dopo al risveglio, quando, stiracchiandosi e tendendo i muscoli, avrebbe pensato: Sono in grado di tenere sotto controllo ogni parte del mio corpo – anche il cervello!
Che voluttuoso piacere gli dava sentire il proprio corpo caldo e riposato, con le braccia, le gambe, le dita pronte a scattare a un suo comando come soldati! E che gioia sapere d’essere in grado di impedire al sonno di sottrargli senza il suo consenso delle ore preziose! – per esserne certo, una volta era rimasto sveglio per tre notti consecutive, e poi aveva studiato tutto il giorno, rifiutandosi persino di ammettere d’essere stanco; ed ora il sonno era divenuto per lui una specie di servitore ai suoi ordini.
Il ragazzo allungò più che poté le braccia e le gambe, fino a toccare con le mani la parete alle sue spalle e con la punta dei piedi il fondo del letto; poi uscì di scatto di sotto le coperte, come un pesce che guizzi fuori dall’acqua. Il freddo era orribile.
Si vestiva sempre in fretta, per cercare di conservare al suo corpo un po’ del tepore assorbito durante la notte almeno per altre due ore, fino al sorgere del sole; ma prima ancora di finire di vestirsi aveva le mani intirizzite e quasi non riusciva a reggere le scarpe. Le scarpe non se le metteva, per timore di svegliare i suoi genitori, che infatti non scoprirono mai che si alzava così presto.
Appena ebbe superato la soglia di casa sentì la pianta dei piedi contrarsi al contatto con il terreno gelato e le gambe irrigidirsi per il freddo. Era notte fonda: il cielo era coperto di stelle e gli alberi erano forme cupe e immobili. Si guardò attorno in cerca di qualche presagio del giorno: il grigio scintillio di una pietra o un fugace bagliore a oriente, ma era ancora troppo presto. Cauto e guardingo come un animale che abbia avvertito un pericolo scivolò senza far rumore sino alla finestra della camera dei suoi genitori e con un piacevole brivido di paura sostò un attimo, quasi per sfida, con la mano sul davanzale, cercando di forare con lo sguardo l’ovattata oscurità della stanza.
Poi, usando come guida il bordo erboso del vialetto che correva attorno alla casa, raggiunse un’altra finestra, che si apriva sul locale in cui la sera prima aveva nascosto il fucile. Le dita intirizzite non riuscivano a far presa sul gelido metallo e per sicurezza si strinse il fucile sotto il braccio. Poi in punta di piedi si recò nella stanza in cui dormivano i cani, timoroso che fossero stati tentati d’andarsene prima di lui; invece lo stavano aspettando, acquattati nelle loro cucce per difendersi dal freddo, e appena scorsero il fucile rizzarono le orecchie ed agitarono festosamente la coda. Le sue sommesse ammonizioni li convinsero a seguirlo zitti e quieti finché non furono a un centinaio di iarde dalla casa: allora si lanciarono a grandi balzi nel fitto del bush, uggiolando eccitati.
Il ragazzo immaginò i genitori agitarsi nel letto e borbottare: “Di nuovo quei maledetti cani!” prima di ripiombare nel sonno; e sorrise con sdegnoso compatimento. Prima di superare la fila di alberi che gli avrebbe nascosto alla vista la casa le gettò, come faceva sempre, un’ultima occhiata. Sembrava così piccola e fragile, quasi schiacciata sotto il peso dell’immenso cielo punteggiato di vivide stelle. Poi si voltò e si scordò immediatamente di lei e dei genitori addormentati nella camera calda di fiati.
Doveva affrettarsi. Doveva percorrere almeno otto miglia prima che facesse giorno; e già qualche foglia si stava tingendo di verde, e l’aria aveva un odore diverso, e le stelle erano impallidite.
Si gettò le scarpe sulla spalla: scarpe alte e robuste, screpolate e indurite dalla guazza di cento mattine. Gli sarebbero state necessarie quando il terreno sarebbe diventato troppo caldo per poter camminare scalzo. Ora invece sentiva la polvere umida infilarglisi fra le dita e si affrettò a rilassare i muscoli dei piedi in modo che le piante si adattassero più facilmente alla scabrosità del terreno. Con piedi come questi, si disse, potrei percorrere centinaia di miglia! Potrei camminare un giorno intero senza stancarmi!
Si avviò di buon passo lungo il buio tunnel di foglie che di giorno era un sentiero. I cani erano spariti, ma li sentiva ansimare: stavano evidentemente esplorando i segreti meandri del bush. Ogni tanto sentiva un muso umido sfiorargli le gambe, poi i cani si allontanavano di nuovo, alla ricerca di qualche pista da seguire. Non erano cani addestrati, ma liberi compagni di caccia, che spesso si stancavano dei lunghi appostamenti e se ne andavano per i fatti loro senza attendere lo sparo. Poco dopo riuscì a vederli, piccoli e indomiti, nella tremula incerta luce che stava lentamente avvolgendo il bush, in attesa che il sole restituisse alla terra e alla vegetazione i loro colori.
L’erba gli arrivava alle spalle e gli alberi stillavano grosse gocce argentee. Era ormai fradicio e tutto il suo corpo era contratto e percorso da un costante brivido. A un certo punto si chinò a osservare delle impronte ancora fresche sparse sul sentiero, ma si raddrizzò subito, ricordando con rammarico che quel giorno non poteva concedersi il piacere di seguire una traccia.
Mentre avanzava lungo il margine di un campo arato notò di sfuggita che era ricoperto di fitte, recenti ragnatele, così che pareva che sulle grandi zolle brune fosse stato disteso un velo grigio e scintillante. Camminava a lunghi passi regolari, come aveva visto fare agli indigeni, spostando ritmicamente il peso del corpo da un piede all’altro, poiché quella era un’andatura che non stancava e non accorciava il respiro; sentiva il sangue scorrere pulsando nelle gambe e nelle braccia e a poco a poco fu invaso da una sorta di ebbrezza e strinse forte i denti per vincere l’impulso di manifestare ad alta voce la propria esultanza.
Si era ormai lasciato alle spalle la zona coltivata della tenuta e la macchia bassa e oscura ed ora davanti a lui si apriva un grande vlei, acri ed acri di erba pallida che rimandava verso il cielo di raso un ingannevole bagliore. I grandi ciuffi d’erba s’erano appiattiti sotto la rugiada, condensatasi in grosse gocce che scintillavano come diamanti.
Il primo uccello si risvegliò proprio ai suoi piedi e subito un intero stormo si levò nell’aria ed annunciò con acuti strilli che il nuovo giorno era nato; e all’improvviso anche il bush alle sue spalle si risvegliò e si riempì di voci e da lontano giunse il richiamo di una faraona. Questo significava che le faraone avevano già abbandonato i loro nidi sugli alberi per scendere fra l’erba fitta. Era venuto fin là proprio per loro, ma era arrivato troppo tardi. Tuttavia non se ne rammaricò. Si era quasi scordato d’essere venuto fin lì per cacciare. Allargò le gambe, bilanciò il peso del corpo su entrambi i piedi e tenendo il fucile orizzontale lo sollevò e abbassò più volte, in una sorta di improvvisato esercizio ginnico, e gettò il capo all’indietro finché sentì dolergli i muscoli del collo – e fu così che scorse delle piccole nubi rosee galleggiare in un mare d’oro.
All’improvviso qualcosa scattò dentro di lui e non riuscì più a controllarsi. Lanciò un urlo e spiccò un balzo, poi prese a correre, ma non più compostamente, come poco prima, bensì come un forsennato, o un animale impazzito, lanciando grida incoerenti e selvagge, inebriato e travolto da una incontenibile gioia di vivere, dall’esplosione della sua esuberante giovinezza.
Scese veloce verso il vlei, mentre sopra il suo capo il cielo si tingeva di porpora e d’oro e attorno a lui cantavano tutti gli uccelli del creato. Correva a grandi balzi e mentre correva gridava la sua gioia di sentire il proprio corpo sollevarsi nell’aria gelida e trasparente e i piedi ricadere sicuri sul terreno; e per un attimo pensò, ma come ad un evento inverosimile, che in mezzo a quell’erba alta e fitta avrebbe potuto slogarsi una caviglia. Si aprì la strada fra i cespugli con la destrezza d’un’antilope, scavalcò a balzi le rocce, e alla fine s’arrestò di colpo, là dove il terreno scendeva a precipizio verso il fiume.
Aveva percorso senza arrestarsi almeno due miglia, fra arbusti e cespugli alti fino al petto, e ora respirava con affanno e non aveva più voce. Si sedette su un masso e contemplò l’acqua scintillante del fiume che intravedeva fra gli alberi contorti e piegati dal vento, e all’improvviso si disse: “Ho quindici anni! Quindici anni!”
Quelle parole avevano un suono nuovo per lui; e perciò le ripetè più volte, sorpreso e sempre più emozionato; a un tratto gli parve di tenerli in mano, quei suoi quindici anni, e di contarli come se fossero altrettante biglie dure, levigate, lucenti, ciascuna a suo modo inimitabilmente stupenda. Ecco cos’era lui: quindici anni di questa terra ferace, e quest’acqua dal lento fluire, e quest’aria dal profumo eccitante, sia nell’afa pomeridiana sia nelle albe fresche e ventose.
Non c’era nulla che non potesse fare, nulla! E a un tratto ebbe una specie di visione, come quando un bimbo ode pronunciare la parola “eternità” e tenta di afferrarne il significato, e la sua mente cerca di concepire un tempo senza confini. Vide la propria vita futura come uno spazio luminoso e indeterminato, di cui era l’unico e assoluto proprietario; sentì il sangue pulsargli nelle tempie e disse ad alta voce: “Tutti i grandi uomini sono stati ragazzi come me, e io posso diventare come loro, non c’è nulla che possa impedirmelo; e non c’è Paese al mondo che io non possa considerare mio, se lo desidero. Il mondo è dentro di me. Posso farne ciò che voglio. Se voglio, posso mutare il futuro; dipende solo da me, da ciò che decido in questo momento”.
La fermezza e la convinzione con cui aveva pronunciato quelle parole, dettategli da un incontenibile impulso, lo resero a tal punto esultante che cominciò a cantare a voce spiegata, e la sua voce scese via via smorzandosi verso l’alveo del fiume. Tacque e attese l’eco, poi riprese a cantare: tacque di nuovo e cantò di nuovo. Ecco cos’era lui! – se voleva, cantava, e il mondo era costretto a rispondergli.
Per qualche minuto rimase fermo dov’era, gridando e cantando e ascoltando la propria voce che dopo essersi spenta nella valle gli veniva rimandata limpida e forte dall’eco; come se qualcuno, udite le sue parole, gli stesse rispondendo e lo stesse incoraggiando: finché la valle fu invasa da grida attutite che rimbalzavano da una roccia all’altra fino al fiume. Ma ad un tratto gli parve di udire una voce diversa dalla sua. Rimase in ascolto, immobile, con i muscoli tesi, pronto a scattare: non era il canto gioioso d’un uccello, né il gorgoglio argentino d’una piccola cascata, né il sordo scalpiccìo d’una mandria; ed era molto vicino.
Il suono si ripeté. Nella quiete profonda di quel mattino in cui erano racchiusi il suo passato e il suo futuro, echeggiò come una disperata implorazione, una specie di appello inarticolato, come se qualcuno, o qualcosa, cercasse di invocare aiuto ma non ne avesse la forza. Il ragazzo rientrò in sé, si guardò attorno e richiamò i cani. Ma i cani si erano allontanati troppo e non risposero al richiamo. Era solo.
Ormai si era calmato, la folle ebbrezza di poco prima era svanita. Con quelle grida soffocate e piene di terrore nelle orecchie e il cuore che gli batteva forte scese con prudenza dal masso e si avviò verso una fila d’alberi, avanzando con cautela poiché non molto tempo prima proprio in quel punto aveva scorto un leopardo. Raggiunti gli alberi, si fermò e si guardò attorno, con il fucile spianato, poi riprese ad avanzare, lanciando a ogni passo occhiate attente e sospettose. Poi all’improvviso vacillò e si arrestò, stupefatto e incredulo. Scosse il capo, smarrito, come se dubitasse dei propri occhi.
Laggiù, fra due alberi, contro uno sfondo di scabre rocce brune, c’era un essere che pareva uscito da un sogno, uno strano animale che aveva bensì le corna e quattro zampe ma non somigliava a nessun animale o creatura ch’egli avesse mai visto o anche solo immaginato. Aveva l’aspetto d’una piccola antilope ridotta a brandelli. Il mantello lacero lasciava infatti qua e là intravedere, tra ciuffi arruffati di pelo, lembi di carne viva… ma quelle chiazze insanguinate venivano velocemente ricoperte da una sostanza nera e palpitante, mentre altre ne apparivano in altre parti del corpo: e intanto l’animale continuava a lamentarsi, con piccoli gemiti soffocati, e si dibatteva e saltellava, sbandando, come se fosse cieco.
Finalmente il ragazzo capì: era davvero un’antilope. Avanzò di qualche passo, ma ancora una volta si fermò di colpo, trattenuto da una nuova paura. Aveva avuto la sensazione che tutt’a un tratto l’erba si muovesse e frusciasse, come se fosse viva. Si guardò attorno, atterrito, poi abbassò gli occhi al suolo. Il terreno era coperto di formiche, grosse formiche nere che non si curavano affatto di lui ma si dirigevano risolute verso l’animale in agonia, così che l’erba sembrava percorsa da lunghi rivoli neri e scintillanti.
E mentre il ragazzo tratteneva il respiro, sopraffatto dall’orrore e dalla pietà, l’animale si abbatté al suolo e i lamenti cessarono. Ora non udiva altro che il canto d’un uccello e il sommesso, incessante fruscio delle formiche.
La loro vittima era frattanto diventata una nera massa informe che conservava solo vagamente l’aspetto di un giovane animale e sussultava convulsamente. A poco a poco tuttavia s’acquietò e giacque inerte, scossa soltanto da qualche lieve contrazione.
Il ragazzo si disse che avrebbe dovuto spararle e mettere così fine alle sue sofferenze e alzò il fucile. Ma lo riabbassò subito. La piccola antilope ormai non sentiva più alcun dolore; i suoi sussulti non erano che una meccanica reazione dei muscoli. Tuttavia non fu questa considerazione che lo indusse ad abbassare il fucile.
Fu una incontenibile ondata di furore, di angoscia e di rabbia impotente che lo travolse e gli suggerì questa riflessione: se io non fossi venuto fin qui, sarebbe stata questa la sua fine: perché dunque dovrei intervenire? Nel bush queste cose accadono di continuo; ogni giorno, forse ogni ora, innumerevoli esseri viventi muoiono straziati; così è fatta la vita. Serrò il fucile fra le ginocchia e gli parve di percepire sul proprio corpo le innumerevoli trafitture che l’animale agonizzante ormai non avvertiva più, e strinse i denti, e ripeté più e più volte sottovoce: “Non posso impedirlo. Non posso impedirlo. Non c’è nulla ch’io possa fare”.
Senza dubbio la piccola antilope era ormai incosciente e non soffriva più, si disse, e se ne rallegrò, poiché questo lo dispensava dal prendere la decisione di ucciderla, anche se il suo cervello e tutte le sue fibre gli ripetevano: Sono cose che accadono, fanno parte della vita. È giusto – gli dicevano in realtà il suo cervello e il suo corpo – è giusto che sia così e nulla può impedirlo.
Per la prima volta in vita sua si rendeva conto che esisteva per tutti un destino, al quale nessuno poteva sottrarsi, e questa nuova consapevolezza lo turbò e gli paralizzò la mente e le membra, e potè solo ripetere come un automa: “Così è la vita. Sì, così è la vita”.
L’inaudito concetto di inevitabilità gli era penetrato nella carne, nelle ossa, nei più remoti meandri della mente, e glieli rodeva come un tarlo. In quel momento non avrebbe potuto compiere il minimo gesto di pietà: sapeva ormai che nel veld, immenso, immutabile, crudele, dove a ogni passo poteva capitare d’inciampare in un cranio putrefatto o di calpestare la carcassa di qualche piccolo animale, la pietà era inutile.
Sconvolto, disgustato e furente, ma al tempo stesso compiaciuto del proprio nuovo sinistro cinismo, si appoggiò al fucile e osservò la nera massa informe e palpitante diventare sempre più piccola. Ora ai suoi piedi passavano senza fretta cortei di formiche che trascinavano rosei brandelli di carne e nell’aria s’era diffuso un odore acre e pungente. Impose con fermezza al proprio stomaco vuoto di resistere al disgusto e ricordò a se stesso: anche le formiche devono mangiare! E nel medesimo istante si accorse di avere il volto rigato di lacrime, che insieme al sudore che gli inzuppava gli abiti testimoniavano la sua partecipazione alle sofferenze della piccola antilope.
Nessuno ormai avrebbe riconosciuto nella massa informe che andava via via rimpicciolendo il giovane animale. Dopo un po’, ma non avrebbe saputo dire quanto tempo fosse passato, il ragazzo vide spuntare di sotto lo strato nero che la rivestiva, e che frattanto era diventato meno fitto, delle chiazze bianche che il sole faceva scintillare – sì, c’era il sole, s’era appena levato, e ora i suoi raggi incendiavano le rocce. Evidentemente la drammatica scena cui aveva assistito non era durata più di qualche minuto.
Cominciò a imprecare, usando parole che aveva udito pronunciare a suo padre, contro l’intollerabile fugacità del tempo, e imprecando avanzò, stritolando formiche a ogni passo e liberandosi con la mano da quelle che gli erano salite sulle gambe, finché raggiunse la carcassa dell’antilope, che giaceva scomposta sotto un cespuglio. Se non fosse stato per qualche roseo frammento di cartilagine che ancora aderiva alle ossa candide si sarebbe potuto pensare che fosse là da anni. Tutt’attorno le formiche si stavano ritraendo a sciami, stringendo fra le mandibole minuscoli lembi di carne.
Il ragazzo le osservò. Erano grosse, nere, disgustose; alcune si erano rizzate sulle zampe e lo fissavano con i piccoli occhi lucenti.
“Andatevene!”, gridò irato alle formiche. “Non sono per voi – non ancora, per lo meno. Andate via!” E gli parve che le formiche gli obbedissero e mutassero direzione.
Si chinò sulla carcassa dell’antilope e osservò le due vuote cavità nel cranio. Qui c’erano gli occhi, si disse, incredulo, ricordando lo sguardo umido e mansueto delle antilopi. Poi attirò verso di sé il lungo ed esile stinco d’una delle zampe anteriori e se lo appoggiò sulle palme.
Quel mattino, forse soltanto un’ora prima, quella giovane antilope aveva vagato libera e fiera nel bush, aveva sentito l’aria gelida pungerle la pelle, proprio come lui, e forse come lui ne era stata esilarata. Scalpitando, e scuotendo le corna, e agitando la graziosa coda bianca, aveva inalato la fresca aria del mattino. Con l’incedere d’un re o d’un conquistatore aveva esplorato il suo regno, il bush, dove ogni filo d’erba cresceva per lei sola, dove l’acqua limpida e scintillante del fiume scorreva solo per placare la sua sete.
E poi – cos’era accaduto? Quell’animale dal passo così rapido e sicuro non si era certo lasciato intrappolare da uno sciame di formiche!
Il ragazzo si chinò ad esaminarne con attenzione lo scheletro. E allora si avvide che una delle zampe posteriori, che negli spasimi della morte l’animale aveva sollevato e proteso nell’aria, era spezzata all’altezza della coscia, e i due segmenti dell’osso infranto sporgevano sovrapposti. Ecco dunque com’era andata! L’antilope zoppicava e quando aveva calpestato il formicaio, pur rendendosi conto del pericolo non era stata in grado di fuggire. Già, ma come mai aveva una zampa rotta? Era forse caduta? Impossibile, l’antilope è troppo agile e leggera. Era stata forse incornata da qualche rivale geloso?
Cosa poteva essere successo? Forse degli indigeni le avevano lanciato contro delle pietre, com’è loro costume, tentando di ucciderla per mangiarsela, e le avevano spezzato la zampa. Sì, doveva essere andata così.
E mentre cercava di raffigurarsi la scena, con gli indigeni che urlando rincorrevano e lapidavano l’antilope, e l’animale azzoppato che cercava di fuggire, un’altra immagine gli attraversò la mente. Rivide se stesso, in una di quelle luminose, inebrianti mattine, puntare eccitato il fucile contro un’antilope appena intravista, e dopo lo sparo, abbassato il fucile, chiedersi se fosse riuscito a colpirla; e dirsi alla fine che s’era fatto tardi, e aveva voglia di far colazione, e non valeva la pena di inseguire per miglia e miglia un animale che con ogni probabilità sarebbe comunque riuscito a sfuggirgli.
Per qualche istante tentò di sottrarsi a quel confronto con se stesso. Chinò il capo e sferrò dei calci dispettosi alla carcassa dell’animale: era di nuovo un ragazzino che si rifiutava di accettare le proprie responsabilità.
Poi si raddrizzò e contemplò le povere ossa con pietoso sgomento; non provava più alcuna ira, né rabbia. Si sentiva la testa vuota: tutt’attorno a sé vedeva lunghe fila di formiche scorrere e scomparire fra l’erba con un secco, sommesso fruscio, simile a quello d’una pelle di serpente abbandonata dopo la muta.
Alla fine raccolse il fucile e si avviò verso casa, dicendosi che del resto ormai faceva caldo, troppo caldo per continuare a vagabondare nel bush, e che aveva fame.
Ma era soprattutto stanco. Camminava lentamente, a passi pesanti, senza controllare dove metteva i piedi. Quando giunse in vista della casa si fermò ed aggrottò la fronte. C’era qualcosa su cui doveva riflettere. La morte di quella piccola antilope lo aveva turbato, era un pensiero che non riusciva a scacciare dalla mente, un episodio non ancora chiuso.
Presto, anzi l’indomani stesso, si sarebbe liberato di tutti e sarebbe ritornato di soppiatto nel bush, dove avrebbe potuto meditare in pace.
Alba sul veld è contenuto nella raccolta Racconti africani di Doris Lessing, edita da Feltrinelli e acquistabile a questo link. La traduzione è di Franca Castellenghi Piazza. Lucy ringrazia l’editore per il bel regalo.