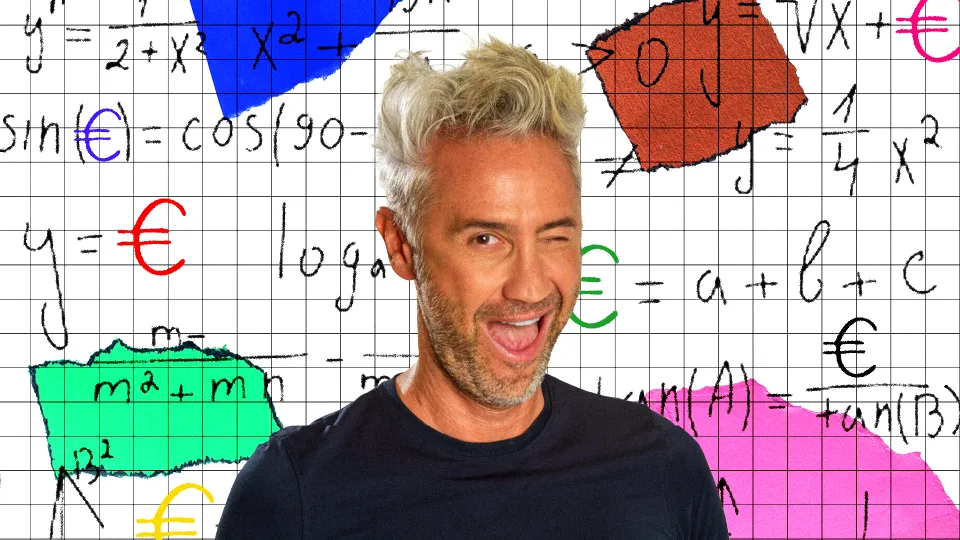Dietro uno dei maggiori successi popolari degli ultimi anni, sta uno scrittore sorvegliato e appassionato studioso dei meccanismi dei classici. Se fatichiamo così tanto a staccarci dalle vicende di Montalbano è forse per via dell’”Orlando Furioso”?
“Gentile Signor Camilleri, Ha fatto molto bene ad eludere, come Lei dice, la severità della nostra formula ‘si collabora per invito'”, gli scriveva su carta intestata della rivista «Mercurio» il direttore, Alba De Cespedes, da Roma l’11 maggio 1945. “Come sta? Mi dia sue notizie”, gli chiedeva Vitaliano Brancati da Catania nel giugno del 1945. “Caro amico”, gli scriveva Elio Vittorini nel 1945, considerandolo troppo montaliano. “Caro Camilleri», è invece la formula con cui gli si rivolgevano tanto Eduardo De Filippo nel 1962 quanto Primo Levi nel 1967: quest’ultimo dopo un incontro in vista della trasmissione radio del suo racconto Il versificatore, su una fantascientifica macchina in grado di produrre poesie, premonizione visionaria dell’intelligenza artificiale (in sorprendente sintonia, fra l’altro, con gli esperimenti di Nanni Balestrini col calcolatore e col registratore in quegli anni).
Tutt’altro che isolato, marginale o laterale rispetto alla società letteraria del suo tempo, come ha appena dimostrato una piccola ma utilissima mostra presso la Società Dante Alighieri, a cura di Giulio Ferroni, Camilleri è stato un protagonista del Novecento italiano, capace di far convergere intorno a sé e alla sua esperienza un mondo intero di transiti e conversazioni. Dello scrittore siciliano si celebra quest’anno il 100° compleanno (che sarebbe stato il 6 settembre); ma non è certo la circostanza esteriore della ricorrenza a renderne significativo il ripensamento. Si tratta piuttosto di prendere atto dell’interazione tra il contemporaneo e il canone, perché contemporaneo non è chi ha successo nell’immediato, ma chi, come diceva Agamben ispirandosi a Nietzsche e Mandelstam, «è in grado di scrivere intingendo la penna nella tenebra del presente». Presente, allora, visto anacronisticamente: dall’oggi, stridendo, e dal domani, ironizzando, che è effettivamente un metodo à la Camilleri – vedere come un orpello ciò di cui la propria epoca è orgogliosa. Facile e accomodante, uomo medio ai confini della mediocrità, italiano standardizzato e compiaciuto, sarebbe, secondo alcuni, il suo Montalbano; ma è anche un campione di quel distacco ironico che sa evitare di prendere la vita troppo sul serio e invitare a spostare sempre il punto di vista. Destinato a essere eroe, si descrive come un personaggio di Gianni e Pinotto, capace di vedersi da fuori e smontarsi dall’esterno.
Di un Camilleri meno intriso di Montalbano e restituito alla sua storia la mostra ha voluto rendere conto, nella convinzione che l’autore si capisca meglio attraverso non il biografismo, ma la rete di relazioni che ha mobilitato e in cui è invischiato. Autore di poesie già a quattordici anni, conservate in un quadernetto dattiloscritto di “prime poesie”, intitolate Stati d’animo, Camilleri fu prima di tutto regista teatrale, mettendo in scena Eliot, Beckett, Ionesco, Calderon de la Barca e Luigi Pirandello; ma fu il lavoro in televisione a dargli la possibilità di entrare in contatto con un materiale umano variegato che sarebbe diventato in seguito esplosivo materiale narrativo. Camilleri ha trascorso in Rai oltre trent’anni, dall’assunzione nel 1957 fino alla pensione nel 1990. Lì ha prodotto e diretto sceneggiati di maggiore e minore successo e ha partecipato alle “Interviste impossibili“, incontrando Stesicoro nel 1975 e Federico II nel 1976, fino a rilanciare, in una riedizione del format, con un’”intervista sulle interviste” nel 2006 e un’intervista a Galileo Galilei nel 2009.
Da questo materiale ricchissimo lo scrittore avrebbe in seguito selezionato un riferimento principale, che sorprendentemente non è Verga, Pirandello o Sciascia, ma Ludovico Ariosto, l’autore dell’Orlando furioso, cui è dedicato l’unico omaggio esplicito in un titolo della saga di Montalbano, Il sorriso di Angelica, uscito nel 2010 (da Sellerio, come quasi tutto Camilleri): dedicato alla protagonista fuggitiva del poema ariostesco, il romanzo s’ispirava alle classiche illustrazioni di Doré, che avrebbero turbato da ragazzo il commissario proprio come avevano turbato il suo autore. A partire da qui, infatti, Camilleri ricostruiva una passione ariostesca che fino ad allora era rimasta in sordina, se non addirittura nascosta. Lo dichiarava in Donne del 2014, ma i lettori più attenti e appassionati avevano senz’altro notato che già nel 2006 il romanzo semiautobiografico La pensione Eva proponeva un alter ego, Nené, che a sua volta si era innamorato dell’Angelica di Doré: “una fìmmina nuda, ’ncatinata a una specie di scoglio, che chiangiva alla dispirata. Matre santa, quant’era beddra quella fìmmina! i capelli longhi longhi non riuscivano ad ammucciare le gran cosce che aveva! e che minne tunne tunne le sporgevano dal petto!”.
Nella pensione Eva, il bordello del paese, la solita Vigata, Nené arriverà a sfidare a duello un avventore rivale: a cavalcioni di due prostitute, Nené e Ciccio si sentivano come Rinaldo su Baiardo e Astolfo sull’ippogrifo, insultandosi al suono di versi come “corri veloce, mio bravo Baiardo, così d’Astolfo ne facciamo lardo!” e “corri veloce, mio bravo ippogrifo, Rinaldo e il suo Baiardo fanno schifo!”. Se Ariosto serve a leggere, in controluce, l’immaginario di formazione del giovane Nené, come poteva mancare a colui che di Nené era indirettamente figlio, il commissario Montalbano, in quanto creatura di colui di cui Nené era controfigura, Camilleri in persona? Nessuna meraviglia, insomma, che nell’Angelica Cosulich del romanzo Il sorriso di Angelica egli riconosca, “pricisa ’ntifica, ’na stampa e ’na figura”, l’Angelica ariostesca nella versione di Doré (sicilianizzata, per di più, attraverso un’altra Angelica, suo inevitabile precedente nella serie letteraria delle riprese e dei rifacimenti, quella del Gattopardo, sublimemente esaltata dall’interpretazione di Claudia Cardinale).
Il sorriso di Angelica a prima vista è un’antologia di citazioni ariostesche prêt-à-porter sull’amore e sulla gelosia, tratte quasi soltanto dai canti 19 e 23 dell’Orlando furioso (che raccontano rispettivamente l’innamoramento di Angelica e Medoro e la pazzia di Orlando); ma, specchiando il poema cavalleresco nel videogame di Catarella, dove il giocatore interpreta se stesso e il suo aiutante, Montalbano realizza che il gioco ariostesco col personaggio è la chiave per risolvere il giallo. Si tratta, in altri termini, di applicare l’ironia ariostesca al mondo di Montalbano, che nel momento in cui più esibisce la propria coscienza di finzione letteraria è tanto più realistico in quanto capace di penetrare i meccanismi fondanti della realtà, al di là della verifica fattuale. Ariosto, allora, per Camilleri è un maestro d’ironia, che svela le modalità con cui la finzione introduce alla realtà più di qualsiasi storia vera o verisimile per il semplice fatto che la sua è una verità del possibile anziché del già accaduto.
Alla fine del romanzo, nella solita avvertenza al lettore che fatti e personaggi sono frutto d’immaginazione, Camilleri aggiunge, pirandellianamente, che in tutto ciò c’è però un gradiente di realismo, perché il romanzo, come lui lo concepisce, è un’introduzione alla conoscenza anziché puro intrattenimento.
Perché la nota di poetica che smaschera l’ideologia sottostante a tutta la produzione letteraria dello scrittore si trova proprio nel romanzo più pieno di memoria e citazioni, il suo romanzo ariostesco? L’ipotesi è che Ariosto sia l’interlocutore sottile con cui Camilleri ha sempre dialogato. Se si vanno a vedere, in effetti, i suoi primi due romanzi, Il corso delle cose, scritto tra il 1967 e il 1968, ma pubblicato solo nel 1978, e Un filo di fumo, del 1980, entrambi di gran lunga precedenti al successo di Montalbano, Ariosto compariva già, utile a indicare la memoria colta dei personaggi, ma anche a smascherare quei fili dell’intreccio che lo rendono complice, da un lato, dell’opera dei pupi, e dall’altro, della stessa narrativa camilleriana: proprio in questa sinergia, il grande Ruggero Jacobbi, geniale prefatore del secondo romanzo, vedeva una sicilianità che “sembra sfuggire tra le mani dell’osservatore, tutta intessuta com’è di moventi umani elementari ma oscuri, di gesti cerimoniali che alludono a una seconda natura, a un’ipotesi dell’uomo non misurabile secondo i parametri della logica”. Che sia questa la natura più vera e più profonda della scrittura di Camilleri, fino a Montalbano incluso, che solo la cartina di tornasole ariostesca riesce a rivelare?
Se è l’intreccio, del resto, la forza della narrativa di Camilleri, com’è stato autorevolmente suggerito, non c’è Ariosto anche qui, con la sua arte dell’interrompere e differire, slacciare e riannodare, sospendere e riprendere i fili della storia? Un Camilleri più ironico e contraddittorio, più ambiguamente intriso di mistero, più sfuggente e meno rassicurante sarebbe quello che una lettura di questo tipo ci restituisce. L’ironia ariostesca, a sua volta, non è forse, come ha scritto uno dei suoi interpreti più acuti, il critico britannico naturalizzato americano Donald Carne-Ross, un invito alla “comprensione multipla delle cose”? Forse di Ariosto Camilleri aveva bisogno per scoprire la sua dimensione narrativa più autentica, superando quel lirismo post-rondista e montaliano che Vittorini gli rimproverava e che non gli diede il successo: sono gli incontri, più spesso casuali che cercati, a determinare i destini.
Non si tratta, in conclusione, di accorpare Camilleri al canone dei classici, con operazione di allargamento che serve solo a confermare anziché spostare: si tratta, piuttosto, di verificare quella mobilità dei testi nella storia che è l’unica modalità di circolazione della letteratura, indipendentemente dalla restituzione di presunte ultime volontà o sigilli autoriali. La piccola mostra da cui siamo partiti ha offerto allora un’occasione di riflessione sul rapporto tra classico e contemporaneo.
Letta nella dinamica delle relazioni, la letteratura ha più da guadagnare che da perdere: quando si sposta nella sfera della contemporaneità, lungi dall’inevitabile perdita di autenticità o essenza, un classico può trarne vantaggio in molti modi. Dialogando coi classici, viceversa, piuttosto che nobilitarsi meccanicamente, il contemporaneo si mette in crisi, apre a ipotesi alternative, genera domande su domande, si fa percorso mentale e inchiesta paradossale. “Noi viviamo immersi nelle narrazioni, ripensando e soppesando il senso delle nostre azioni passate, anticipando i risultati di quelle progettate per il futuro, e collocandoci nel punto d’intersezione di varie vicende non ancora completate”, scriveva Peter Brook, l’autore di Trame (Reading for the Plot). Per comprendere il funzionamento della letteratura, abbiamo bisogno più di una fenomenologia che di un’ontologia dell’opera letteraria: non c’interessa se sia canonica o contemporanea, classica o pop, ma come s’iscriva, per via di riprese e rimandi, citazioni e circolazioni, traduzioni e appropriazioni, all’universo della letteratura.