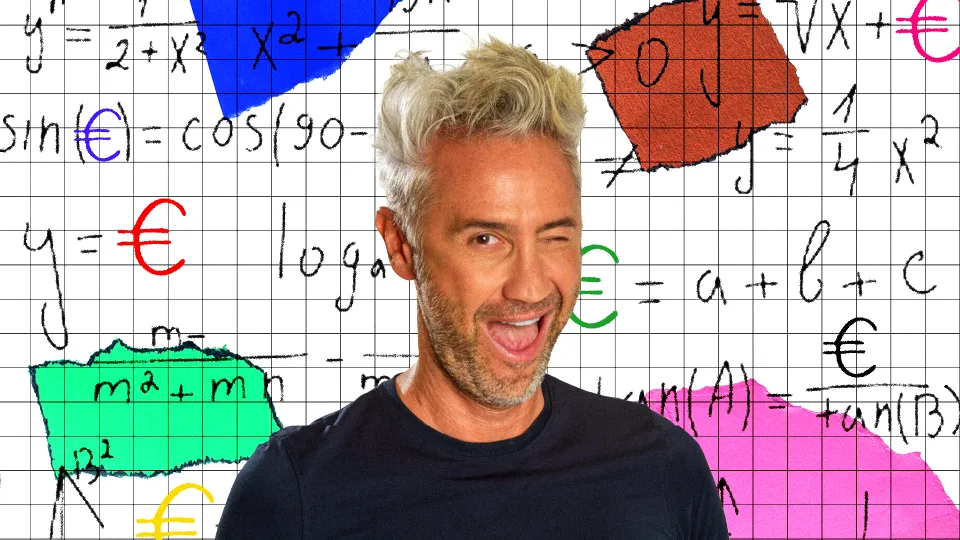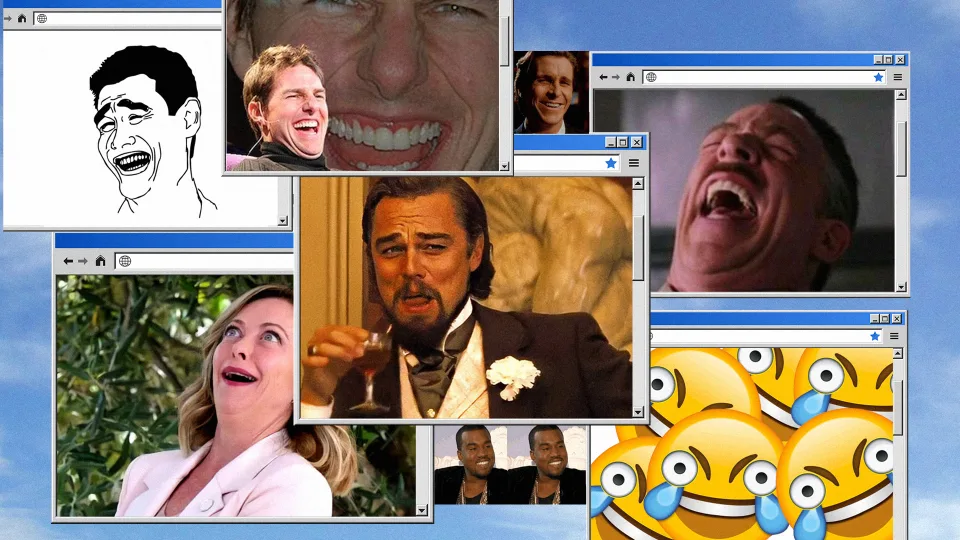Retaggio del regime fascista, le case lavoro sono numerate strutture del nostro Paese in teoria dedicate a chi ha commesso particolari reati. Nella realtà dei fatti, chi entra in questi luoghi, spesso per ragioni di condotta, non sa quando ne esce e le condizioni in cui versano i detenuti sono durissime e inumane.
Per qualche giorno, lo scorso novembre, in Italia si è parlato di case lavoro. È successo dopo che Elia Del Grande, 50 anni, è scappato dalla struttura di Castelfranco Emilia in cui si trovava internato. Del Grande nel 1998 aveva ucciso a colpi di pistola i genitori e il fratello a Cadrezzate, in provincia di Varese. Fu condannato a 30 anni di carcere e nel 2023, dopo averne scontati oltre ventisei, è tornato in libertà vigilata. Si è trasferito in Sardegna, ha trovato una compagna, ha ottenuto un lavoro. Ha iniziato quel faticoso percorso di reinserimento sociale dopo avere espiato la sua lunga pena, proprio come vorrebbe la Costituzione. Fino a settembre 2025, quando un magistrato di sorveglianza ha ordinato il suo internamento in una casa lavoro.
Del Grande è tornato a vivere la reclusione non perché abbia commesso un nuovo reato, ma perché è stato considerato “socialmente pericoloso”. Durante la sua fuga dalla struttura ha inviato una lettera al giornale locale Varesenews, poi ripresa dai media nazionali, dove ha raccontato la sua terribile esperienza nella casa lavoro. Il suo allontanamento è stato insomma un tentativo disperato di accendere i riflettori su quella che è probabilmente la forma più cruda e subdola di detenzione in Italia. “Una provincia dimenticata del nostro diritto penale”, come ha denunciato l’ex Giudice della Corte Costituzionale, Valerio Onida. Un’eredità del regime fascista che oggi continua a essere usata in funzione di difesa sociale contro soggetti considerati devianti. Non per le loro azioni, ma, quasi in chiave lombrosiana, per il loro profilo psicologico e sociale.
Dal regime fascista a oggi
“Il disagio che ho visto lì dentro credo di non averlo mai conosciuto”. Nella lettera diffusa durante la sua fuga, Elia Del Grande ha reso bene l’idea di cosa significhi stare in una casa lavoro. Dopo oltre ventisei anni di carcere gli sono bastati due mesi in quel tipo di istituto per rendersi conto che non c’è fine al peggio. E per decidere di evadere, anzi di allontanarsi. Nella piena consapevolezza che sarebbe stato rintracciato, ma con l’urgenza di fare un gesto forte per indurre l’Italia a parlare, anche solo per qualche giorno, dell’inferno delle case lavoro.
La reclusione in una casa lavoro è una misura di sicurezza applicata a persone ritenute “socialmente pericolose” con il fine di rieducarle attraverso, appunto, il lavoro. La sua invenzione risale al regime fascista, quando il ministro della Giustizia, Alfredo Rocco, istituì un sistema penale a doppio binario che da una parte mirava a comminare pene nei confronti degli autori di reati, dall’altra predisponeva misure di sicurezza in funzione di difesa sociale contro persone ritenute devianti, in modo del tutto arbitrario. Venne così introdotta la possibilità di limitare la libertà per le figure di “delinquente abituale, delinquente professionale e delinquente per tendenza”, profili difficilmente definibili in maniera oggettiva. Una classificazione che non ha mai cessato di esistere da allora nel nostro sistema legislativo e che costituisce il pilastro su cui continuano a sopravvivere le case lavoro.
Oggi in Italia ce ne sono nove, a cui si sommano tre colonie agricole in Sardegna, che ospitano circa 300 persone. Se il primo tipo di struttura, almeno a livello teorico, è incentrato sul lavoro di tipo domestico e artigianale, nel secondo la rieducazione avviene lavorando la terra. Sono tre i paradossi principali che caratterizzano questi istituti. Il primo è che non si può fare niente per evitare di finirci dentro perché non esistono ragioni oggettive all’origine di questa forma di reclusione. È sufficiente il criterio soggettivo della “pericolosità sociale”.
Il secondo è che si sa quando si entra, ma non si può sapere quando si esce. A differenza della pena, la cui durata è fissata in maniera definitiva da una sentenza, la detenzione in casa lavoro viene rinnovata di sei mesi in sei mesi in base a come ritiene il magistrato di sorveglianza.
Il terzo paradosso è che per quanto la casa lavoro non sia, ufficialmente, un carcere, nel concreto presenta le sue medesime caratteristiche e problematiche, moltiplicate in maniera esponenziale. Non è un caso che tutte le nove case lavoro italiane non siano altro che sezioni all’interno degli istituti penitenziari.
Una discarica sociale
“Mi sono trovato ad avere a che fare ogni giorno con gente con serie patologie psichiatriche, la terapia psicofarmaco viene data in dosi massicce a chiunque senza problemi. L’attività lavorativa esistente è identica a quella dei regimi carcerari. Le case di lavoro oggi sono delle carceri effettive in piena regola con sbarre, cancelli e polizia penitenziaria, orari cadenzati, regole e doveri”. Questo estratto della lettera di Elia Del Grande è una perfetta fotografia dell’aria che si respira in quegli istituti. Ed è una testimonianza preziosa. Sapere cosa succede al loro interno, infatti, è sempre difficile. Le case lavoro sono come isole dimenticate sul territorio nazionale, luoghi nascosti dietro barriere insormontabili che impediscono quasi del tutto la fuoriuscita di informazioni. Per rendersi conto della situazione, basta considerare che i dati del Ministero della Giustizia rilevano la presenza di persone internate in case lavoro anche in regioni dove non esistono questo tipo di istituti. Segno della confusione che domina al riguardo. E del disinteresse delle istituzioni.
Giulia Melani in Un ossimoro da cancellare, misure di sicurezza e case lavoro ha raccolto le poche statistiche esistenti sul tema, incrociandole con una ricerca quantitativa e qualitativa effettuata tra il 2022 e il 2023 all’interno delle nove case lavoro italiane. SI tratta di una risorsa molto importante per fare un po’ di ordine su quel mondo oscuro. E per comprendere meglio l’urgenza di superarlo. Se il concetto di “persona socialmente pericolosa” può far presupporre che nelle case lavoro ci siano esclusivamente profili che in passato hanno commesso reati molto gravi, in realtà in quasi un caso su due si tratta di autori di reati contro il patrimonio. Questi istituti presentano poi un’incidenza di tossicodipendenti molto alta, con punte del 39 per cento che superano anche i dati del sistema penitenziario. Altro tema è quello dei disturbi mentali: la popolazione con diagnosi psichiatrica è del 29 per cento ma in alcuni istituti si supera abbondantemente il 50 per cento. Questo anche perché succede che nelle case lavoro finiscano persone uscite dalle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), strutture sanitarie adibite all’accoglienza di autori di reato ritenuti infermi o seminfermi di mente che hanno sostituito i vecchi ospedali psichiatrici Giudiziari (Opg). All’interno delle case lavoro c’è poi uno scarsissimo livello di istruzione, con tassi di analfabetismo che raggiungono il 9 per cento. Una persona su sette è inoltre senza fissa dimora. E il 42 per cento degli “internati”, il termine dall’amaro retrogusto storico con cui si definisce chi si trova in una casa lavoro, risulta privo di una rete familiare all’esterno.
“La povertà economica, culturale e sociale incide sia sulla selezione in ingresso che sulla permanenza in casa lavoro”, sottolinea Giulia Melani nella sua ricerca. Il risultato è una discarica sociale dove vengono deportati gli ultimi tra gli ultimi, una forma di doppia pena per gli autori di reati ormai estinti che si protrae all’infinito. In certi casi anche per 30 anni, rinnovati di sei mesi in mesi come nella peggiore delle forme di tortura. E se l’unica cosa che potrebbe tenere impegnati è un’occupazione, la realtà dei fatti è che nelle case lavoro spesso non si lavora, perché chi viene mandato al suo interno è semplicemente inabile a farlo.
Come fantasmi
La scorsa estate un internato della casa lavoro di Vasto si è tolto la vita. Aveva 40 anni, era di origine maghrebina, era stato trasferito da pochi giorni nell’articolazione per la tutela della salute mentale all’interno della struttura. Qualche mese dopo, a inizio gennaio, un altro internato della casa lavoro abruzzese è stato trovato morto di prima mattina nella sua brandina, apparentemente per cause naturali. Questi episodi, insieme a tutte le carenze quotidiane che contraddistinguono la vita degli internati, hanno portato a una violenta rivolta, che si è conclusa con la devastazione degli ambienti e il ferimento di alcuni agenti di polizia penitenziaria.
Quello che è successo nella casa lavoro di Vasto era altamente prevedibile. L’equazione è semplice per tutti, tranne che per chi invoca più repressione e misure di sicurezza: se si accumula conflittualità in un luogo ristretto, poi questa a un certo punto è destinata a divampare. È quello che è successo nelle carceri italiane nel marzo 2020, quando la sospensione dei colloqui per limitare la diffusione del Covid-19 aveva causato rivolte che si erano tradotte nella peggiore strage penitenziaria del dopoguerra, con tredici morti. Era da tempo che si evidenziava la necessità di migliorare la situazione nelle carceri perché altrimenti la situazione sarebbe precipitata e nel 2019 perfino il Comitato europeo contro la tortura si era espresso in questo senso. Non venne fatto niente e la strage ne fu una diretta e consapevole conseguenza. Molti di quei decessi avvennero a Modena e un giorno, qualche mese più tardi, un gruppo di cinque detenuti decise di raccontare in un esposto le violenze cui avevano assistito in quelle ore tragiche e tutti gli errori che erano stati commessii dalle autorità. Uno di loro poco dopo venne liberato perché aveva scontato la sua condanna ma subito dopo fu trasferito in una casa lavoro perché ritenuto “pericoloso socialmente”. Gli attivisti che seguivano il caso dissero che all’uomo era stata fatta pagare la sua denuncia delle violenze di Modena, rivelando un altro dei possibili utilizzi delle case lavoro, quello vendicativo.
Della persona di Modena, poi, non si seppe più niente. Entrare in una casa lavoro significa recidere ogni contatto, o quasi, con l’esterno. Sparire. Proprio come è stato per Elia Del Grande. Per qualche giorno la sua fuga ha aperto un dibattito sulla sua condizione di reclusione nonostante una pena già scontata. Ha costretto i giornali a parlare, spesso per la prima volta, delle case lavoro. Poi Del Grande è stato ricatturato. Ed è tornato a essere invisibile. Un fantasma, come le migliaia di persone che dal fascismo a oggi hanno popolato questi spazi dimenticati. Dove, nel silenzio-assenso delle istituzioni, il diritto resta sospeso.