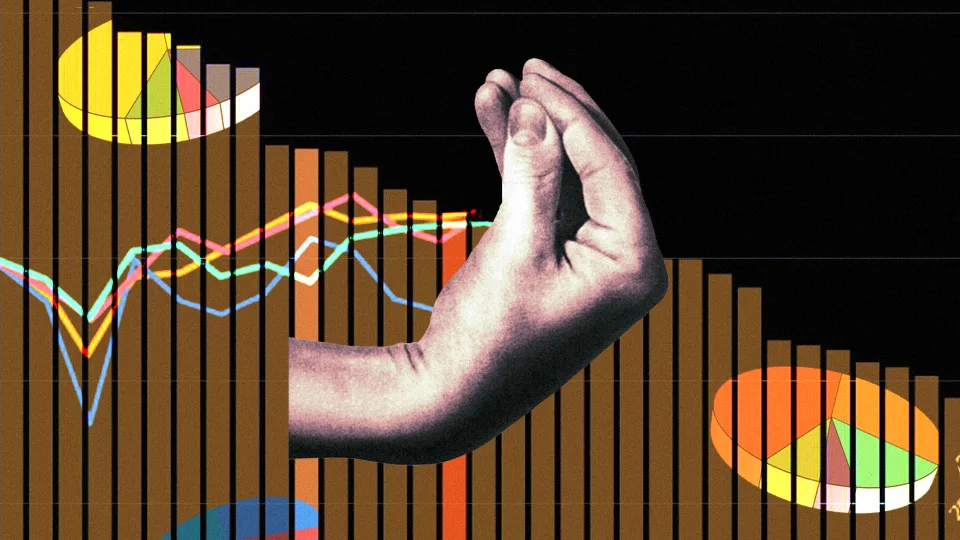Tra il 2002 e il 2021 sono andate via dal Sud 2,5 milioni di persone. Di queste, 800 mila avevano meno di 35 anni. Entro il 2080 si prevede una perdita di oltre 8 milioni di residenti. Quella che è stata a lungo l’area più giovane d’Italia diventerà la più vecchia. E la politica nazionale sembra aver smesso di considerarlo un problema.
L’Italia meridionale è oggi l’area arretrata più estesa d’Europa. A questo primato se ne aggiunge un altro: se l’inverno demografico rende l’Italia tra i paesi più anziani al mondo, promettendo un drastico ridimensionamento della sua popolazione nei prossimi decenni, lo spopolamento al Sud (il saldo negativo tra nascite, morti, fughe) segue ritmi ancora più incalzanti. Il Mezzogiorno potrebbe diventare presto un continente fantasma, tra l’incapacità della classe politica di guardare oltre le prossime elezioni (e gli operatori turistici oltre la prossima estate), l’imminente opportunità per noi poetastri di cantare molto presto un mondo perduto e l’attuale compiacimento degli esteti meridiani (i più vacui in assoluto) per i quali “il Sud è assenza”.
Per capire i termini di una sconfitta storicamente rinnovata, che rischia di diventare il tracollo di tutti, è utile leggere Storia dell’Italia meridionale di Pino Ippolito Armino, pubblicato da Laterza.
Cominciamo dalle fughe. Tra il 2002 e il 2021, scrive Armino, sono andate via dal Mezzogiorno 2,5 milioni di persone. Di queste, 800 mila avevano meno di 35 anni. Entro il 2080 si prevede una perdita di oltre 8 milioni di residenti. Il Mezzogiorno, che è stato a lungo l’area più giovane d’Italia, diventerà la più vecchia, e anche la meno consistente (prima dello Stato unitario 4 italiani su 10 erano meridionali, tra qualche decennio diventeranno un quarto della popolazione nazionale, con un possibile decremento del 50% nella fascia tra i 0 e i 12 anni). Non so se questi numeri rendono l’idea di quale svuotamento (identitario, culturale, politico) attende il Paese intero. Chi non capisce il Sud non capisce l’Italia, si diceva una volta, e nel XXI secolo neanche il mondo, così tra i meno capaci di comprendere ciò che sta accadendo troviamo oggi – in apparenza su poli opposti, di fatto strozzati dallo stesso cordone ombelicale – sia i ragionieri dell’autonomia differenziata (gli eredi di quelli che pensano che il Sud fannullone e vittimista rubi al Nord ingegnoso e produttivo) che gli esoterici cantori delle Catacombe dei Cappuccini che travisano Franco Battiato e Carmelo Bene (quelli convinti che per partenogenesi la vita si rinnovi dal marmo di Trani o da una cattedrale barocca anche quando non ci fosse più nessuno a guardarla o ricordarla, e – meno che mai – manutenerla). E tuttavia i sinceri democratici, vedremo, non stanno messi tanto meglio.
Sempre per restare ai numeri di Armino, oggi chi abita in Campania vive in media 3,2 anni in meno di chi risiede nella provincia autonoma di Trento. È uno squilibrio che racconta bene la diversa qualità dei sistemi sanitari. Meno intuitive le conseguenze: nel solo 2023 “le regioni meridionali, in particolare la Calabria, la Campania, la Sicilia e la Puglia, hanno trasferito quasi un miliardo di euro alla Lombardia, all’Emilia Romagna e al Veneto per garantire ai propri cittadini le cure mediche che non sono state in grado di offrire sul loro territorio”.
Delle difficoltà del Sud si sta dunque approfittando il Nord per ammortizzare il proprio, di declino?
Pino Ippolito Armino è tutt’altro che un neoborbonico. Contro i nostalgici di Ferdinando II aveva scritto un libro nel 2021, Il fantastico regno delle due Sicilie, dove sottoponeva a fact-checking molte menzogne di questa scuola di pensiero. Ma è il motivo per cui, libero dal clima vittimista e rivendicativo di chi vorrebbe rovesciare in un manifesto terrone il secessionismo neopagano di Pontida (più insidioso oggi di trent’anni fa, travestito com’è da epica nazionalista e cristianoide), Armino può rendere conto anche ai Savoia della loro miseria quando si tratta di ragionare su come si è formato il divario.
Provando a riassumere, almeno sette sarebbero per Armino le tappe che storicamente – partendo dalla fine del Settecento – avrebbero compromesso in modo così grave l’equilibrio tra le due aree del Paese: 1) il fallimento della Rivoluzione napoletana del 1799 e la violentissima repressione che ne seguì (il meglio dell’intelligenza illuminista, un’intera classe dirigente, fu sterminata; Armino ricorda l’episodio di Nicola Fiani, ridotto a brani dalla plebe, abbrustolito e mangiato, prefigurazione in chiave orrorifica di tutte le volte in cui i tentativi di modernizzazione – il Sud come parte più evidente di una questione nazionale – non riuscirono a coinvolgere i ceti popolari; basti pensare mezzo secolo dopo alla morte di Carlo Pisacane); 2) la mancata svolta costituzionale dei Borboni contrapposta alle aperture sabaude sempre più decise da un certo punto in poi; 3) il modo in cui, sotto la linea di Cavour, l’unificazione avvantaggiò effettivamente sotto diversi aspetti il Settentrione a scapito del Mezzogiorno (“l’unificazione amministrativo-finanziaria”, ricorda Armino, “impose a tutti gli italiani il pagamento degli interessi sui titoli del debito pubblico che erano in larga misura un’eredità del Piemonte”, per non parlare dell’impatto della politica fiscale che portò i meridionali a pagare tasse poco prima sconosciute, o al modo in cui le manifatture tessili del Sud si trovarono a perdere, da un momento all’altro, le commesse statali; Armino ipotizza, come effetto dell’unificazione, una perdita di 200.000 posti di lavoro al Sud, “un numero immenso su una popolazione di poco più che 9 milioni di abitanti”); 4) le tariffe protezionistiche promosse alla fine del XIX secolo dal Regno d’Italia che danneggiarono in modo pesantissimo la piccola e media impresa agricola meridionale; 5) l’economia di guerra del fascismo che dagli anni ’30 investì massicciamente nel triangolo industriale del Nord; 6) Il fallimento dell’intervento straordinario che l’Italia repubblicana cercò di operare al Sud con la creazione della Cassa del Mezzogiorno, risoltasi in una selva di clientele e vampirismi locali, a cui c’è da aggiungere la presenza devastante della criminalità organizzata; 7) l’invenzione della “Questione settentrionale” dall’inizio degli anni ’90 del Novecento, la rivolta dei ricchi contro i poveri che riguarda in realtà oggi una porzione ben più grande di mondo.
È paradossale notare come una parte consistente della nostra produzione culturale – specie per la Sicilia e la Campania ma non solo, soprattutto per il cinema e la letteratura, basti pensare a L’amica geniale eletto dal «New York Times» come il romanzo più importante finora di questo secolo, o ai record di incassi cinematografici dei film di Checco Zalone – continui a trarre ispirazione da ciò che accade a Sud, e come questo (chiamiamolo così) “strapotere dell’immaginario” sia del tutto fuori scala rispetto al peso sempre meno consistente (economico, politico, adesso dicevamo anche demografico) del Sud in una vicenda nazionale che da una parte del Mezzogiorno vorrebbe forse liberarsi, ma dall’altra non può farlo senza vedere la propria identità stravolta in modo irreparabile.
“L’Italia meridionale è oggi l’area arretrata più estesa d’Europa. A questo primato se ne aggiunge un altro: se l’inverno demografico rende l’Italia tra i paesi più anziani al mondo, promettendo un drastico ridimensionamento della sua popolazione nei prossimi decenni, lo spopolamento al Sud (il saldo negativo tra nascite, morti, fughe) segue ritmi ancora più incalzanti”.
Se per le frange più reazionarie l’autonomia differenziata realizza un sogno punitivo inconfessabile (mettere in ginocchio chi se l’è goduta nel disagio, chi riesce a ridere nelle tragedie, a mangiare senza lavorare, a volte persino a mangiare senza mangiare – qui basta leggere male Malaparte), la parte progressista mi pare a sua volta nel pieno di un abbaglio, o forse gioca furbescamente di rimessa.
Negli ultimi trent’anni ci sono state tre “primavere meridionali”, tutte ascrivibili al centro sinistra. Ricordo la “primavera siciliana” successiva alle stragi di Capaci e via D’Amelio, seguita da quella “campana” di Antonio Bassolino. Dopo aver suscitato grandi speranze (e aver prodotto, ancora una volta, occasionali meraviglie non intenzionali, ricordiamo ad esempio come l’epopea di Ciprì e Maresco diventi “nazionale” nell’imminenza delle stragi, con la prima messa in onda di Cinico TV su Rai3 proprio nel 1992) entrambe sono regredite rapidamente nella palude di un autunno stagnante. Più complicato il caso della “primavera pugliese”, cominciata ufficialmente con il primo mandato di Nichi Vendola presidente della Regione nel 2005 ma preparata da un fermento culturale attivatosi almeno quindici anni prima. La “primavera pugliese” non si può dire sia fallita, le è capitato però qualcosa di assai insidioso: è sfociata cioè in un’estate talmente torrida da rischiare di bruciare il raccolto. Il rinnovamento culturale (compresa la rivisitazione in chiave viva della tradizione, basti pensare all’epopea della Notte della Taranta o a film come Lacapagira o a libri come Il pensiero meridiano) rischia di trasformarsi, anni dopo, in pura attrazione turistica dove tutto è “cultura” (la masticazione del panzerotto a dieci euro come rito rigenerativo, una versione leggera per scandinavi dell’ayahuasca turistica in Brasile), e una linea di pensiero mediterraneo che si proponeva come alternativa a quella dominante pare essersi interrotta, complice anche la scomparsa prematura di alcuni suoi protagonisti, penso a Franco Cassano, Guglielmo Minervini, Alessandro Leogrande. La logica delle masserie e dei bnb vestiti a calce o damascati sembra avere contagiato anche altre regioni come Sicilia e Campania – non mi pare sia avvenuto qualcosa di diverso con la “piccola primavera” lucana conseguente all’elezione di Matera Capitale europea della cultura. L’impressione è che, insomma, rientrata la possibilità di una vera emancipazione e di un robusto rinnovamento (ma il resto d’Italia non cova in modo meno disagiato lo stesso male?), sia venuto istintivo ripiegare sul cosiddetto estrattivismo, celebrandolo con entusiasmi inquietanti, il tutto mentre i redditi della gente comune restano al Sud tra i più bassi d’Europa e le liste d’attesa per un esame medico arrivano a superare l’aspettativa di vita di chi ne fa richiesta.
Come si è capito non sono un sostenitore di questo modello. Ma sopporto ancora meno l’estetismo dei nostalgici del latifondo, gli apologeti della miseria altrui. Anche io credo nella tradizione dei miei luoghi d’origine, credo che nel Sud risieda un pensiero e un modo di vivere e di stare con gli altri e di vedere il mondo capace di irrorare positivamente il pensiero e la cultura dominanti (da questo punto di vista l’Italia ha forse bisogno del Sud più che il contrario; così come l’Europa, un continente in questo momento in crisi, dovrebbe guardare di nuovo al proprio mare), credo che al Sud il mito si faccia fantasmagorico (cioè duttile, mutante, vivo) e non legato al culto dell’origine e del sangue, e nello stesso momento in cui omaggio Di Vittorio e rileggo Guido Dorso o Carlo Levi e ammiro le meridionali d’adozione come Lisetta Carmi (e mi sembra estremamente interessante il modo in cui Franco La Cecla e Vito Teti reinterpretano Ernesto De Martino) posso sostenere – mi limito alle Puglie – che a Copertino i santi volino davvero, che a Capurso la Madonna esca dal pozzo stringendo un cuore in fiamme, che nella Foresta di Mercadante sfrecci il fantasma di Fra’ Diavolo, che a Castel del Monte sia custodito il Graal, che sulle Murge il vento tra le rocce parli la lingua di Dio. Ricordo certo Carmelo Bene quando (più vicino a Pasolini di quanto desiderasse) elogiava l’analfabetismo dei contadini salentini, i quali – prima di imparare a leggere e scrivere infarcendosi così di opinioni non proprie, e prima che, sentendo il lavoro come un dovere, barattassero la fame con la fine della libertà – sarebbero stati vicini al sacro, all’abbandono, fuori dalla tirannia di Chronos. Ma un conto, passando per Artaud, è riversare genialmente questi rapimenti in Nostra Signora dei Turchi. Altro è fare l’elogio del tempo dei servi della gleba sentendosi (tra arroganza e ridicolo) parte di un’aristocrazia contemporanea.
Bisogna ripensare la Questione Meridionale. In un tempo in cui si moltiplicano gli odi, i massacri, i fili spinati, il Sud è forse un “luogo” dove i confini si fanno meno critici, ponti imprevisti vengono riedificati, lo straniero torna pellegrino, sorge la possibilità di amicizie che sotto altri domini culturali sarebbero inimmaginabili.
Se il Sud si stacca o viene staccato dal resto del Paese (e, allargando il discorso, dal resto del mondo), ho l’impressione che la deriva riguardi tutti quanti.