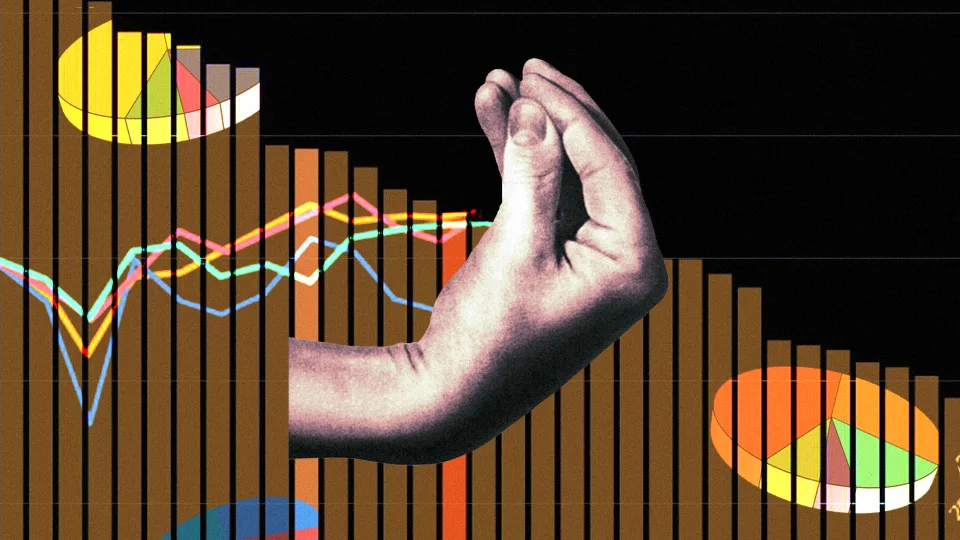Fare i conti con le storie delle nostre famiglia significa, spesso, fare i conti con la violenza della storia. Un passato che ci riguarda e che ereditiamo nella tragica consapevolezza di non poterlo mutare.
È stato intorno ai 15 anni che ho iniziato ad accorgermi di come nella mia famiglia ci fosse una sorta di grande rimosso, qualcosa di cui i miei non parlavano. Mio nonno, a quanto pare, era ebreo. O meglio: mezzo ebreo, figlio di una donna ebrea (non praticante) e di un uomo cristiano (non praticante).
Al tempo, questa storia d’amore e questo figlio crearono un bel po’ di problemi, tanto che il mio bisnonno e la mia bisnonna decisero di battezzare il nuovo arrivato in chiesa, di nascosto dai genitori di lei.
Penso che fosse perché avevano letto lucidamente la situazione intorno a loro in quell’Italia di inizio anni Trenta, più che per un’ipotetica vicinanza agli insegnamenti e ai precetti di Gesù Cristo; dopo aver rischiato di avvelenare la famiglia con le bugie, mio nonno finirà infatti per andare a messa una manciata di volte in tutta la sua vita.
Il battesimo, in una maniera o nell’altra, riuscì a proteggerlo dalle discriminazioni che sono poi arrivate nel 1938, ma non si può certo dire che fosse un bravo fedele. Da ebreo che in realtà non era un ebreo e da cristiano che in realtà non era un cristiano: nonno Alberto ha attraversato il Novecento limitandosi a essere un donnaiolo e un ginnasta, poi a cascata un padre e marito amorevole, un vedovo addolorato, un nonno devoto, un ammiratore di Gabriella Ferri, un berlusconiano di ferro.
Il rimosso nella nostra famiglia non è stato però una maniera di processare un trauma, dato che mio nonno, pur essendo ebreo, non ha mai realmente sofferto sulla sua pelle il costo delle sue origini. Quando a un certo punto fu deportato in un campo di smistamento pronto a essere spedito in Germania, ci finì in quanto forza lavoro italiana rastrellata nella provincia pisana e non in quanto Juden. Il rimosso nella nostra famiglia era semplicemente una dimenticanza: l’essere ebreo di mio nonno ha significato così poco nella nostra vita, che, alla fine, ce lo siamo persino scordati.
Ho combattuto strenuamente contro questa rimozione, devo ammetterlo: l’inizio della mia formazione come storico e la perenne crisi identitaria che, come me, attanaglia tanti giovani uomini bianchi eterosessuali d’occidente mi spinsero, verso i vent’anni, a cercare di rintracciare questa pista che aveva solo tangenzialmente sfiorato la storia della mia famiglia.
Ho fatto ricerche, ho fatto domande, ma a quel punto nonno era affaticato dagli anni che si portava sulle spalle e i miei genitori, i miei zii, i miei cugini, sembravano più interessati a chiedere a quel vecchietto come stesse di salute, e non a chi si era raccomandato suo padre carabiniere (il mio bisnonno) per evitare di far cacciare il figlio ebreo da scuola.
Io, che non ho mai letto un paragrafo de Il Girasole di Simon Wiesenthal senza piangere, avrei fatto di tutto per avere un nonno ebreo. Nonno, da parte sua, non poteva darmi ciò che volevo; la sua storia non era quella degli ebrei d’Europa, ma, figurarsi, degli italiani come li intenderebbe Stanis La Rochelle. Il sabato in camicia nera, la domenica a pranzo con la famiglia della porta a fianco. Che aveva scritto Toaff sul campanello, ed era la famiglia del rabbino Alfredo Sabato.
Nelle cosiddette memory wars, ovvero quegli spazi del dibattito pubblico dove si ridefinisce la memoria collettiva nazionale attraverso uno scontro innescato da ragioni politiche, la vicenda della mia famiglia sarebbe una storia di diserzione. Non solo non abbiamo mai puntato il fucile contro la testa di qualcuno, ma nessuno ha mai neanche puntato il suo fucile alle nostre teste. E se è successo (mio nonno in un campo di smistamento, la mia prozia rincorsa da un soldato tedesco) non sembra ce ne sia importato particolarmente; c’era la guerra, dopotutto, e queste cose erano il minimo che ti potesse capitare.
È così che mi sono rivolto a guardare le famiglie degli altri, quelle di coloro i cui padri non hanno mai smesso la divisa o non sono mai davvero tornati dal fronte. Le famiglie fiaccate dalla colpa, in particolare. È quella l’unica cosa che sono convinto non si scordi mai: ci si dimentica della sofferenza subita – lo ha fatto mio nonno, che mi raccontava del campo come un posto divertente perché, da fumatore non più di tanto accanito, scambiava volentieri le sue sigarette con una doppia o tripla razione di cibo – ma mai della sofferenza che gli è stata certamente inflitta. Il dolore passa, lo attenua il tempo o magari la gioia, ma questo non accade con la colpa.
“Ho combattuto strenuamente contro questa rimozione, devo ammetterlo: l’inizio della mia formazione come storico e la perenne crisi identitaria che, come me, attanaglia tanti giovani uomini bianchi eterosessuali d’occidente mi spinsero, verso i vent’anni, a cercare di rintracciare questa pista che aveva solo tangenzialmente sfiorato la storia della mia famiglia”.
In proposito mi viene in mente The act of killing, documentario sulle purghe anti-comuniste degli anni Sessanta in Indonesia diretto da Joshua Oppenheimer. Mentre Anwar Congo, un gangster tra i maggiori responsabili dei massacri, ricorda quegli anni in un’intervista, non può far altro che piangere e vomitare. “I miei sogni sono infestati dalle voci minacciose delle vittime”, dice. “Sono fantasmi che ritornano, e che mi odiano. Li sento ridere, e questo mi terrorizza”.
Le schiere di chi si è seduto dalla parte del torto non sono mai state così folte come negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, in particolare nell’esperienza storica dell’uccisione sistematica degli ebrei d’Europa. Mai come fino a quel momento, nella storia dell’umanità, il Male ha avuto una tale adesione, sistematizzazione e ambizione. Mai il carnefice era stato così tanto carnefice, e la vittima così vittima. E se il destino delle vittime era quello di soccombere e morire, a sopravvivere rimanevano i carnefici; loro hanno costruito le società che abitiamo oggi, loro hanno avuto figli, e poi nipoti, e poi pronipoti.
La colpa è così arrivata fino a noi, perdipiù assopita sotto patetiche retoriche come quella dei “nostri nonni partigiani”: cioè attraverso una seria mancanza di reali processi di sanificazione delle società nel dopoguerra. Se delle vittime non rimangono più neanche le ossa, dei carnefici restiamo noi.
Nella comunità online di appassionati di “Holocaust Studies” (quella nicchia interdisciplinare di ricerca che studia l’eliminazione sistematica degli ebrei d’Europa durante il nazismo) di queste faccende negli ultimi anni se ne è parlato in abbondanza per via soprattutto di alcune pubblicazioni fondamentali. Una di queste è il lavoro della storica franco-tedesca Géraldine Schwarz, che nel 2017 (la traduzione in inglese avverrà tardi, nel 2021) ha pubblicato uno straordinario lavoro sulla storia della sua famiglia durante l’Olocausto.
In I senza memoria (Einaudi, 2019) Schwarz ripercorre le esistenze dei nonni, gente mai realmente interessata alla politica e che lei colloca tra i Mitläufer, ovvero coloro che ‘seguono la corrente’ e si adattano alle condizioni intorno a loro. Uno dei passaggi più significativi del libro riguarda il momento in cui il padre di Schwarz prende per la prima volta coscienza di una forma di “colpa” fino ad allora invisibile.
La rivelazione avviene quando è ancora adolescente: osservando alcune fotografie dell’appartamento di famiglia prima della guerra, si accorge che l’arredamento è cambiato. In quella discrepanza materiale solo in apparenza banale si apre per lui la consapevolezza della sottrazione. Sia nella sala da pranzo che in salotto, a un certo punto, appare un mobilio che i nonni non avrebbero in precedenza potuto permettersi. “Quel mobilio”, dice il padre a Schwarz, “con la sua aria da grande borghesia, non corrispondeva alla condizione sociale di allora dei miei genitori, e dato che non ne avevano bisogno perché di mobili ne avevano già, a spingerli a comprarli doveva essere stato il loro prezzo irrisorio. Ma durante la guerra erano i beni degli ebrei a essere svenduti a quel modo, e lo si sapeva”.
La coppia non si era sporcata le mani di sangue, ma aveva fatto qualcosa che forse era anche peggiore: da quello stesso sangue, aveva tratto profitto. Oltre al mobilio, i due avevano “acquistato” (“arianizzato”, si diceva al tempo) un’attività commerciale dai Löbmann e dai Wertheimer (due famiglie di ebrei) quando queste erano state già sequestrate o forse quando i loro proprietari non avevano altra possibilità che vendere per finanziare la fuga.
È da quelle aziende che la famiglia si era assicurata una sicurezza economica, ed era proprio su quel tavolo che pranzavano tutti insieme nei giorni di festa. Mentre i Löbmann e i Wertheimer fuggivano oltreoceano, o venivano imprigionati, deportati e gassati nei campi di sterminio, la colpa arredava la casa. Di fatto la colpa era, nella famiglia Schwarz, il motivo per il quale puoi pagare le bollette, o il mobile Art déco alla cui vista gli ospiti ti riempiono di complimenti.
Un altro momento in cui la famiglia è tornata al centro degli studi sul nazismo è la ricerca pioneristica portata avanti dallo studioso tedesco Jürgen Matthäus su una delle foto più famose, agghiaccianti e misteriose dell’Olocausto: “The Last Jew in Vinnitsa”. Di questo scatto abbiamo sempre saputo poco, tranne un’indicazione sul luogo (Vinnitsa, oggi in Ucraina), l’anno (1941) e ciò che si vede: una folla di SS che assiste impassibile a un’esecuzione di un uomo inginocchiato di fronte a una fossa, e nella quale ci sono ammucchiati già decine di corpi. Matthäus lavora a quella foto da diversi anni, anche grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale e a una comunità di ricercatori amatoriali che lo segue, e ha scoperto cose interessanti: per esempio che la foto è stata scattata nel primo pomeriggio del 28 luglio 1941, che si trovavano a Berdychiv (e non Vinnitsa), e che gli uomini erano appartenenti all’Einsatzgruppe C. Grazie alle sue ricerche Matthäus è stato in grado anche di dare un nome all’uomo con la pistola in mano: Jakobus Onnen, un insegnante tedesco della Frisia Orientale.
Nonostante tanti articoli sulla vicenda citino il rivoluzionario uso dell’AI per svelare l’identità di Onnen, questo è falso: Matthäus grazie all’Intelligenza Artificiale è riuscito a confermare con quasi certezza, tramite comparazione fisionomica, che Onnen e l’assassino siano la stessa persona, ma quel nome è in realtà affiorato soprattutto grazie alla memoria dell’esperienza storica nazista: di nuovo, dunque, per via della colpa familiare.
Negli ultimi anni, infatti, lo storico tedesco ha ricevuto molte segnalazioni sulla possibile identità del soldato: una in particolare, però, cattura la sua attenzione. A scrivere è un insegnante di liceo in pensione in Germania, che ammette di aver ben presente la foto; da decenni, almeno da quando è stata resa celebre durante il processo a Eichmann in Israele, la sua famiglia è infatti tormentata da quelle immagini. Parla di un’angosciante somiglianza con il fratello della madre di sua moglie, un fanatico nazista che nel 1941 stava prestando servizio in Ucraina proprio come ufficiale delle SS, e proprio nell’Einsatzgruppe C. Questo zio, che si chiamava appunto Jakobus Onnen, era morto al fronte nell’agosto del 1943 e nessuno dei suoi familiari era riuscito mai a fargli la domanda più difficile: sei tu, in quella foto, a sparare?
Questa domanda se la stanno facendo in molti oggi, anche se Onnen non potrà mai rispondere. Se l’è fatta Jürgen Matthäus, ce la stiamo facendo noi. Se la stanno facendo anche i cittadini di Weener, la cittadina della Bassa Sassonia dove Onnen era cresciuto e che, dopo la guerra, avevano inciso il suo nome in una targa commemorativa.
Fino a poco prima, infatti, Onnen era uno dei tanti soldati della Wehrmacht e delle SS caduti al fronte i cui nomi vengono sommessamente ricordati nei cimiteri e nelle piazze tedesche o austriache; tutti sanno che il rischio, in questi casi, è che i criminali di guerra si confondano con i sedicenni spediti a fermare l’Armata Rossa come un sacchetto di biglie, ma una comunità non si può permettere di cancellare i suoi figli (anche quelli maledetti). L’amministrazione della cittadina ha iniziato a vagliare le sue possibilità, dalla rimozione del nome dalla targa all’integrazione di un testo di contestualizzazione vicino a questa. Qualunque decisione venga presa, non è questo il punto comunque. Il punto è che, in una comunità piccola e chiusa come quella di Weener, Onnen è anzitutto uno di famiglia. È in questa dimensione che viene riconosciuto e protetto, prima (o, e questo lo concedo, almeno tanto quanto) del gesto che lo consegna alla storia come l’uomo che spara a quell’ebreo. È allo stesso tempo un padre e un figlio di quella gente. Quando il sindaco di Weener pubblica su Facebook una dichiarazione sul tema e qualcuno commenta affermando che i caduti nell’Est non erano vittime e non meritano di essere ricordati; un altro utente commenta: “E chi erano, i tuoi genitori?”.
Lontana da quella presunta naturalezza in cui amiamo crogiolarci, la famiglia è un costrutto sociale e, in definitiva, è la comunità. Dopotutto, il nostro rapporto con i familiari è definito dagli stessi intrecci storico-culturali che in fondo dettano il nostro rapportarci con il resto delle persone: la tradizione greco-romana (che definisce la famiglia come unità economica e patrimoniale), il cristianesimo (la sacralizza e la moralizza), l’illuminismo (la ridefinisce in ottica contrattualistica e educativa) e la rivoluzione industriale (ecco, finalmente, la famiglia come nucleo borghese).
È questo che ci leggiamo nei commenti della pagina Facebook della municipalità di Weener: le memory wars che attraversano le famiglie sono le stesse che attraversano le società contemporanee. Parlano la stessa lingua, hanno gli stessi volti, lo stesso sangue sulle mani e ci mettono di fronte allo stesso bivio: condannare, certo, ci mancherebbe, ma si figuri, e poi? Poi dimentichiamo, o perdoniamo?
Questa è la questione principale di ogni processo di pace, il cosa farne della colpa. Una volta che la giustizia ha esaurito il proprio corso, che i carnefici materiali non sono più nelle condizioni di pagare, nessuna società può permettersi di vivere a lungo con il germe del peccato originale a corroderla. Quindi si dimentica, o si perdona.
Si può dimenticare come propone di dimenticare Elon Musk che, pochi giorni dopo essersi esibito in un saluto fascista durante la cerimonia di insediamento di Trump alla Casa Bianca, è apparso in un raduno di Alternative für Deutschland affermando che “dobbiamo andare avanti e smetterla di focalizzarci sulle colpe del passato”. “Non è giusto che i figli paghino per colpe dei loro padri”, ha detto il figlio di Errol Musk, proprietario di una miniera di smeraldi in Zambia, “figuriamoci se parliamo di nonni o bisnonni”. Però, si può dimenticare anche come proponeva di fare Winston Churchill, quando già nel 1946 in un discorso all’Università di Zurigo parlava di “un atto salutare di dimenticanza” fine a “voltare le spalle agli orrori del passato” per focalizzarsi sul futuro. Oppure, si può perdonare. Si può intraprendere un percorso di riconoscimento e responsabilizzazione tanto difficile quanto però necessario a elevare l’esperienza umana in questo mondo. Non è facile, e non è obbligatorio.
Se è difficile e complicato percorrere una qualsiasi di queste strade in quanto cittadino, lo è ancora di più in quanto familiare. Il motivo è semplice, e lo abbiamo anticipato sin dalle prime righe: la famiglia riguarda noi stessi. Noi, in definitiva, siamo una diretta emanazione di questa. Per questo volevo disperatamente che mio nonno fosse ebreo, perché così ero un po’ ebreo, un po’ vittima, anche io. Perdonare o dimenticare il sangue del tuo sangue, se ci pensate bene, è un po’ come perdonare o dimenticare sé stessi.