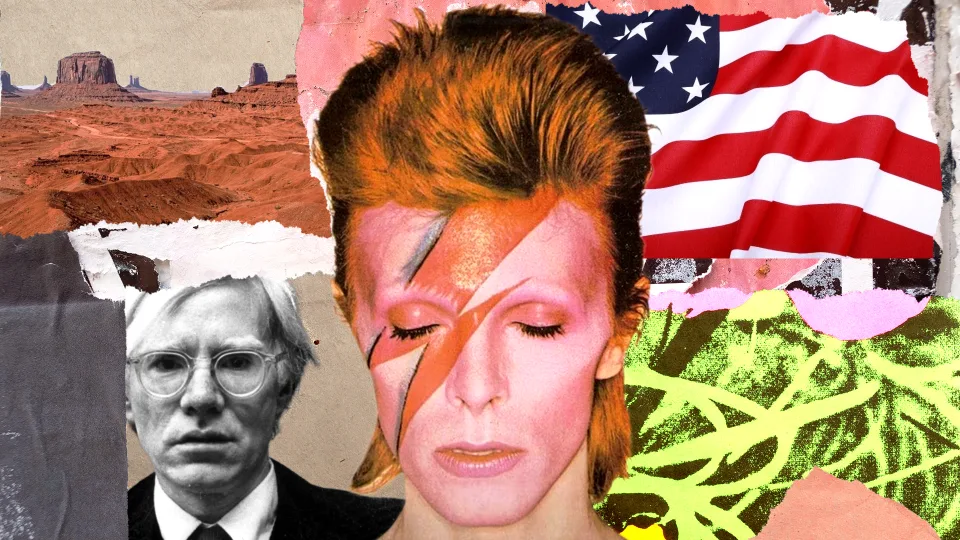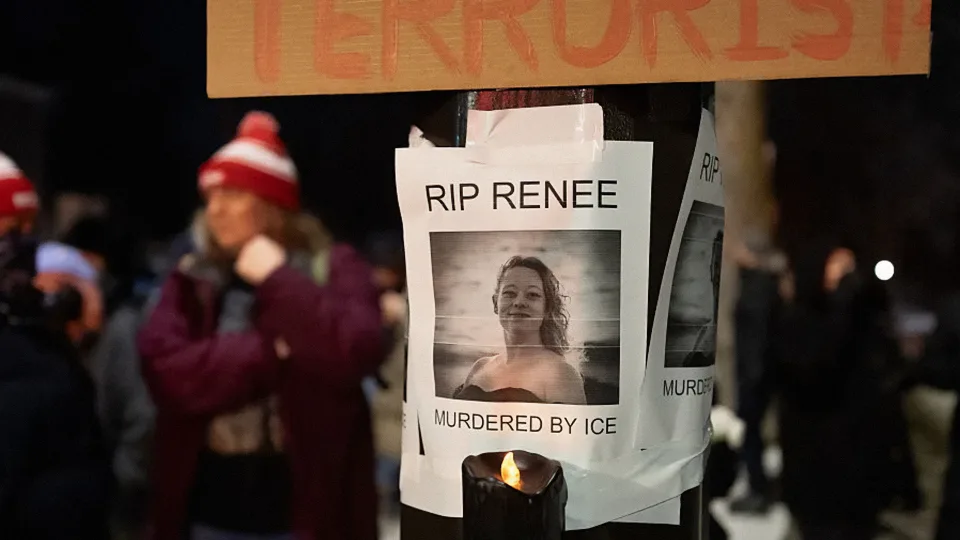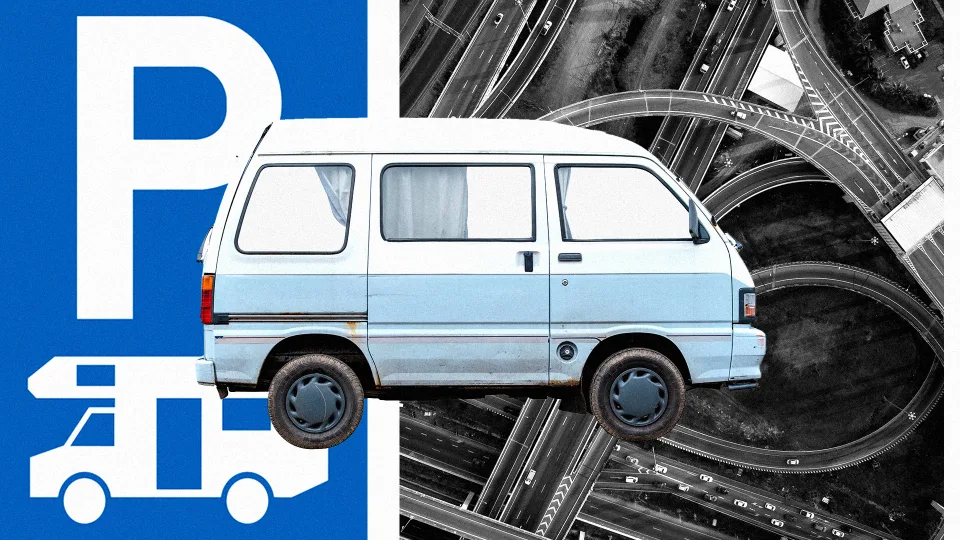Unico italiano in concorso a Cannes, quello di Martone – tratto da L’università di Rebibbia di Goliarda Sapienza – è un film molto riuscito. E conferma che l’autrice di L’arte della gioia è una benedizione per il cinema.
“Ho rubato a una di queste pseudo-signore per punirla. O per punirmi?”
Il 4 ottobre del 1980 Goliarda Sapienza viene arrestata a Roma nella sua casa ai Parioli. L’accusa è aver rubato dei gioielli a una conoscente. Il furto è avvenuto poco più di un anno prima nella casa della proprietaria dei gioielli, che Sapienza ha poi venduto a un banco dei pegni. Al momento dell’arresto la scrittrice catanese ha cinquantasei anni, gliene restano sedici da vivere, ha pubblicato due libri (Lettera aperta e Il filo di mezzogiorno), ha lavorato in teatro e recitato in qualche film. Quello che verrà considerato il suo capolavoro, L’arte della gioia, è per adesso oggetto di continui rifiuti editoriali.
Riportando il 5 ottobre la notizia dell’arresto, l’edizione locale di un noto quotidiano definisce erroneamente la scrittrice “ex moglie del regista Maselli”. Goliarda Sapienza ha avuto una lunga relazione con Citto Maselli, ma è finita da tempo. Ha sposato l’anno prima un attore, Angelo Pellegrino. La loro unione ha destato qualche sospiro nel più bacchettone dei mondi, quello intellettuale: lui è più giovane di 22 anni.
Sapienza sconterà una breve reclusione nel carcere di Rebibbia e la racconterà poi in un libro, L’università di Rebibbia. Da questo libro Mario Martone ha tratto uno dei suoi film più belli, Fuori, scritto con Ippolita di Majo, presentato ieri al Festival di Cannes.
Il film alterna il durante e il dopo, con una scelta efficace di tempi alternati. Ci sono i giorni della detenzione. E ci sono i mesi successivi, quelli in cui Goliarda Sapienza usa, per misurare la pochezza del mondo esterno, l’unità di misura appresa in carcere. La frequentazione delle altre detenute è stata per lei un’esperienza profonda, attraverso la quale, per contrasto, ha potuto mettere a fuoco, in modo sempre più nitido, l’Italia a cavallo tra anni Settanta e Ottanta. Le sembra adesso di capire in pieno di che pasta è fatto il Paese rappresentato dalla politica e dalla società civile, dal buon senso del mondo piccolo borghese e dall’ipocrisia della società letteraria (atterrita e deliziata dallo scandalo).
In galera Goliarda Sapienza scopre insomma un altro mondo.
“Sono da così poco sfuggita dall’immensa colonia penale che vige fuori”, scrive ne L’università di Rebibbia, “ergastolo sociale distribuito nelle rigide sezioni delle professioni, del ceto, dell’età, che questo improvviso poter essere insieme – cittadine di tutti gli stati sociali, cultura, nazionalità – non può non apparirmi una libertà pazzesca, impensata”.
Potrebbe sembrare una dinamica simile a quella che aveva portato trent’anni prima Pier Paolo Pasolini a scoprire le borgate. Ci sono delle differenze. Pasolini diventava non di rado oggetto di persecuzione ma non era un emarginato, riceveva denunce per reati che non aveva commesso (tra le più assurde l’accusa di aver rapinato, armato di pistola, un benzinaio del Circeo) ma occupava una posizione centrale nella cultura italiana ed europea. Goliarda Sapienza non era una perseguitata (venne arrestata per un furto che aveva commesso) ma era un’emarginata, faticava a pubblicare, veniva reputata un’artista a dir bene secondaria, tanto da ricevere un pieno riconoscimento solo dopo la morte. L’arte della gioia, pubblicato coraggiosamente in versione parziale da Stampa Alternativa nel 1994, venne accolto in Italia in modo entusiastico dopo essere diventato un caso in Francia nel 2005.
Ma c’è una differenza ancora più profonda, tra Pasolini e Sapienza. Il primo aveva una formazione borghese – il nonno era imparentato alla lontana con un nobile casato ravennate, il padre era un ufficiale delle forze armate; entrambi amanti del gioco d’azzardo, ridussero la famiglia sul lastrico –, una parte del suo odio sociale si rivoltava contro le proprie stesse radici. Per Sapienza la situazione è diversa.
“Goliarda Sapienza da bambina non va a scuola”, è la scritta che compare all’inizio del film di Martone, “c’è la dittatura, la istruiscono a casa i suoi fratelli e i suoi genitori, anarchici e antifascisti”. La madre era sindacalista. Il padre fu arrestato nel 1942 a Catania con l’accusa di aver guidato un gruppo di rivoltosi. L’anno successivo, uscito dal carcere, partecipò alla resistenza organizzando la Brigata Vespri a Roma. Sempre all’inizio del film leggiamo: “da ragazza si trasferisce a Roma. Lì farà l’attrice, lavorerà nel cinema, tenterà il suicidio, subirà sette elettroshock, coltiverà amori e furori in egual misura”.
Ciò che, pur tra queste differenze, accomuna Pasolini a Sapienza è la capacità semmai di trovare nei margini notizie anche sul centro (il quale è incapace di conoscere se stesso quanto più è feroce e saturo di potere). “Volevo solo, entrando qua”, scrive sempre ne L’università di Rebibbia, “tastare il polso del nostro Paese, sapere a che punto stanno le cose. Il carcere è sempre stato e sempre sarà la febbre che rivela la malattia del corpo sociale”.
Il carcere. Come l’ospedale. Come il manicomio.
Nel film di Martone, Goliarda Sapienza è interpretata da Valeria Golino. Matilda De Angelis interpreta Roberta. Elodie interpreta Barbara. Sono, queste ultime, due giovani detenute che Goliarda incontra in carcere, e che prende l’abitudine di vedere anche fuori. Le due ragazze, in particolare Roberta, diventano le uniche persone che Goliarda riesce a frequentare dopo la fine della detenzione senza sentirsi soffocare. Gli altri – i rappresentanti dell’ordine borghese, nonché di quello editoriale – sembrano adesso appartenere alla categoria dei morti o dei vampiri.
Roberta e Barbara potrebbero essere sue figlie. Tra le tre si instaura un rapporto magico, profondo, a volte aspro, travolgente sul piano emotivo, d’improvviso più leggero, di nuovo cruciale, un rapporto in cui il transfert madre-figlia non gioca un ruolo secondario.
Roberta fiancheggia la lotta armata, è anche un’eroinomane. Barbara, fuori dal carcere, sta provando a vivere in modo diverso (una profumeria a Torpignattara, seppure in società con un ricettatore), ma il richiamo dell’irregolarità si fa sentire ogni giorno.
Nel film, Martone fa muovere le tre amiche per Roma, una città sterminata e radiosa, un labirinto pieno di botole e meraviglie, trasmettendo allo spettatore un sentimento di libertà quasi straziante – fantasma vivo di ciò che è stata Roma per anni, una città spalancata, avventurosa, dispersiva, caotica e a suo modo protettiva.
Noi siamo vive voi siete morti, sembrano dire Goliarda, Roberta e Barbara a ogni respiro.
Naturalmente è Goliarda a doversi fare accettare dalle altre detenute. “Nun è che sei ’na spia?”, “Me pari una spiona”. È questo che, diffidenti, le dicono a brutto muso non appena se la vedono entrare a Rebibbia. In effetti lei è diversa da loro. Non è mai stata in carcere, è una scrittrice, per quanto di specie particolare. E poi ha solo rubacchiato due gioielli. All’università di Rebibbia le decane hanno cattedre ben più importanti, sono dentro per traffico internazionale di droga, omicidio, rapina, terrorismo, ricettazione. È Goliarda a dover lottare per rompere il muro di diffidenza. È pur vero che ha delle stranezze che lasciano basite le altre carcerate, un rapporto con la realtà al tempo stesso astratto e concretissimo, capace a volte di andare al punto delle questioni con una profondità, e una ferinità, che risultano spiazzanti perfino per chi ha fatto vita di strada.
Insomma, dopo un’iniziale resistenza le altre detenute le si avvicinano. Avevano avuto torto a diffidare di lei. Eppure, avevano ragione. Goliarda non è una spiona in senso classico, non ha rapporti con la polizia o con i servizi segreti, mai tradirebbe le nuove amiche. È tuttavia una scrittrice, il tradimento le scorre nel sangue, tutto ciò che le succede nella vita potrà finire un giorno, trasfigurato, sulla pagina.
“Sei un po’ strana”, concede una delle detenute, “è come se c’avessi una fissa… però non sei un’infame”.
Uno scrittore è una persona a cui sta a cuore tutto fuorché la letteratura. È una definizione, piuttosto celebre, di Elsa Morante. Potrebbe valere anche per Goliarda Sapienza, e in particolare per Fuori, un film che trabocca di quel tutto che è la vita con la scusa della letteratura.
“Il film alterna il durante e il dopo, con una scelta efficace di tempi alternati. Ci sono i giorni della detenzione. E ci sono i mesi successivi, quelli in cui Goliarda Sapienza usa, per misurare la pochezza del mondo esterno, l’unità di misura appresa in carcere”.
Questo di Martone è un film molto riuscito. L’arte della gioia di Valeria Golino è una serie molto riuscita. Goliarda Sapienza, negli ultimi tempi, si sta rivelando una benedizione per i registi cinematografici almeno quanto altri scrittori risultano al contrario refrattari (una per tutte, storicamente, la maledizione di Cervantes).
C’è un uso sapiente dei dialoghi (il modo in cui comunicano le detenute in carcere, il linguaggio che usano quando sono fuori, il lessico della strada e quello sentimentale; soprattutto – questo riesci a riprodurlo solo se quel mondo l’hai frequentato, l’hai compreso, dunque l’hai prima rispettato e almeno un po’ lo hai amato, a meno che non sia proprio il tuo contesto di provenienza – il modo in cui le ex detenute riescono a dirsi cose durissime e, subito dopo, a solidarizzare tra loro, a colpirsi al cuore senza restarne offese poiché, fuori dalla letteralità, ci sono migliaia di sottosignificati che condividono senza doverci neanche pensare, altrimenti che università sarebbe?) e una costruzione drammaturgica piena di buone idee (a inizio film vediamo una scena misteriosa che fatichiamo a comprendere, un sistema d’allarme suona a una mostra di gioielli – ma i gioielli Sapienza non li aveva rubati in casa della proprietaria?, ci domandiamo – e solo diverso tempo dopo, in un’altra scena, con un bel gioco a incastro, scopriamo che il gioielliere che ha acquistato in buona fede la refurtiva l’ha poi esposta a questa mostra dove, coincidenza incredibile, viene riconosciuta dalla domestica della derubata).
Quando vende i gioielli, Goliarda Sapienza usa un documento trafugato a una persona che conosce. È il passaporto di Modesta Maselli, sorella del suo ex compagno Citto, molto simile a lei fisicamente. La scrittrice firma il furto dei gioielli con il nome della protagonista de L’arte della gioia.
Fuori celebra l’amicizia femminile, la sorellanza diremmo oggi con un’espressione che credo non piacerebbe a Sapienza (la troverebbe di moda). Tuttavia Martone riesce a raccontare in maniera efficace, lasciandola sullo sfondo, anche la relazione tra Sapienza e Angelo Pellegrino, interpretato da Corrado Fortuna. È solo grazie alla perseveranza di quest’ultimo, alla sua ostinazione, al suo amore, alla sua capacità vedere la bellezza lì dove altri crederanno di ritrovarsi con un romanzo farraginoso, se L’arte della gioia verrà infine pubblicato.

Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie. Il lavoro delle attrici, e sulle attrici, è davvero notevole. È bravo anche Corrado Fortuna. E anche Antonio Gherardi (interpreta Albert, un losco figuro, a suo modo irresistibile, che se la fa con Roberta).
C’è un momento in cui Goliarda, Roberta e Barbara fanno la doccia insieme. È una delle scene di nudo più caste e soavi, tra le più delicate e sfuggenti che ricordo di aver visto al cinema negli ultimi tempi.
Dal palazzo di casa sua – un appartamento ai Parioli arioso e leggermente alla deriva, un’antiretorica perfino topografica, quella di Sapienza, solo i piccolo borghesi vivono nel senso di colpa, e solo i padroni cercano ovunque il dominio – Goliarda contempla nel pomeriggio le folte chiome di grandi alberi, simili a una tempesta verde, dolcemente agitata di fronte all’appartamento veliero.
Goliarda Sapienza abitava in via Denza. Dunque, ho pensato, saranno i pini e i cedri e i bagolari di villa Glori.
Sono molto suggestive le musiche originali di Valerio Vigliar. È bella la colonna sonora, con il Duke Ellington di In a Sentimental Mood, e più ancora Robert Wyatt che rifà Round Midnight, che esegue The British Road, nonché (chicca per dylaniani) Blues in Bob Minor mentre Goliarda e Roberta si aggirano in macchina nella notte romana.
Le ore del nostro presente sono già leggenda. Ogni volta che esce di galera, Roberta ha l’abitudine di andare a verificare se certe scritte sui muri ci sono ancora. Questa la ritrova sulla parte superiore del viadotto ferroviario in piazza di Porta Maggiore.
Fuori non parla solo dell’epoca di Goliarda Sapienza, non parla alla sua epoca. Mentre Goliarda, Roberta, Barbara vagabondano liberamente per Roma nel 1980, mettendo in gioco di continuo la loro esistenza e i loro affetti in modo sincero, c’è chi, prima e dopo aver visto questo film, nel 2025, trascorrerà il proprio tempo a litigare sui social, ad amareggiarsi per assolute stupidaggini, stritolato nella diceria, nel pettegolezzo, nell’ansia di posizionamento, nel credito sociale, nella recriminazione, nel risentimento, nell’invettiva misera. Il mondo su cui sputava allora Goliarda è il nostro mondo adesso.
L’intervista di Enzo Biagi a Goliarda Sapienza è un’apoteosi di paternalismo, e vista oggi risulta piuttosto odiosa. Viene inserita da Martone nei titoli di coda, una sorta di rivincita postuma.
“Qui è un posto dove ancora si scrivono lettere d’amore: fuori non si scrivono più, fuori non si riesce più ad amare né un uomo né una donna, non si riesce a essere più né una donna né un uomo, ma solo robot addetti alla produzione al successo al potere”.
Verso la fine del film, dopo un litigio acceso con Goliarda in un bar della stazione Termini, Roberta si rivolge rabbiosa agli avventori che osservano la scena: “che cazzo ve guardate? Nun c’avete una vita?”
È la domanda a cui gli spettatori di questo film temono di dover rispondere.
Le foto all’interno dell’articolo sono di Mario Spada che ringraziamo per la gentile concessione.