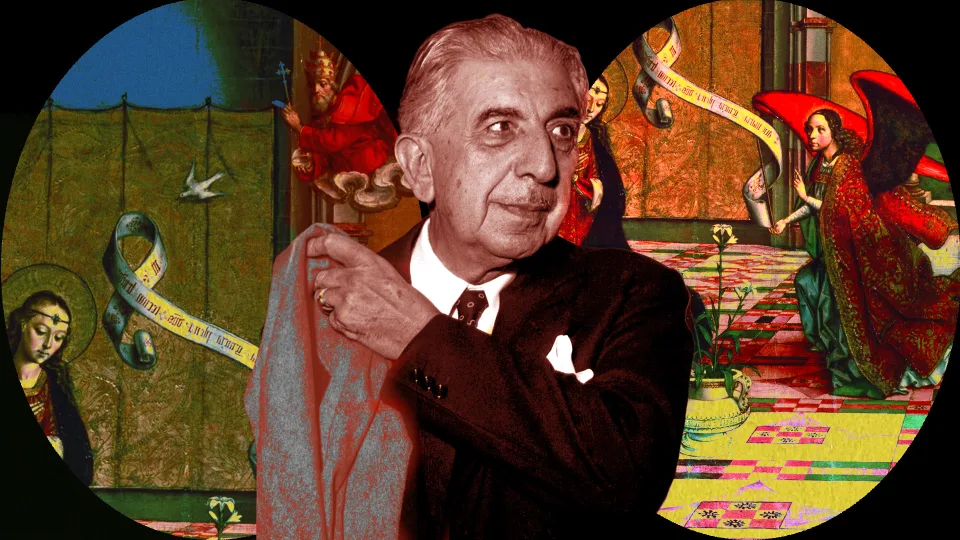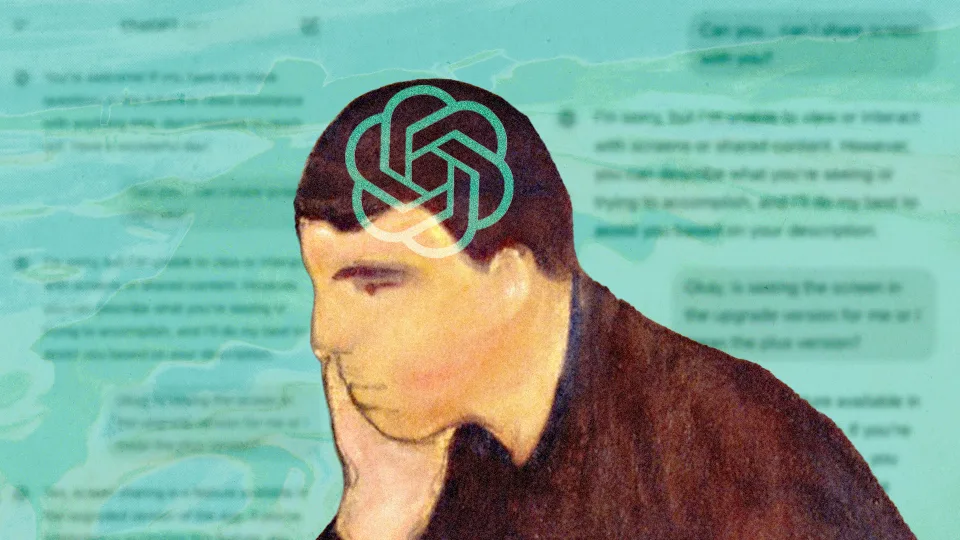Da qualche tempo pare che la letteratura delle donne consti di due sole possibilità: la riscoperta di grandi scrittrici del passato e il romance. Se nel primo caso il marketing sfrutta le intenzioni sincere e la passione di autrici giovani che esprimono gratitudine per coloro che le hanno precedute, nel secondo a venire sfruttata è la vulnerabilità delle donne alla narrazione che le vede sempre alla ricerca dell'amore maschile.
Qualche tempo fa ho pubblicato sempre qui, su Lucy, un dialogo intercorso con la scrittrice Claudia Durastanti in cui ragionavamo sui romanzi “difficili”, chiedendoci se fossimo ancora in grado di leggerli e apprezzarli. Durante la conversazione abbiamo sfiorato un tema che vale la pena approfondire, ovvero quella della “letteratura delle donne”. Uso le virgolette perché è un territorio dove facilmente si può generare l’equivoco. Premesso che è più che importante che questa letteratura emerga con forza, come avviene oggi, è anche molto facile che certe sue derive, seppur giuste negli intenti, siano poi fraintese nel risultato. Per esempio: come muoversi nella sacrosanta riscoperta delle scrittrici del Novecento, che da una parte ha il merito di riconoscere il valore di artiste e intellettuali sommerse dalla storia, ma dall’altra rischia di offuscare le artiste e intellettuali di oggi? L’interlocutrice ideale per rispondere a questa e altre domande è la scrittrice Giulia Caminito, che a questa riscoperta si dedica da molti anni.
Se c’è un fenomeno importante in ambito letterario riguarda l’attenzione, la cura, la gratitudine e infine la serietà con cui vengono riscoperte e riproposte le scrittrici del Novecento. Quasi esclusivamente, direi, da parte delle scrittrici più giovani. Penso al tuo omaggio contenuto in Amatissime, dove ritroviamo non solo Elsa Morante e Natalia Ginzburg, ma Paola Masino, Laudomia Bonanni, Livia De Stefani. Ed era un lavoro che avevi cominciato già da tempo. Penso, ancora, agli studi di Daniela Brogi su Anna Banti, a quelli di Nadia Terranova, e altre, su Alba De Cespedes. Penso all’ostinata e felice riscoperta di Marta Barone a proposito di Marina Jarre.
Secondo me non è mai stato abbastanza raccontata, questa attenzione: o forse non si comprende fino in fondo che si sta tessendo un’unica storia. E mi vengono in mente due affermazioni. È il 1970. In Mai devi domandarmi, Natalia Ginzburg scrive: “da tempo orfani, noi generiamo degli orfani, essendo stati incapaci di diventare noi stessi dei padri”. È il 1993. David Foster Wallace dice in un’intervista una cosa molto simile: abbiamo messo sottosopra la casa, come fanno i figli, e aspettiamo che i genitori tornino per sistemare le cose, ma ci rendiamo conto che non torneranno più. Il dramma della sua generazione, dice, è “e che noi dovremo essere i genitori.” Le scrittrici si ritrovano nella situazione, o meglio vogliono crearla? Essere madri delle madri di penna?
In qualche modo credo che come scrittrici di adesso noi sentiamo una forte responsabilità. Siamo in un periodo di visibilità e riscoperta delle voci femminili in Italia e nel resto del mondo per varie ragioni, anche economiche. Ma non basta la moda del momento, essere madri delle nostre madri vuol dire prendersene cura perché restino. Tutte noi siamo cresciute e siamo state educate in un mondo che non ci permetteva di accedere alla cultura delle donne, al pensiero e la letteratura, l’arte, la politica prodotta dalle donne perché per tradizione cattolica, per organizzazione scolastica, per sessualizzazione del linguaggio, le donne sono sempre state il resto, tutto quello che non è dato conoscere. E quando le abbiamo scoperte, in autonomia, coi nostri mezzi, attraverso le altre che ce le hanno fatte conoscere, ci siamo rese conto di essere sempre state derubate di una parte della nostra formazione, la parte che ci riguarda di più. E ci siamo anche rese conto che per quanto sia stato formativo e importantissimo il pensiero maschile su cui abbiamo studiato e abbiamo formato le nostre opinioni e i nostri gusti, c’è una connessione diversa che noi donne proviamo nel leggere altre donne, soprattutto quelle del passato. Questa connessione è preziosa, il sentirsi raccontate è prezioso e farsi carico della protezione di questa scoperta diventa una necessità. Difendiamo come scrittrici il nostro diritto alla genealogia politica e letteraria e al riconoscimento delle nostre madri. Ma che fare per non vederle scomparire di nuovo e per permettere ai giovani di adesso e di domani di continuare a leggerle e a indagarle? I nostri sono tentativi per evitare il ritorno dell’oblio e continuare a spingere queste scrittrici in avanti.
Nei fatti, quello che sta avvenendo è qualcosa di più di un omaggio formale. Non è quello che fa Stephen King con Shirley Jackson, che considera la sua maestra e non solo ne scrive nei suoi saggi sulla letteratura, ma le dedica un romanzo (L’incendiaria) e inserisce una Jackson street a Derry, in It. È un cercare punti in comune da poter raccontare ancora oggi, un tipo di sguardo che non è necessariamente legato a un’epoca, ma persiste nelle scrittrici. Ricordare quello che è stato dimenticato (quelle che sono state dimenticate, soprattutto) non è solo generosità: è un impegno che include l’atto della scrittura e della lettura. Che, incredibilmente, a volte si considerano come separati. In quali forme, secondo te?
Si parte sostanzialmente dalla lettura, che non è così scontata rispetto a molte scrittrici del passato, perché in effetti trovarle per leggerle può essere ancora faticoso. Quando dieci anni fa ho iniziato a leggerle ce ne erano davvero pochissime disponibili, i libri non si trovavano se non in alcune biblioteche o nei mercatini per l’usato. Trovarle vuol dire leggerle, interrogarle, farsi poi delle domande su chi erano, perché scrivevano. Nasce in maniera molto spontanea questa curiosità di conoscere anche la loro vita, perché l’essere donne e aver vissuto da donne le ha penalizzate, non si può affrontare la loro lettura senza tener presente questa specificità. Ma chiaramente leggerle non vuole dire elogiarle in toto, ma anzi inserire la loro produzione in un apparato critico, capire quali di loro avevano più polso sulla realtà, quali avevano una scrittura ricercata, quali hanno avuto ottime idee per alcuni libri o hanno fatto scelte meno brillanti per altre: insomma studiarle e studiarsi la critica femminista su di loro, per inquadrarle. Poi credo vada da sé, una volta che sono diventate parte del nostro bagaglio, includerle nella scrittura, nel nostro vocabolario, ispirarsi a loro, citarle, renderle vive nella letteratura di oggi. Stiamo vedendo molte biografie di scrittrici in libreria, ricostruzioni sulla loro esistenza ibridate anche nella forma romanzo o come, nel caso di Amatissime, mescolate all’autobiografia, ma loro sono presenti in forme meno appariscente in tanta scrittura contemporanea come riferimenti e come ganci letterari. Più questa influenza viene tenuta viva, più le scrittrici continueranno a esserci, a stare nei libri, sui libri, accanto a chi legge e chi scrive.
Nella conversazione sul romanzo difficile che ho avuto con Claudia Durastanti, Claudia fa un’affermazione su cui vale la pena riflettere. Questa: “Però oggi l’autocritica è fondamentale, anche verso le operazioni editoriali dedicate alle scrittrici del Novecento: che godimento può scaturire ancora da questo scavo filologico se non viene accompagnato da un sostegno verso le scrittrici del presente, magari non esordienti, magari al quarto, quinto libro, che continuano a fare ricerca o a produrre libri originali ma non sempre trovano il sostegno di un reparto editoriale lungimirante perché non sono morte né si sono consegnate al romance? Se penso al prezioso Amatissime di Giulia Caminito, di cui è appena un’edizione aggiornata e fa il paio con un classico come Le signore della scrittura di Sandra Petrignani, non posso fare a meno di chiedermi chi saranno le scrittrici che popoleranno pagine simili tra vent’anni. Scrittrici diverse come Elisa Casseri, Ginevra Lamberti, Emmanuela Carbé e Laura Marzi, che spaziano dal romanzo alla saggistica e intersecano prosa e teoria portando avanti una loro linea, un loro modo di interrogare la loro letteratura. Gli spazi per questo tipo di attenzione si stanno riducendo, e siamo nella situazione paradossale per cui De Cespedes, Cialente e Banti ci sembrano freschissime mentre le nostre contemporanee in classifica ci sembrano delle antenate polverose e addirittura deleterie; ci muoviamo tra le autrici da disseppellire e quelle nate già vecchie, in una prospettiva sballata in cui a dominare è comunque il passato”.
Cosa ne pensi? C’è un rischio che ancora non vediamo?
Io sono molto d’accordo con Claudia. Se da una parte la moda editoriale del periodo ha il merito di aver riportato in libreria tante scrittrici che, come dicevo prima, dieci anni fa erano introvabili, dall’altra ci rendiamo ben conto che se le ragioni del loro ritorno sono esclusivamente di marketing siamo comunque destinate a perdere. Le ragioni del recupero devono essere letterarie, non importa infilare in catalogo una scrittrice del Novecento o un libro su una di loro, se non viene fatto perché questi testi vengono riconosciuti come letterariamente di valore e utili al dibattito critico. La disputa sul rapporto tra valore/guadagno oggi è centrale. Fino anche solo a 5 anni fa i grandi editori si giustificavano per la pubblicazione di influencer e personaggi tv dicendo che con i soldi guadagnati da loro e dalla loro popolarità avrebbero finanziato le collane di poesia o la produzione più di nicchia. Oggi non è già più così. Si chiede a scrittori e scrittrici di essere comprensibili, attraversabili e ben riconoscibili, si chiede di essere letterari ma non troppo, nuovi ma non troppo, brillanti ma non troppo perché bisogna rientrare dell’investimento che l’editore ha fatto su di te. Bisogna vendere per non soccombere. E certo non possiamo ignorare le vendite, gli editori piccoli o grandi non possono permettersi di ignorare la parte marketing. Ma siamo sicure che affollare le librerie di instant book e narrativa di consumo sia il modo giusto per far leggere al pubblico più libri? Siamo sicure che pubblicare dieci, venti, trenta libri come “La portalettere” sia un modo per sostenere la scrittura delle donne? O è più vero il contrario, che oggi ancora si pensa alle scrittrici come quelle che devono occuparsi solo di alcuni generi di narrativa e non pretendere di allargarsi verso la sperimentazione o la sottrazione da alcuni argomenti vendibili? Anche a me in primis è stato chiesto di riprodurre o avvicinarmi il più possibile a un mio libro che aveva venduto. Come a dire che se L’acqua del lago non è mai dolce ha venduto molto io ho in me sempre il potenziale di produrre libri da vendere, ma non è così. Io non ho idea quando scrivo di cosa possa vendere e non posso riprodurre l’effetto che quel libro ha avuto sul pubblico, perché non scrivo seguendo delle tendenze, ma scrivo e basta. E da quando il compito dell’editore non è più riuscire a far arrivare al pubblico un buon libro, piuttosto che chiedere a chi scrive di scrivere libri che vendano? Le scrittrici di oggi che più si stanno discostando, anche come reazione al mercato, dal modello mainstream di scrittura femminile, sono tra le più penalizzate dagli editori e dalla sovrapproduzione. Tra noi scrittrici lo sappiamo bene.
Uno dei rischi che vedo io, per esempio, è il rivenir sospinte all’indietro. Conosci, credo, i dati che vengono dagli Stati Uniti e che riguardano l’abbandono del lavoro da parte delle donne per impossibilità di sostenere i costi della cura di un figlio o di una figlia. Se la letteratura (o meglio, il mercato editoriale) è figlio del tempo, a volte guardo con preoccupazione all’affermazione incontrastabile del romance o delle saghe al femminile ambientate nel Novecento. Senza nulla togliere alla qualità dei singoli libri, evidentemente, ma mi sembra che si possa correre il rischio di incasellare (nuovamente!) la scrittura delle donne. Ricorderai un articolo dove si definiva “romance” la maggior parte della produzione delle scrittrici italiane. In quell’articolo, apparso su «Doppiozero», si diceva: “La differenza tra autori e autrici è in ciò, che i primi frequentano più generi, perlopiù il thriller, mentre le seconde si sono ancorate a uno solo: appunto il romance”. E ancora: “Ma mai il romance si snatura lasciando il posto al più realistico novel, l’altro côté del modello narrativo moderno, di tradizione anglosassone e non spagnola come il primo, molto più caro al pubblico maschile, più frequentato dagli autori, tuttavia oggi in secondo piano per via della invalente supremazia della donna scrittrice e lettrice.” Sappiamo che non è così. Ma sappiamo anche che questa convinzione è ancora diffusa. E che complica ulteriormente la questione posta da Claudia: cosa non si vede, ancora, di quel che oggi scrivono le donne?
Questa convinzione è ahimé molto più diffusa di quello che sembra, anche tra i nostri colleghi scrittori. La storia letteraria del genere romantico è molto più complessa di così, e ci sono state tante scrittrici che al di fuori di quel genere si sono interrogate sul sentimento d’amore e sul suo peso in termini di riconoscimento per le donne. L’isola di Arturo di Elsa Morante è in apparenza la cosa più lontana da un romance che ci possa venire in mente, ma in realtà quello che indaga Morante è l’amare e il non essere amati. Arturo è il più disamato, il meno riconosciuto, tanto che non è figlio e non è amante, ma sempre qualcosa di diverso e inafferrabile. Mentre nel genere romance si tenta sempre di soddisfare questo vuoto d’amore, di trasformare la realtà e piegarla alla conquista anche del peggior uomo sulla faccia della terra, in Arturo Morante ci dice che a vincere purtroppo è il crudele disamore, è il non essere amate. Le donne di Morante sono trattate sempre malamente, considerate come stracci, lasciate chiuse nelle case, impossibilitate alla vita, costrette al matrimonio, al sesso e alle grida, e a dirlo è una scrittrice. La potenza di questo messaggio che passa dalla voce e dalla prospettiva di un giovane uomo è il lato opposto, ma anche connesso, del mondo del romance. Il romance nasce come desiderio soprattutto per molte donne di essere amate. Scoprire che anche la più sciatta, povera, disillusa donna di una storia può ambire a essere amata, a essere unica, a essere viva è la grande bugia del romance, su cui si sono formate generazioni intere di ragazze. Quando è sul disamore che le donne devono giocare la loro battaglia politica: esistere e confermarsi a prescindere dall’essere amate da un uomo. Chi riduce tutto questo a un mero giochetto editoriale dimostra la propria ignoranza e il proprio sguardo gretto.
Concludevo la chiacchierata con Claudia riflettendo proprio sul mercato editoriale: cosa stiamo sbagliando? Come si esce dalla prevalenza di pochi filoni di successo su tutto il resto?
Non ho una risposta sicura, di certo penso che continuare ad aumentare i titoli in libreria non sia il modo. Continuare e gettare in promozione centinaia e centinaia di libri non sta aiutando nessuno. I tempi sono diventati sempre più brevi, si scrive in meno tempo, si pubblica in meno tempo, si sta in libreria meno tempo. Dov’è finito il tempo debito? Possibile che noi come scrittrici e scrittori ma anche come editori ed editrici non possiamo fermare questo flusso continuo? La responsabilità è di tutti, ma ogni parte attacca un’altra parte. Eppure, ci sono case editrici nate da pochissimo che già pubblicano 40 libri l’anno, un numero altissimo. Credo serva una diminuzione di quei numeri, un aumento della produzione digitale, una diminuzione delle presentazioni senza compenso e un ragionamento concreto sulla sostenibilità dell’editoria di oggi che però poi porti a una messa in pratica. Certo, avere il governo che abbiamo non sta aiutando in nessun senso la cultura che già di suo è un settore povero, agonizzante e precario.