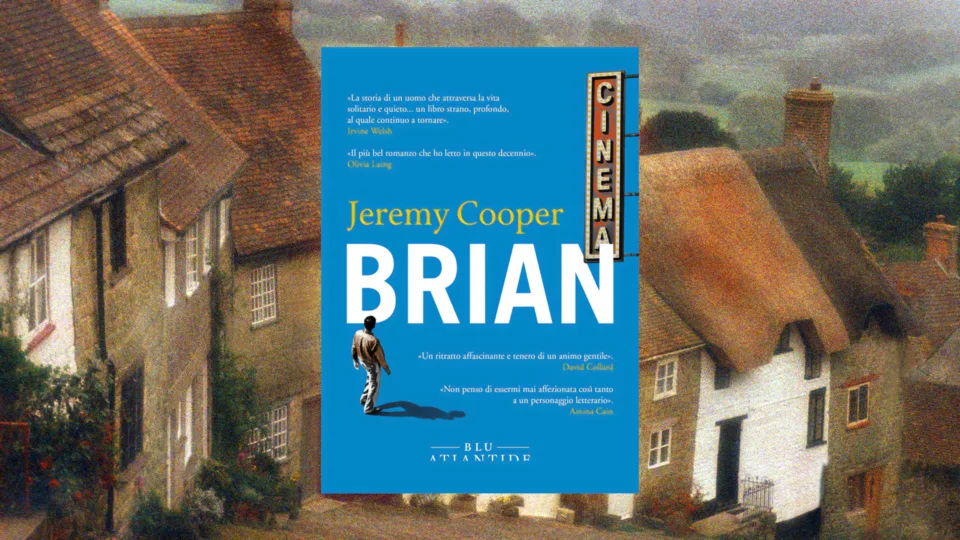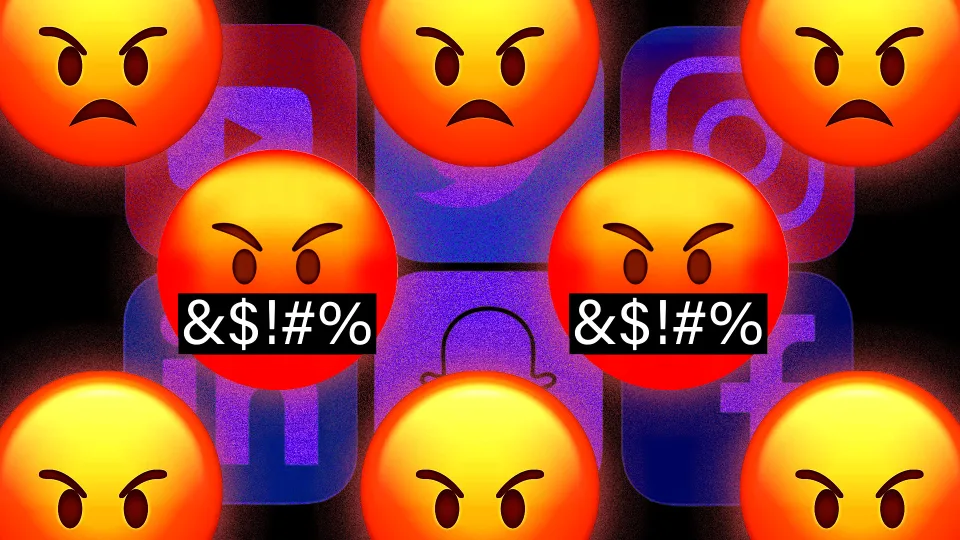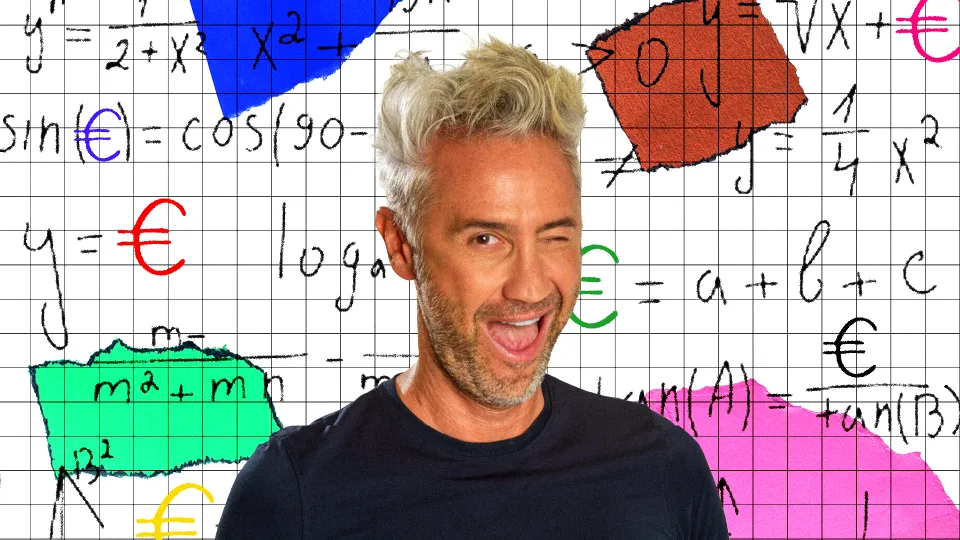Ritratto di e dialogo con uno scrittore solitario ed elusivo che attraverso il suo ultimo romanzo racconta la vita ordinaria di un uomo solo.
Ci sono tante cose comuni nella vita di Jeremy Cooper – una collezione di cartoline, un’infanzia infelice, un divorzio, il ritiro in campagna – ma più numerose sono quelle straordinarie per la loro assenza: Cooper non ha mai visto un film sullo schermo di un computer, non possiede un cellulare, non prende aerei, non compra online, non è sui social media e negli ultimi venticinque anni non ha mai guardato la televisione. Conduce una vita isolata, non partecipa a eventi sociali né ai festival letterari e quindi ha un sacco di tempo a disposizione, che dedica esclusivamente alla scrittura.
È nato nel 1947, si è laureato in storia dell’arte a Cambridge e il suo primo lavoro è stato presso la casa d’aste Sotheby, dove catalogava sculture e mobili del XIX secolo. Ha partecipato a molti episodi di Antiques Roadshow, il reality della BBC dedicato alle fiere dell’antiquariato; ha presentato The Week’s Antiques per Radio 4 ed è autore di vari saggi di storia dell’arte, tra cui Artists’ Postcards: A Compendium in cui, a partire dalla sua collezione personale, racconta la fascinazione di molti artisti per le cartoline, dai surrealisti a Fluxus e all’arte concettuale (dal 1984, Cooper acquista cartoline d’arte in duplice copia: una la tiene con sé, l’altra la conserva al sicuro).
Da quando ha lasciato Londra nel 2000, vive in un cottage del XVII secolo nella campagna del Somerset. Tutti i giorni della sua vita sono identici, senza domeniche e festività. Nel suo mondo non esiste il Natale. Cooper segue una routine quotidiana precisa: si sveglia alle sei e mezzo, rimane a letto a leggere per un’oretta (un romanzo contemporaneo), poi si rade, si veste e scende in cucina a bere un succo di mela, quindi esce per una chiacchierata con Moses e Clarence, due montoni ormai adulti che ha allattato con il biberon perché erano rimasti orfani alla nascita. Si dedica al giardino e al frutteto e, dopo aver fatto colazione, va a scrivere nel suo studio, un ex granaio che lui stesso ha ristrutturato. Alle undici si fa un caffè, lo beve all’aperto mentre legge la corrispondenza consegnata dal postino. Torna a scrivere, all’una pranza mentre ascolta le notizie su Radio 4, poi lavora ancora un po’ in giardino e nel pomeriggio scrive fino alle sette, quando si prepara la cena. Tutto il cibo che consuma è prodotto localmente. Mentre lava i piatti, ascolta Front Row, il magazine di Radio 4 sull’arte, la letteratura, la musica e i media, poi torna alla scrivania per sbrigare questioni pratiche (cataloga, scrive alla sorella che vive nell’altro emisfero, prende appunti da pubblicazioni di storia dell’arte). Alle dieci è a letto, ascolta le ultime notizie dalla radio e legge qualche altra pagina del romanzo che ha sul comodino prima di addormentarsi.
Per semplificarsi ulteriormente la vita, i suoi abiti sono di materiali, stili e colori che li rendono facilmente abbinabili tra loro. Nelle foto pubblicate dall’«Observer» nel 2024 in occasione dell’uscita di Brian (il suo settimo romanzo, da poco pubblicato in italiano da Edizioni di Atlantide con la traduzione di Ilaria Oddenino), è un signore di 77 anni dalla fronte alta, i capelli bianchi tagliati corti per praticità; indossa una giacca color lavanda come la camicia e un gilet blu, è seduto su una vecchia panchina di legno che probabilmente ha costruito lui stesso. Alle sue spalle i fiori di salvia riprendono i colori dei suoi vestiti in una tonalità appena più accesa. Sembrano lucine naturali che illuminano quel ritratto bucolico. Cooper tiene le mani conserte, guarda l’obiettivo eppure è elusivo, impenetrabile nonostante il viso aperto, i lineamenti regolari, gli occhi chiari rimpiccioliti dall’età. È un’immagine incredibilmente armoniosa.
Ogni due settimane lascia la campagna del Somerset per andare qualche giorno a Londra per “vedere, ascoltare e guardare nuove cose creative”. Non avendo uno smartphone né la televisione, non ha mai usato Facebook, TikTok, Netflix, YouTube, Twitter. Questo gli conferisce un particolare tipo di verginità. Per la nostra intervista rifiuta una videochiamata e sceglie di comunicare via email.
Per molti aspetti, Jeremy Cooper è simile a Brian, il protagonista del romanzo acclamato da Irvine Welsh (“Un’opera d’arte davvero profonda, una conferma del nostro essere umani”) e da Olivia Laing (“Il più bel romanzo che ho letto in questo decennio”), da cui Zadie Smith e il marito Nick Laird hanno tratto una sceneggiatura. Sullo schermo Brian avrà il volto di Daniel Craig.
Il protagonista è un impiegato comunale di mezza età, di origini irlandesi, solitario, ossessivo compulsivo, per il quale la vita quotidiana è una sfida incessante. Quando inizia la storia, la sua giovinezza appartiene già al passato, “un’epoca che Brian si era lasciato alle spalle senza mai riuscire a trovare un posto alternativo in cui sentirsi a proprio agio”. Brian ha bisogno di programmare nei minimi dettagli le sue giornate, di anticipare le mosse del futuro per non avere sorprese. Rimugina su tutte le possibili conseguenze di ogni singolo gesto e ne soppesa con precisione costi e benefici. Per lui posizionarsi nel vagone sbagliato della metro rispetto all’uscita e dover rifare il percorso all’inverso quando scende è “un vergognoso errore di valutazione”.
Dopo aver vissuto in un ostello, da dove viene espulso per limiti di età, e in una serie di camere in affitto in varie zone di Londra, si è sistemato in un minuscolo appartamento a Kentish Town, sopra al ristorante Taj Mahal. Le sue giornate si svolgono, come quelle di Cooper, secondo quella routine che appare confortante sulle pagine di un romanzo – penso ai personaggi di Banana Yoshimoto e di Haruki Murakami, e perfino all’ibernazione narcotica della protagonista di Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh – ma che nella vita reale risulta intollerabile.
Tutti i giorni Brian pranza in un ristorante italiano, la sua unica fonte di socialità e di informazioni sul mondo. In ufficio rifiuta qualsiasi interazione con i colleghi, rifiutandosi perfino di rivelare la data di nascita per sottrarsi ai festeggiamenti di rito. I suoi precedenti tentativi di integrazione con un club di lettura e con il calcio sono falliti miseramente e per un po’ si rassegna a passare le serate davanti alla tv mangiando biscotti al cioccolato.
Finché un giorno non va al British Film Institute a Southbank a vedere Il texano dagli occhi di ghiaccio di Clint Eastwood. Nei momenti più stressanti della giornata si ripete una battuta del film – “Non è difficile stargli dietro. Semina morti sul suo cammino” – perché lo fa stare meglio. Dopo estenuanti riflessioni, a quasi quarant’anni decide di diventare membro del BFI e prenota due proiezioni al mese che gradualmente si intensificano fino a diventare quotidiane finché, quando va in pensione, vede due film al giorno tutti i giorni.
Essendo un sopravvissuto (nel romanzo si accenna a un trauma familiare legato al conflitto nordirlandese), è in grado di riconoscere alcuni sintomi allarmanti:
“C’erano i pensieri cupi che avevano cominciato ad attanagliarlo nelle sere che trascorreva da solo in casa, dove ormai aveva persino smesso di prepararsi un pasto caldo. Troppo spesso, poi, non ricordava nulla delle ore che passava di fronte alla TV, non riuscendo quindi a partecipare, il giorno successivo, alle chiacchiere sui programmi serali durante la pausa caffè. Aveva anche smesso di leggere, cosa ancor più preoccupante, e gli era esploso un eczema sui gomiti e dietro le ginocchia”.
“La solitudine cronica non solo ci rende disperati, ma può anche farci ammalare”, scrive il neuroscienziato John Cacioppo. “Le persone sole provano sensazioni più intense di impotenza e di minaccia che aggravano le difficoltà e lo stress della vita quotidiana”. La solitudine di Brian rende più acuti i suoi comportamenti ossessivi compulsivi e le sue ansie. La frequentazione del BFI è un salvavita, l’argine che frena la progressiva degenerazione. Diventando un buff, un esperto maniacale, viene accettato in un gruppo di simili, gli habitué che a fine proiezione fanno capannello per commentare il film appena visto. Nel romanzo assistiamo anche al lento e cauto sviluppo di un’amicizia con un’altra figura solitaria e reietta.
Come personaggio letterario, ricorda – più che William Stoner di John Williams – Bartleby Lo Scrivano di Melville per il suo “preferirei di no”, o un Walden in versione urbana per lo stile di vita ascetico: Brian resiste a qualsiasi tentazione consumistica, le uniche gratificazioni che si concede, oltre al BFI, sono l’acquisto di cartoline di vecchie sale cinematografiche e di libri sul cinema. Del resto, Bartleby e Walden sono figure paragonabili allo stesso Jeremy Cooper, con i suoi rifiuti elencati in lunghe liste joyciane (“no parties, no funerals, no holidays, no birthdays, no reunions, no alcohol, no golf…”, scrive nel saggio Solitude del 2020) a cui corrisponde uno stile di vita a impatto ambientale ridotto (abiti in tessuti naturali, detergenti ecologici, niente pesticidi né diserbanti in giardino).
Brian tiene a bada la disperazione andando al cinema, Cooper scrivendo.
Nelle 190 pagine del romanzo si dispiega l’intera storia della settima arte: da La nascita di una nazione di D. W. Griffith a Ingmar Bergman, al cinema giapponese postbellico, al regista turco Yilmaz Güney, Fassbinder, Herzog, Kiarostami e decine di altri. Sono 166 i film citati, di questi un paio sono inventati e, dato che Cooper non si considera un buff, lo sono anche alcuni dettagli da cinefili: “A volte nei miei saggi e romanzi commetto consapevolmente errori fattuali, racconto storie che non sono del tutto vere”, dice. “È un avvertimento subliminale ai lettori affinché non credano a tutto ciò che leggono, anche quando è pubblicato da uno come me, uno scrittore critico nei confronti delle favole e delle esagerazioni nel mondo della letteratura”.
Al cinema Brian si sente al sicuro, protetto da una rete affettiva: “Avendo tagliato da decenni qualsiasi rapporto con la famiglia, Brian aveva trasferito il suo attaccamento emotivo ad alcuni registi, di cui piangeva le morti”. I film gli offrono identità più interessanti della sua “piccola vita”: come uno Zelig, diventa il lustrascarpe di Un uomo da marciapiede, il cuoco di Babette, il Cherokee silenzioso di Qualcuno volò sul nido del cuculo, un gangster dopo Mean Streets. Il cinema è una pratica di mindfulness – “Brian tendeva a esperire i film nel momento in cui li guardava, per ciò che significavano per lui nel qui e ora, indipendentemente da dove fossero stati realizzati o ambientati, o da quanto fossero accurati nelle loro pretese” – e uno strumento di conoscenza, permettendogli di fuggire dal mondo e al tempo stesso di conoscerlo.
Però Brian ha un lavoro stabile, l’assistenza sanitaria e una pensione, tutte cose che oggi per molti sono un lusso. Se negli anni ’80 e ’90 è un emarginato, oggi sarebbe un privilegiato, anche se forse non potrebbe più permettersi il piccolo appartamento a Kentish Town e dovrebbe trasferirsi fuori Londra, rendendo così più difficile la frequentazione del BFI. Non vota, ma essendo diventato un cinefilo le sue inclinazioni politiche si sono spostate a sinistra, ed è asessuale: “Sebbene fosse certo di non avere intenzione di fare sesso, mai, con nessuno, era pronto ad ammettere privatamente che, nell’eventualità, poteva essere con un uomo come con una donna”. Se costretto sotto minaccia di morte, il sesso di gruppo è per lui l’opzione meno tremenda: “Le prodezze di Salò di Pasolini sembravano piuttosto divertenti”.
Le questioni esistenziali e l’attualità divampano nel racconto delle gesta di questo personaggio scialbo, triste, a cui non presteremmo attenzione se lo incontrassimo per strada o in una sala cinematografica. Anzi, forse cercheremmo di sederci a distanza da lui. Brian è un bildungsroman cinematografico? Il protagonista è un potenziale psicopatico salvato dal BFI? Brian c’est moi? Cooper, perché ha lasciato Londra? Come passa le giornate quando ci torna? Delle circa venti domande che gli invio per email, lo scrittore sceglie di rispondere solo a tre. Una è sul cinema italiano. È facile capire perché Fellini sia “problematico” per Brian e gli provochi un “disagio diffuso” e prolungato, dovuto alla “allegria ostinata con cui il regista amava sovvertire le convenzioni”. Ci sono De Sica con Ladri di biciclette e Sergio Leone con C’era una volta in America, ma mancano Antonioni e Pasolini. Dato che il romanzo nasce dalla sua frequentazione del BFI, anche questo riflette i suoi gusti personali? “La scelta dei film visti da Brian è piuttosto arbitraria e si basa sulle schede informative del BFI di tutti i film che ho visto dal 1985 al 2015”, risponde. “Sicuramente c’erano anche loro. Viaggio in Italia di Rossellini è citato nel libro ed è stato proiettato al BFI dopo una chiacchierata sul romanzo tra me e il regista Ben Rivers sul palco della sala NFT1 e un reading di Toby Jones. Brian ha un interesse particolare per il cinema giapponese, che rispecchia il mio”.
La seconda è una questione formale: il romanzo è privo di capitoli. Chi legge a volte sente il bisogno di una conclusione momentanea – finire un capitolo prima di spegnere la luce o mettersi a fare altro – così, a proposito di compulsioni, mi sono trovata a identificare alcuni punti in cui un capitolo potrebbe finire e un altro iniziare. La narrazione continua, senza neanche una mezza pagina vuota, rende l’idea della vita come flusso ininterrotto e di quanto trascorra velocemente: nasci, guardi una quantità smodata di film e muori. Cosa dice in proposito l’autore? “Senza voler attirare l’attenzione sullo stile né sulla struttura di ciò che scrivo, tendo a evitare il convenzionale. Bolt from the Blue, il romanzo precedente, è scritto sotto forma di corrispondenza tra un’artista e sua madre; il prossimo, Discord, racconta gli incontri tra due donne visti in modo diverso da ciascuna di loro, con gli stessi titoli dei capitoli (‘1’ e ‘2’). Brian è composto senza divisioni per illustrare fisicamente l’uniformità del tempo per un personaggio come lui, la monotonia della vita con appena qualche interruzione occasionale, come il pensionamento, subito superata da un leggero cambiamento nel rituale”.
“‘Brian’ è un ‘bildungsroman’ cinematografico? Il protagonista è un potenziale psicopatico salvato dal BFI? ‘Brian c’est moi?’ Cooper, perché ha lasciato Londra? Come passa le giornate quando ci torna? Delle circa venti domande che gli invio per email, lo scrittore sceglie di rispondere solo a tre”.
La terza risposta riguarda la città dove si svolge gran parte del romanzo. Leggere Brian è come tornare a Londra e rivedere alcuni luoghi emblematici. Molti anni fa, sono stata ospite di un amico che a Camden viveva nell’appartamento accanto all’enorme stivale della Dr Martens. Brian, vivendo a Kentish Town, ci passa sicuramente davanti. Un’altra volta ho intervistato un musicista da Gaby’s, il celebre deli di Charing Cross dove nel romanzo Brian si ferma a prendere un tè e una torta di mele. Tra i suoi clienti c’erano Charlie Chaplin, Jeremy Corbyn, Mike Leigh, Vanessa Redgrave che ordinavano hummus, falafel, tahini, gulash. Lo stivaletto punk e la rosticceria mediorientale sono scomparsi da tempo e il libro parla anche di una Londra che non c’è più. Come ha scelto i luoghi? “Tutti i miei libri, di narrativa e di saggistica, parlano di cose, luoghi e persone che conosco, senza bisogno di fare ricerche particolari”, risponde Cooper. “Ho vissuto e lavorato a Londra dal 1969 al 2000, ero attratto dai caffè più che dai ristoranti ed è di questi che scrivo. Alcuni, come Gaby’s, hanno chiuso i battenti, ma altri, come Mario’s, il modello per Il Castelletto in Brian, e Scotti’s, a cui è ispirato il Frank’s di Discord – due caffè italiani di terza generazione – sono immutati da decenni nell’arredamento e nel servizio, sono ancora in piena attività e ci vado spesso a fare colazione. All’età di ottant’anni, le esperienze che ricordo sono immerse nel passato, ma vedo, leggo e ascolto opere contemporanee e scrivo principalmente del presente, in particolare nel nuovo romanzo Discord, ambientato nel 2023, in cui uno dei due personaggi principali è una sassofonista di ventinove anni”.
Riguardo le altre domande, Cooper confessa di avere due problemi: “La sensazione che spetti al lettore decidere di che parlano i miei romanzi e una crescente riluttanza a parlare delle mie motivazioni e dei miei pensieri riguardo alla scrittura, o qualsiasi altra cosa”. In fondo all’email, però, allega un saggio inedito che mi autorizza a citare. Il saggio si intitola Nothing to add, niente da aggiungere. Con il timore di avergli posto delle domande indiscrete, comincio a leggere il documento che riporto quasi nella sua interezza: “Pur essendo essenzialmente soddisfatto di vivere in un relativo isolamento sociale, mi sforzo di scrivere per essere letto, con l’obiettivo di pubblicare le mie opere che, mi auguro, abbiano per gli altri lo stesso significato che hanno per me, anche se in modo diverso. Se il loro valore non è riconosciuto dai lettori, i libri non sono nulla. Con la personalità di un gatto, attratto dal fare la stessa cosa alla stessa ora giorno dopo giorno, anno dopo anno, ho imparato lentamente a scrivere, trovando finalmente sulla pagina una voce che sento mia. Con sette romanzi pubblicati fino ad oggi, un altro già accettato da Fitzcarraldo e il prossimo dal titolo provvisorio di Beating the Bounds, di cui ho scritto tredicimila parole, sento di potermi definire uno scrittore.
Qualunque sia la domanda posta su un’opera di narrativa rispettabile, la risposta più utile da parte degli scrittori è che non hanno niente da aggiungere, che il testo pubblicato dall’inizio alla fine è l’unica e sola risposta. I romanzi sono esattamente ciò che ogni singolo lettore percepisce, non esistono reazioni giuste o sbagliate, interpretazioni corrette, parole migliori o più significative di quelle riportate sulla pagina. La romanziera e poetessa Esther Kinsky esprime un punto di vista simile: ‘È inutile aspettarsi che uno scrittore analizzi retrospettivamente un impulso che, nella sua totale inspiegabilità, costituisce l’energia alla base di qualsiasi creazione artistica’.
Per favore, leggete il mio libro è tutto ciò che un autore ha bisogno di dire. Lo scopo di un romanzo è di essere letto, tenuto tra le mani e assorbito lentamente, dal punto di vista emotivo e intellettuale […] Il motivo per cui alcuni autori sentono il bisogno di spiegare in pubblico se stessi e la loro scrittura può dipendere da una questione di controllo, dal desiderio di vedere anni di lavoro dedicati a un libro accolti come loro vorrebbero. È un tentativo destinato a fallire. Che le cose accadano o meno, il senso di potere e responsabilità dello scrittore va indirizzato all’azione vera e propria, alla creazione del testo, lasciandone la ricezione al lettore. Avendo bisogno, per ragioni personali e per esperienza, di vivere in solitudine appartata, rifiuto di partecipare al circo pubblicitario e mi affido invece a un commento di Janet Frame nel romanzo The Edge of the Alphabet del 1962: ‘Il linguaggio ci proteggerà dall’assalto dell’umanità’”.
Cooper cita anche un passaggio da Così ha inizio il male di Javier Marías, un commento poetico su Brian e sulle fragilità e debolezze che condividiamo con lui. Anche noi siamo quegli “esseri che sembrano camminare in punta di piedi per il mondo e trovarsi di passaggio per la vita o averla ricevuta solo in prestito […] alcuni di loro più che altro tendono a nascondersi e hanno in serbo storie più curiose o interessanti, più civili, più nitide, di quelle dei tanti urlatori esibizionisti che invadono e assordano gran parte del globo e lo estenuano con il loro agitarsi”.
Che ne siamo consapevoli o no, Brian c’est nous.