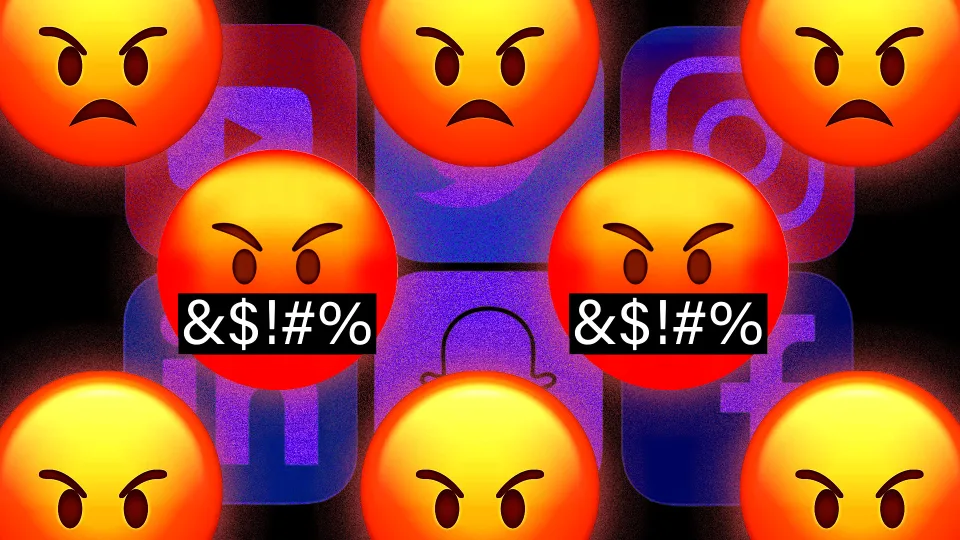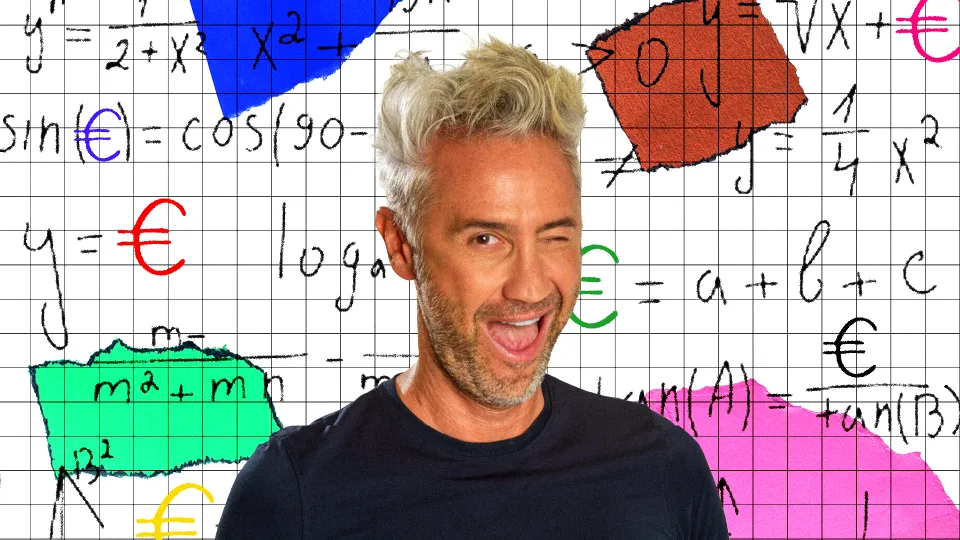Tra romanzi, scandali e inimicizie sfavillanti, Vidal fece della lucidità un’arma artistica e politica. Oggi, a cent’anni dalla nascita, e nell’era dell’empatia obbligatoria, non avrebbe avuto spazio.
“Ogni volta che un amico ha successo, io muoio un po’”. Un’affermazione del genere, oggi, sarebbe impensabile. L’era della confessione pretende empatia e consenso, e noi, sfessati millennial, siamo stati educati alla gentilezza — salvo poi sfogare l’odio nelle chat private, protetti dall’anonimato. Forse è per questo che l’autore della frase in apertura e di altri aforismi, Gore Vidal, non interessa più come un tempo. Per quanto fosse un provocatore, non credo sarebbe stato disposto a sacrificarsi, come accade oggi, alla macchina dell’odio, e ad alimentare un flusso polarizzato di screditamenti e di engagement (un’impresa disumana, dove il confronto è scomparso ma lo scontro, per chi sa reggerlo, produce fatturati notevoli). Il pensatore riflessivo, quello che attende il proprio turno di parola, non esiste più.
Vidal era uno di questi. La sua propensione alla provocazione – mai volgare, benché irritante – lo portava spesso sulle prime pagine dei giornali. Celebre la lite con William F. Buckley, il candidato repubblicano con cui ingaggiava frequenti duelli televisivi. Durante la Convention Democratica del 1968, in diretta su ABC News, Buckley perse il controllo: dopo una raffica di provocazioni, lo insultò dandogli del “queer” e minacciando di spaccargli quella “shitty face”.
Non era certo un personaggio compiacente, Vidal. Da polemista, sostenne tesi antiamericane che oggi forse troverebbero consensi di piazza, come l’idea che gli Stati Uniti fossero a conoscenza dell’attacco dell’11 settembre così come di quello di Pearl Harbor. Era vicino agli intellettuali ebrei newyorkesi, ma se ne distaccò dopo la nascita dello Stato di Israele. Amava le risse tra scrittori: prese un pugno da Norman Mailer e trovò comunque il modo di chiudere con eleganza: “anche questa volta a Mailer sono mancate le parole”.
Ancora più note erano le sue antipatie. Su tutte quella per Truman Capote. L’odio reciproco era pubblico, tanto che finì in tribunale. Per Vidal, Capote era un bugiardo cronico. Nei suoi memoir, Palinsesto e Navigando a vista (pubblicati in Italia da Fazi) non perde occasione di sbugiardarlo. Quando ricorda il suo primo volo, fatto a undici anni in compagnia del padre, Eugene, pioniere dell’aviazione, si sofferma più a screditare la versione di Capote – che aveva osato appropriarsi dell’aneddoto – che a raccontare l’emozione del ricordo.
Ci furono anche amicizie sincere. Con Christopher Isherwood mantenne un legame costante, pur non risparmiandogli le critiche. Diceva che beveva troppo, che i suoi diari erano “il diario delle sbornie”, e non capiva la sua ossessione per la propria vita domestica e per il ruolo di icona gay.
Sempre in Navigando a vista, mentre racconta l’incontro casuale in Cambogia con Barbara Cartland, la scrittrice di romanzi rosa e matrigna di Lady D, prova a punzecchiarla sul perché non fosse andata al matrimonio della figliastra. Vidal sa la verità – gliel’ha riferita la principessa Margaret – ma non la rivela a nessuno: non è, dice, un pettegolo come Truman. “Truman Capote ha trascorso gran parte della sua vita – con un certo successo – cercando di entrare in un mondo da cui io ho trascorso gran parte della mia vita – con un certo successo – cercando di uscire.”
Lui, in mezzo ai cigni, ci era nato. Cresciuto tra West Point e Washington, non nella provincia sudista di Capote, Gore Vidal era imparentato con i Kennedy (il secondo marito di sua madre era il patrigno di Jackie), e aveva trascorso l’infanzia in compagnia del nonno cieco, il senatore Thomas Gore, a cui leggeva per ore e che accompagnava per le strade all’ombra del Campidoglio. Da adulto poté scegliere tra politica e letteratura e scelse la seconda.
La carriera di scrittore iniziò con Williwaw, scritto mentre era in marina. Un esordio riassumibile, in un linguaggio da pitch, come “romanzo hemingwayano”. Quel primo successo lo fece entrare nel giro degli scrittori suoi coetanei, tra cui Tennessee Williams, con cui girò l’Europa su una jeep che, a suo dire, guidava malissimo. Sarebbe potuto diventare uno dei grandi della sua generazione, ma nel 1948 pubblicò The city and the pillar. Un successo ma anche una condanna. Nessuno, prima di lui, aveva raccontato l’amore tra uomini in maniera esplicita, senza impelagarsi in metafore speleologiche. Cheever si sfogava nei diari, Isherwood dietro l’obiettivo della camera. E forse facevano bene. Vidal fu cancellato ante litteram, il «New York Times» smise di recensirlo. Si era spinto troppo avanti. “Il sesso è politica”, dirà poi — parafrasando, o forse anticipando, Foucault.
Ma per il nipote di Thomas Gore, che era riuscito a diventare senatore nonostante la cecità sopraggiunta da ragazzino, non esiste l’autocommiserazione. Dato che con i romanzi non c’era futuro, Vidal si buttò sul cinema. Faulkner lo mise in guardia, si fa presto a fare la fine di Fitzgerald, ma lui aveva bisogno di soldi. Sceneggiò molti film di successo – Ben-Hur, Pranzo di nozze, Io, Caligola – ma intanto covava il riscatto come romanziere. E lo trovò con Myra Breckinridge: il romanzo di un uomo che sceglie di diventare la vedova di se stesso. In Italia non viene ristampato da anni, eppure chissà che oggi non serva proprio un libro così: un romanzo che, tra Pirandello e Virginia Woolf, racconti un uomo che si risveglia donna nell’America di Trump o nell’Europa di Giorgia Meloni; chissà i tweet di J.K. Rowling.
Dopo il periodo romano – Vidal abitò a lungo in largo Argentina dove scrisse la sceneggiatura di Ben-Hur – negli anni Settanta si trasferì a Ravello, nella celebre villa Rondinaia. Quando la comprò, in casa c’erano solo un tavolo e una sedia, “tutto ciò di cui uno scrittore ha bisogno”. Lì trascorse il resto della sua vita, scrivendo i Narratives of Empire, i sette romanzi che ricostruiscono la storia degli “Stati Uniti d’Amnesia”, come li definì in seguito, per raccontare la deriva imperialista di una nazione che preferisce dimenticare le sue origini colonizzatrici. Per il centenario della nascita dell’autore, questo autunno, Fazi ha ristampato Washington D.C. e il monumentale Hollywood – romanzone corale alla Ken Follett dove i protagonisti vanno da Chaplin a Roosevelt.
“Chissà che vitaccia avrebbe avuto oggi Vidal, dove il consenso rischia di farsi gestire da algoritmi e intelligenze artificiali. Forse si sarebbe divertito a criticare il giustizialismo social, la deriva retequattrista del dibattito pubblico, o magari era davvero troppo elitario e WASP per capirne il linguaggio”.
Alla Rondinaia viveva con il compagno di sempre, Howard Austen, ex manager di Broadway, allegro, brillante, spesso intento a cantare per gli ospiti sulla terrazza affacciata sul mare. Il loro era un rapporto d’altri tempi. Vidal rifiutava l’idea di coppia romantica: sosteneva che il segreto di una relazione duratura fosse la castità. “Il sesso distrugge la relazione”, diceva. “Va praticato fuori dalla coppia, e possibilmente non con persone amiche”. Chi passava per la Rondinaia – da Susan Sarandon a Hillary Clinton – notava la loro stabilità. Austen si occupava delle cose pratiche e, talvolta, di sgonfiare la pomposità del compagno. “Gore was a very cold fish”, racconta Matt Tyrnauer, il suo editor, mentre Howard era più allegro e meno timido.
Le pagine del memoir in cui Vidal rievoca gli ultimi giorni di vita di Howard Austen, morto nel 2003, commuovono non per sentimentalismo ma per la lucidità con cui racconta il dolore: il letto, gli ospedali: “la sostanza di cui sono fatti i bulbi oculari aveva ceduto, e due strisce gelatinose, simili a quelle lasciate dalle lumache, gli scorrevano lungo le guance.” Alla fine Vidal ammette il rimorso di non aver pianto, prigioniero del suo ghiacciaio WASP. A ricompensarlo con le lacrime ci ha pensato Francesco Vezzoli, ricamandogliene una blu su un ritratto in bianco e nero, oltre ad averlo ingaggiato per Trailer for a remake of Gore Vidal’s Caligula esposto poi alla Biennale.
Chissà che vitaccia avrebbe avuto oggi Vidal, dove il consenso rischia di farsi gestire da algoritmi e intelligenze artificiali. Forse si sarebbe divertito a criticare il giustizialismo social, la deriva retequattrista del dibattito pubblico, o magari era davvero troppo elitario e WASP per capirne il linguaggio. Una cosa era provocare Truman Capote, un’altra traccheggiare con Kanye West e le Kardashian. In fondo Vidal è l’espressione di un élite culturale, aristocratica, che si divertiva a giocare con il populismo illuminato, ma sempre dall’alto della Rondinaia, e forse è per questo che in un’epoca come la nostra – risentita e insicura – rischia di essere dimenticato. Si avrebbe forse bisogno di un racconto che lo renda più leggibile soprattutto per i più giovani, che al nome Vidal rischiano di associare soltanto il marchio del docciaschiuma. Magari un bel biopic.
Un buon punto di partenza potrebbe essere, oltre alla morte dell’amato Jimmy Trimble, primo amore caduto nell’inutile battaglia di Iwo Jima, anche la stroncatura di The City and the Pillar: la prima ferita, la fatal flow che tanto piace agli sceneggiatori. Un modo per scagionare tutta la pomposità e la litigiosità di un autore che, per l’intera vita, non si è mai pianto addosso. Un biopic su Vidal, in realtà, era davvero pronto per Netflix, ma il progetto è sfumato dopo le accuse di molestie a Kevin Spacey, che avrebbe dovuto interpretarlo. Chissà cosa ne avrebbe pensato Gore.