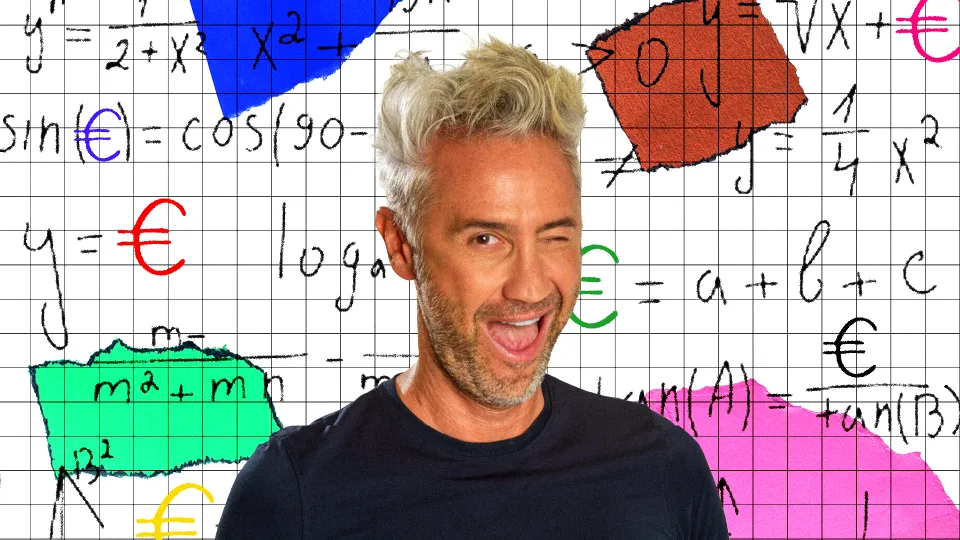Dal cinema all’industria, dall’abbigliamento alla ristorazione, l’America ha trasformato abitudini, gusti e immaginario collettivo degli italiani, e non solo. In meglio o in peggio?
Con l’America abbiamo sempre avuto un rapporto ambivalente. Durante il Fascismo, molti scrittori americani venivano interpretati nel nostro Paese come un importante simbolo di libertà. La cultura di sinistra, cioè, vedeva l’America come una terra di rinnovamento e progresso. E anche il mondo proposto dalle pellicole cinematografiche realizzate a Hollywood veniva molto considerato. Come ha scritto Umberto Eco diversi anni fa nel saggio Il modello americano, “Nel 1939 il Ringo di Ombre rosse fu l’idolo della generazione. Ringo non combatteva per un’ideologia o per la patria, ma per se stesso e per una puttana. Era antiretorico e perciò antifascista”. Questa immagine positiva degli Stati Uniti si è progressivamente rafforzata in Italia, anche perché gli americani si sono assunti il ruolo dei “salvatori” durante la seconda guerra mondiale. Pertanto, a guerra terminata, la società italiana, così come le altre società europee, ha accolto a braccia aperte tutto ciò che aveva a che fare con il seducente modello dei consumi di massa provenienti dagli Stati Uniti, il cosiddetto american way of life. Sono bastati pochi anni però perché le piazze italiane si riempissero di manifestanti che arrivavano anche a bruciare le bandiere a stelle e strisce. Era naturalmente l’epoca delle proteste contro la guerra combattuta dagli Stati Uniti nel Vietnam.
Negli ultimi decenni, invece, la società statunitense e i suoi prodotti hanno goduto di un notevole favore e di una posizione rilevante sui principali mercati mondiali. Anzi, probabilmente, nessun Paese come gli Stati Uniti è stato in grado negli ultimi decenni di esercitare una così elevata influenza sulla cultura italiana ed europea. Un’influenza che ha agito a vari livelli: su quello molto evidente dei prodotti culturali diffusi mediante il sistema mediatico, come i film, le serie televisive o le canzoni, ma anche su un livello in apparenza meno visibile come quello che gli antropologi hanno definito “cultura materiale”. Vale a dire tutti quegli aspetti concreti di una cultura che riguardano i prodotti e i comportamenti utilizzati nella vita quotidiana, dagli abiti agli alimenti.
Per quanto riguarda i primi, è evidente che negli ultimi decenni in Italia e nel resto del mondo occidentale si è sviluppata una vera e propria “americanizzazione”. Si è sempre più imposto, infatti, l’abbigliamento “casual”, caratterizzato da semplicità e praticità d’uso e adatto a essere indossato in ogni occasione e attività della giornata. Quel tipo di abbigliamento, cioè, che proviene direttamente dalla cultura americana, da sempre libera e orientata all’informalità nel vestire. Ma se questo tipo di abbigliamento è stato accettato anche in luoghi come l’Italia, dove dominavano da molto tempo delle regole di comportamento che prevedevano la formalità nel vestire, è perché rappresenta il risultato di un’efficace applicazione del modello industriale all’abbigliamento. Non a caso è venuta dal contesto culturale americano anche la proposta di un tipo di abbigliamento prodotto in serie come i jeans. Infatti, negli Stati Uniti sono nate le principali marche di jeans, a cominciare da Levi’s. E qualcosa di analogo è successo con le sneaker di Nike, Reebok o Converse. Queste calzature, infatti, sono molto espressive sul piano del design, ma sono soprattutto dei prodotti tipicamente industriali e seriali. Prodotti acquistati, più che per svolgere una specifica attività sportiva, per camminarci durante la giornata. Hanno reso perciò anch’essi l’abbigliamento quotidiano degli italiani e degli europei decisamente meno rigoroso e formale.
Nel caso invece dell’ambito alimentare, anche qui le regole tradizionali del mangiare, dalla successione delle portate al rigore delle ricette, sono state sostituite da quella che lo studioso francese Claude Fischler ha chiamato «gastro-anomia», cioè una condizione di mancanza di precise regole di comportamento. Le ragioni di questo cambiamento sono numerose, ma sicuramente una delle più rilevanti è rappresentata dalla creazione e dalla progressiva diffusione nel mondo da parte degli americani del modello del fast food, nato a metà degli anni Cinquanta del Novecento, quando i fratelli McDonald e il rappresentante di frullatori Ray Kroc hanno cominciato a costruire la catena di ristoranti McDonald’s. Alla base del successo planetario di McDonald’s, e delle altre aziende che prontamente l’hanno imitata come ad esempio Burger King o Kentucky Fried Chicken, ci sono diverse ragioni. Ragioni di economicità dei prodotti, ma soprattutto legate alla capacità di queste aziende di assecondare le richieste di funzionalità alimentare provenienti dai consumatori. Infatti, i ristoranti fast food offrono dei cibi che possono essere scelti e consumati a ogni ora del giorno. Inoltre, vi si può mangiare liberamente, con le mani, in piedi e seguendo un qualsiasi ordine dei cibi. Il fast food diventa così un simbolo di quella libertà dalle regole che sta conquistando un ruolo sempre più decisivo all’interno dell’ambito alimentare contemporaneo. Non è un caso perciò che il sociologo statunitense George Ritzer abbia formulato anni fa il concetto di “mcDonaldizzazione della società” per indicare che le più importanti istituzioni sociali dei Paesi avanzati (politica, religione, scuola, sport, ecc.) adottano lo stesso modello basato sulla razionalizzazione e sulla standardizzazione nella gestione delle risorse umane ed economiche, che un’azienda come McDonald’s impiega con successo ogni giorno nelle sue molteplici attività.
“Un’influenza che ha agito a vari livelli: su quello molto evidente dei prodotti culturali diffusi mediante il sistema mediatico, come i film, le serie televisive o le canzoni, ma anche su un livello in apparenza meno visibile come quello che gli antropologi hanno definito ‘cultura materiale'”.
I cambiamenti in atto nel mondo dell’abbigliamento e in quello alimentare non sono però che degli esempi della capacità di miglioramento continuamente dimostrata dagli americani rispetto al modello industriale. Tale modello, infatti, è nato secoli fa in Europa, ma gli Stati Uniti nel corso del Novecento l’hanno sempre più perfezionato. Le imprese statunitensi, infatti, hanno notevolmente innalzato il livello di efficienza produttiva introducendo la tecnologia della catena di montaggio all’interno della grande fabbrica, grazie alle intuizioni di Frederick Taylor e delle prime applicazioni dell’imprenditore automobilistico Henry Ford. Successivamente, tali imprese hanno capito che dovevano favorire la nascita di una domanda di massa per i beni che producevano nelle fabbriche. È nato così il marketing, emerso appunto con questo preciso obiettivo all’interno del mondo industriale statunitense a partire dagli anni Trenta. Il marketing, a sua volta, ha cominciato a promuovere i propri prodotti utilizzando degli efficaci strumenti di comunicazione come i messaggi pubblicitari.
Dunque, è propriamente agli americani che possiamo attribuire la capacità di perfezionare il modello industriale. Ciò è avvenuto nel corso del Novecento, un secolo nel corso del quale tale modello è stato efficacemente applicato non solamente ai prodotti industriali, ma anche a quelli culturali. Si pensi, ad esempio, a ciò che è successo negli ambiti della musica, del cinema o della televisione. Tutti ambiti che si sono progressivamente caratterizzati per l’adozione di un processo d’industrializzazione basato sul principio di serialità.
Il modello economico e sociale capitalistico creato e messo a punto nei principali Paesi europei e poi perfezionato negli Stati Uniti ha dimostrato però di aver bisogno di consumare molte risorse materiali. Anzi, ha dimostrato che per funzionare al meglio ha una necessità vitale di tali risorse. Negli Stati Uniti, nella fase iniziale del processo d’industrializzazione, durata circa cinquant’anni, dalla fine della guerra civile all’inizio della prima guerra mondiale, tali risorse erano largamente presenti sul territorio geografico del Paese. Si trattava ad esempio di petrolio, ma anche di ferro, oro e un’ampia quantità di terre che potevano essere sfruttate. La ricchezza, insomma, veniva ricavata soprattutto dalla possibilità di disporre di uno spazio sconfinato, coincidente in gran parte con quello del West.
Quando le risorse materiali hanno cominciato a essere meno disponibili, gli americani si sono inventati un nuovo territorio da sfruttare: quello dell’immaginario cinematografico. A Hollywood, all’epoca un piccolo villaggio situato vicino a Los Angeles, si è insediato nel 1919 il primo studio cinematografico e l’anno successivo gli studi operanti erano già una cinquantina. Numerosi produttori cinematografici e registi si erano trasferiti da New York e dalla costa Est degli Stati Uniti dando così vita a un vero e proprio distretto industriale. È stata creata in questo modo un’altra “nuova frontiera”, simile a quella del territorio fisico del West, ma allo stesso tempo anche immateriale.
Poi, quando anche il processo di sfruttamento dell’immaginario del cinema ha cominciato a dare dei segnali d’indebolimento, è stato creato un altro territorio da poter utilizzare: lo spazio digitale del Web. Con il risultato che oggi una parte consistente delle più importanti imprese del mondo si trova negli Stati Uniti e si è specializzata nella produzione di tecnologie e servizi legati al mondo digitale. Parliamo, infatti, di imprese come Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Amazon o Nvidia, che hanno progressivamente invaso il mondo con i loro prodotti e servizi e, anche in questo caso, sfruttando le risorse disponibili nel nuovo territorio digitale grazie all’applicazione di principi di efficienza basati sulla serialità.
È il caso a questo punto di chiedersi se gli Stati Uniti potranno continuare ad esercitare quell’egemonia economica e culturale che hanno sinora saputo esprimere nei principali ambiti della vita quotidiana delle persone. Le opinioni su questo tema sono diverse, ma è evidente che i processi di globalizzazione della cultura, nonostante qualche momentaneo rallentamento, non potranno che continuare ad espandersi e ciò porterà all’emergere di più soggetti importanti all’interno del contesto mondiale. Soggetti che affiancheranno pertanto gli Stati Uniti, i quali potranno subire un indebolimento della capacità d’influenza esercitata sino ad oggi.
Ciò non significa tuttavia che la cultura americana non possa continuare a essere considerata affascinante dagli europei e anche dal resto del mondo. Probabilmente, il suo successo dipende, oltre che dalla capacità di migliorare e rendere più efficiente il modello industriale e la sua natura seriale, dalla sua effettiva diversità rispetto all’Europa. Il sociologo francese Jean Baudrillard, qualche anno fa, l’aveva accusata di essere “primitiva” e “selvaggia”. Forse questo è un giudizio eccessivamente critico, ma è certo che, perlomeno agli occhi degli europei, la cultura americana si presenta da sempre come qualcosa di molto differente e a volte anche dotato di una natura quasi opposta. Sicuramente è giovane, dinamica e soprattutto libera. E ciò contrasta con le caratteristiche proprie del mondo europeo, che nel corso della sua lunga storia è andato via via stabilizzandosi, dandosi un ordine e una struttura.
La cultura americana, inoltre, è principalmente pop. Il che significa non che ha a che fare con un linguaggio artistico sofisticato come quello della Pop Art, ma che dev’essere considerata “popolare” e “commerciale”. Però anche, al tempo stesso, che tende a presentarsi come un universo dominato dal bisogno di crescita e dalla ricerca di forme di saturazione. Può essere pertanto considerata, per certi versi, orientata verso un’estetica “barocca”. Vale a dire che, come lo stile barocco, tende a riempire tutti gli spazi sociali e culturali disponibili e non a caso adotta sistematicamente il principio del “big”, ovvero delle grandi dimensioni. Tutto nella cultura americana dev’essere grande: dagli hamburger ai pick-up, dalle superstrade ai centri commerciali.
Implicitamente, dietro ciò si nasconde una promessa di soddisfazione. Cioè, la promessa fatta a ciascun individuo di poter trovare la possibilità di realizzare i suoi bisogni e i suoi desideri. La possibilità, dunque, di raggiungere la propria felicità. Un sogno evidentemente, ma un sogno che, se ripetuto quotidianamente, diventa credibile e considerato possibile dalle persone. Un sogno però che gli europei, i quali vedono il mondo dall’alto della loro storia millenaria di drammi e difficoltà, possono considerare scarsamente realizzabile. Rimane tuttavia seducente anche ai loro occhi, perché, in fondo, si tratta della stessa promessa di felicità che le merci dell’universo del consumo formulano in tutto il mondo ogni giorno dalle vetrine dei negozi, dagli scaffali dei supermercati o dalle seducenti immagini pubblicitarie e sulla quale basano la propria efficacia.