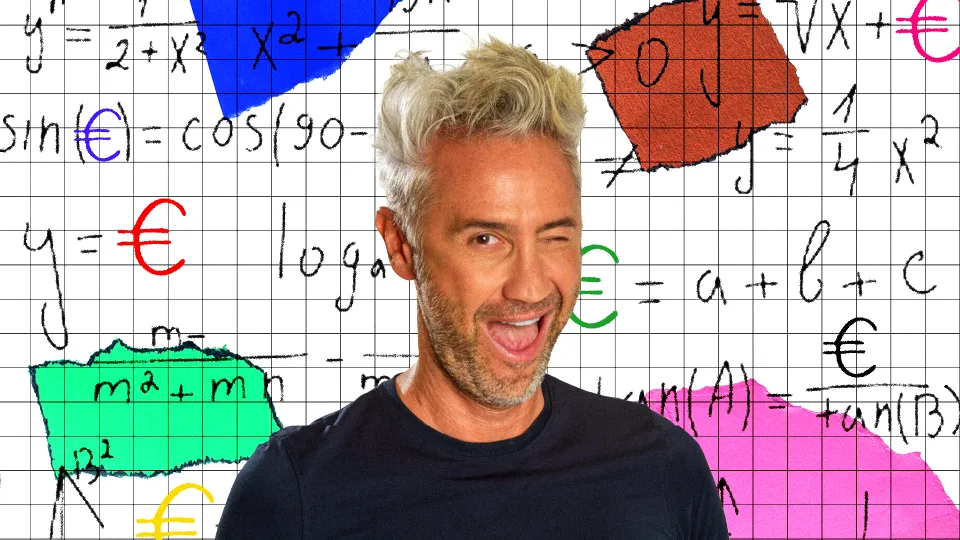Su Internet ormai imperversano le frasi fatte, gli aforismi apocrifi, le banalità più trite fatte passare per poesia. Eppure proprio l’arte ci dimostra come, alcune semplificazioni, in mano agli artisti, possono generare capolavori.
In un’era monopolizzata dalle immagini il suono continua comunque a ricoprire un valore fondamentale. Se non altro per la sua prossimità alle più immediate reazioni corporee e nervose. Certi maschi dotati di ugola rugginosa (per natura o per antica consuetudine col fumo) traggono consapevole vantaggio dal potere persuasivo e avvolgente della voce.
Esiste in alcune persone un’attrazione viscerale per i toni bassi, i grumi fonici, le sonorità gravi fin quasi all’inudibile. Penso alle note profonde della voce di Carmelo Bene magnificate da un sub-woofer magari posizionato sotto le poltrone della platea; alle nenie di Ligeti riversate da Kubrick in Eyes Wide Shut; ai cantici in diplofonia dei monaci tibetani che tanto hanno contato nella ricerca di Demetrio Stratos; al monumentale bordone grave di Dana Colley, sassofonista dei Morphine, a Kali Malone che sperimenta con le vibrazioni più cavernose degli organi da chiesa, e naturalmente al timbro oscuro di Leonard Cohen.
A quel momento indimenticabile in cui nella title track del suo album testamentario, You Want It Darker, lui entra a doppiare il coro (una risposta da brividi, quella di Abramo: hineni, hineni, “eccomi”), aggiungendo poi, a voce sola: I’m ready, my Lord. Ascoltatelo in surround a volume brillante: sentirete vibrare la bocca dello stomaco. “A million candles burning for the help that never came”.
C’è stato un periodo (probabilmente ancora in corso) durante il quale era in auge nei social, anche nei profili votati all’arteterapia e all’autoaiuto, una particolare declinazione memetica di due versi celebri di Leonard Cohen (da Anthem, 1992): There is a crack, a crack in everything. / That’s how the light gets in. ‘C’è una crepa, una crepa in ogni cosa. / È così che entra la luce’. Che poesia ieratica in tonalità maggiore, che immagine densa e lieve al contempo: il fascino casuale della sprezzatura. Salvezza nella fragilità. Il poeta prende un pezzo del suo sogno individuale e lo compartisce a tutti noi, facendoci sognare i suoi stessi sogni. Quanti richiami si svegliano nella mente: dagli evangelici vasi di terracotta in mezzo ai vasi di bronzo fino alla preziosa saggezza orientale del kintsugi, che risarcendo le fratture della ceramica tramite l’oro accoglie l’imperfezione, anzi la illumina.
Oltre a queste vene d’oro in vasi e ciotole, il repertorio che si ritrova come sfondo di questa massima comprende labili foglie lacerate da cui traluce un raggio di sole, mari al tramonto visti da una grotta, epifanie luminose sorte da mani a coppa, montagne e fiori di iperico che spaccano gentilmente una coltre d’asfalto. Ora, com’è possibile che, a forza di essere reiterato a nastro (anzi a catena social) dagli early birds dei buongiorni facebookari, il conio originale di questi due versi aurei si sia usurato, generando una sensazione di annoiato fastidio e degradandosi ormai a banale tritume della rete? Finendo nella soffitta delle frasi fatte, anzi sfatte, consumandosi fino a rendersi “knownsense”? Si deve ovviamente all’effetto cliché, che non risparmia nulla e nessuno. Lo stesso arbitrario destino è capitato a centinaia di immagini della pittura moderna, dalla Gioconda agli autoritratti di Frida Kahlo, dai corvi di Van Gogh alla danza di Matisse, fino a Paul Klee e via dipingendo.
La disseminazione del suono-immagine nell’epoca della sua riproducibilità digitale non la potenzia ma la sfarina spixelandola in un pulviscolo insignificante che possiamo gratificare della nostra distrazione senza soverchie ansie. All’ennesimo ascolto o visione lo choc si estingue, i sensi si assuefanno e il senso sparisce, diviene “la solita roba”, già sentita, risaputa, inerme piattume cognitivo tradotto in tormentone di massa. Paesaggi mai visti, posti appena scoperti nel batticuore dell’inatteso si mutano in luoghi comuni ai nostri occhi di turisti dell’immagine. Per salvarsi da questa “luogocomunione” che ci intontisce bisognerebbe recuperare una virtuosa facoltà di oblio, così da continuare a ristupirsi ogni volta che ci imbattiamo in una data esperienza, “come fosse la prima volta” (sì, anche questo pezzo non sarà esente da cliché). La democratizzazione della produzione di immagini apportata dal digitale è certo un dato positivo, perché ne ha strappato il controllo dalle mani di un’élite, ma il suo rovescio è anche questa forma di dissipazione, il disinnescarsi progressivo della loro potenza di senso.
In quanto umani siamo cercatori, interpreti e ricevitori di segni, e senza essere immersi in questa circolazione proliferante neppure sapremmo come vivere. La ripetizione, in sé essenziale all’assorbimento del sapere, è un processo irrinunciabile anche nella letteratura. Come faceva a non annoiarsi il signor Reger, protagonista monologante di Antichi maestri di Thomas Bernhard? Intendo: come faceva a starsene seduto in un immoto sdegno ogni due giorni (tranne il lunedì) sempre e solo davanti a un unico quadro, l’Uomo con la barba bianca del Tintoretto, in una sala del Kunsthistorisches Museum di Vienna, come faceva a centellinare senza tregua qualunque dettaglio visivo della superficie pittorica alla ricerca delle crepe nel fulgido genio degli autori di capolavori, lui, Reger, individuo singolo in fuga dalla tirannia della perfezione, snocciolando intanto algido e furente le sue polemiche accuse contro la società austriaca, le storture innate dell’essere umano, il cronico stato d’insufficienza dell’universo mondo? Per Reger “pedanteria e kitsch sono d’altronde le qualità fondamentali dell’uomo cosiddetto civilizzato”. Il supremo cliché è allora quello del genio museificato, che riscuote il cieco tributo delle folle strozzate dal pubblico dovere della serietà: “La gente trascina con sé il suo pesante fardello di ammirazione perché non ha il coraggio di deporre l’ammirazione al guardaroba insieme al cappotto”.
Il contagio delle immagini-cliché sembra essenziale nel mondo dell’editoria libraria, dove si tenta di riprodurre un’emozione nel contatto visivo immediato con la veste del volume. Più volte negli anni si è notato il riproporsi di un medesimo pattern a presa rapida nelle copertine di certi romanzi: un solo esempio valga per tutti, quello del modulo “giovane donna di spalle” con sfondo variabile: sentiero di campagna, facciate parigine, mari turbinosi, cieli corruschi o fitti di nuvolaglia.
Altra immagine-feticcio, soprattutto in tempi mutevoli come i nostri, è la cosiddetta Flammarion engraving: una incisione di autore ignoto comparsa la prima volta in L’atmosphere: météorologie populaire di Camille Flammarion (1888). Un viandante medievale (profeta? alchimista? frate? vagabondo?) giunge ai confini del mondo tolemaico, laddove il cielo e la terra si toccano, e piegandosi in basso riesce a sgusciar via carponi da quell’asola, a travalicarne i limiti gettando uno sguardo oltre le ruote celesti, in un complesso aldilà che dovrebbe identificarsi con quello della rivoluzione scientifica.
Ma l’immagine è in parte ambigua, valori simbolici di stampo diverso vi si intrecciano: anche visioni bibliche (la ruota del profeta Ezechiele) ed esoteriche. Penso che la sua fortuna enorme nella iconomania odierna sia dovuta anche a questo: può indicare la disposizione d’animo richiesta alla nuova critica dell’antropocentrismo che pervade l’aria del nostro presente, posta al crocevia tra sensibilità ecologica, fascinazione quantistica e scommessa psichedelica: chinarsi umili a terra, nella posizione etimologicamente umiliata di un supplice o di uno sconfitto, prostrarsi al vivente e accogliere tutto quell’oltremondo che vibra al di là delle crepe del mondo conosciuto (o che ci è comodo pensare tale).
Del resto, per dirla con Voltaire, credere che il cielo si esaurisca nella sua visibile calotta blu (che poi è un nero) vorrebbe dire essere un baco da seta persuaso che i limiti del suo mondo siano quelli del suo bozzolo. Il polemico, mordace Voltaire, la bestia nera degli irrazionalisti di ogni ordine e grado (che dal canto loro non possono stupirsi: nacque Scorpione terza decade), è a sua volta incolpevole depositario di una serie non indifferente di cliché: primo fra tutti la famosa frase-grimaldello “Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”.
L’autore di Candido non l’ha però mai pronunciata né scritta: è una sintesi corriva, un malaccorto liofilizzato che si deve a Evelyn Beatrice Hall, autrice di una biografia sugli amici del pensatore illuminista. Allo stesso modo, Machiavelli non ha mai scritto nel Principe che “Il fine giustifica i mezzi”, eppure è passata quasi in proverbio questa frase. Esattamente come i proverbi e lo small talk da ascensore o accidia postprandiale, la moneta ecumenica del cliché soddisfa bisogni innati: economizzare gli sforzi di pensiero con effetto immediato, farsi capire subito (o illudersi di capire), richiamarsi a un sapere collettivo e semplice, di pronta beva, in modo da sentirsi parte di un consorzio umano sostanziato di identici valori e speranze.
Certo esiste una maniera per rivitalizzare il cliché: o esasperarlo fino a che non acquisisca di per sé un valore ludico o polemico, o prenderlo di sbieco, di scorcio, sgambettarlo tramite la parodia o la variazione.
Se la poderosa operosità di Dante, supremo artefice di una lingua in fase di invenzione, è all’origine di tanti modi di dire ormai per noi naturali (eccone uno: “ché la vostra miseria non mi tange”, dichiara Beatrice nel Canto II dell’Inferno), nel Novecento Andrea Zanzotto si prepara con le IX Ecloghe (1962) agli scivolamenti semantici e alle spericolate oltranze del suo libro successivo, La Beltà (1968): e fra le pieghe di un linguaggio finto-candido e ricercato che ride dolorosamente dei suoi cliché, gioca ironico con il titolo di un famoso programma televisivo («Ah, domenica è sempre domenica») e su un ritornello di Domenico Modugno caro alle nostre nonne: “Abiuro dalle lettere consuete. / O primavera di cocchi e di lendini, / primavera di liquor, dei, suspense, / ‘vorrei trovare / parole nuove'”.
Secondo un simile istinto il genio surrealista Robert Desnos aveva già inventato – un po’ rovesciando i cieli in cornice di Magritte – il cliché al quadrato, la piatta vetta del senso letterale: elencando, nella poesia Vento notturno, corrispondenze fisse fra un nome e un aggettivo per poi ribaltare tutto nell’ultimo verso, apocalittico: “terra terrestre / cielo celeste / ma dov’è la terra celeste?”. Ancora prima, a fine Ottocento, un precursore oscuro dei surrealisti, il temibile Isidore Ducasse (“Conte di Lautréamont”), ci aveva elargito in due Poesie in prosa una sorta di catechismo al contrario, un “libretto di distruzioni” che rovesciava le massime della saggezza comune e della tradizione. E allora “Elohim è fatto a immagine dell’uomo”, e “La poesia deve essere fatta da tutti e non da uno solo”.
Tornando invece alla musica, un altro dei movimenti che mi spingono sempre a interrogarmi è quello che ribattezzerei (non da musicologo, che non sono, ma da goffo praticone schitarrante) scivolamento cromatico: tre o quattro semitoni discendenti, fino alla risoluzione: un modulo che ritrovo, per non parlare della musica colta, in tante canzoni classiche del pop e del rock: Strawberry Fields Forever, Stairway to Heaven, Grace, Paranoid Android. Che altro dire? Sono pietre miliari. Evito di citare i Gentle Giant, i King Crimson e tutto il giardino fatato del progressive inglese per mancanza di spazio, non d’amore.
Bene, la discesa cromatica trovo abbia un potere psichico notevolissimo, palesemente vagotonico: almeno su di me ha un effetto rilassante, mi induce alla meditazione, o al dolce precipizio di un’ estasi immemoriale, a un “mancare a sé stessi”: a volte mi riporta in mente il verbo inglese to swoon (‘svenire’, ‘perdere i sensi’) così come è usato da Keats (And so live ever – or else swoon to death). Cos’altro è lo scivolamento cromatico se non un pattern armonico semplicissimo, un ennesimo e primordiale cliché? Eppure ogni sua nuova ripetizione, ogni variata declinazione musicale lo rivisita in modi che sembrano inattesi al primo ascolto. Infatti ‘andare in visibilio’ è un’altra accezione di quel verbo.
“La discesa cromatica trovo abbia un potere psichico notevolissimo, palesemente vagotonico: almeno su di me ha un effetto rilassante, mi induce alla meditazione, o al dolce precipizio di un’ estasi immemoriale”.
L’ultimo nome che evocherei in questa passeggiata casuale fra suoni, voci e figure è Robert Walser, con il suo compìto manierismo del candore, in cui pulsa la grazia di una vena di perfidia. In lui la superficie è tutto, ed è là che il cliché si prende sempre per buono.
Un tratto costante del suo stile mi pare d’altro canto la ricerca, o l’attesa, di una impossibilità: l’impossibilità di districare mitezza e protesta nei momenti “antispeciali” di uno scrivere svagatamente a vanvera. Tendenza disorientante che si fa più vivida in libri come Il brigante, La passeggiata e negli enigmatici Microgrammi composti in punta di matita, da amanuense lenticolare, su volantini e carta di recupero durante la lunga reclusione volontaria nel sanatorio di Herisau.
Walser sembra sempre adoperarsi alla parodia celata di una giudiziosa scrittura comme il faut, minando con sottili punture scettiche – ma di esteriore inamidato ossequio – il corpo sociale, “quel che si deve dire” e “quel che si deve pensare”. Impossibile decidere, in certe sue sortite, cosa sia e non sia cliché, dove giaccia il cadavere del luogo comune e dove il riso spensierato a bocca chiusa che lo scortica, fingendo di guardare da un’altra parte.
In una prosa dei Microgrammi (cito dalla traduzione di Giusi Drago) il trafugamento della Gioconda dal Louvre, avvenuto nel 1911, è letto come un desiderio esaudito: il quadro ne aveva abbastanza di tutti quegli occhi addosso, e voleva uscire all’aria aperta, voleva un’avventura. “Un quadro pressoché incomprensibile, che sembra essere stato dipinto sulla luna o su qualche altro strano pianeta, va quasi necessariamente sottratto a una sorte poco intelligibile. […] ‘Sono incompresa’ si era lamentata lei per secoli con instancabile monotonia. L’indecifrata non doveva forse avere un anelito a ciò corrispondente?”.
In un altro microgramma Walser dirige lo sguardo sulla nascente società dello spettacolo, anzi sullo spettacolo della società: “Tuttavia è un fatto che la buona società volge le spalle all’Opera e al teatro, perché ‘lì non succede niente’, in altre parole, perché bisogna starsene seduti compostissimi, perché c’è ben poco da aspettarsi in fatto di genio e di autentica artisticità, perché quel nonsoché di mondano è stato praticamente eliminato, perché l’arte ha cominciato a fare la maestrina, invece di limitarsi a essere solo piacevole, nobile, felice, perché lì, vedendo l’evoluzione in corso, una voce insistente sembra dire: ‘Siete obbligati ad applaudire, a portar rispetto’. Quando le arti tremavano per la loro sopravvivenza calcavano le scene dieci volte meglio, perché un’interpretazione meramente professionale è una cattiva interpretazione, se non è il risultato di una lotta contro l’ingiustizia”.
Il solitario che divaga, e attraversa il mondo per tramiti indiretti, facendosi portare da una cedevole disponibilità a tutto quel che accade, valica un confine, magari senza saperlo. “Si vede dunque che ho da fare molte cose e che questa mia passeggiata, all’apparenza indolente e pacifica, brulica in realtà d’impegni pratici, di appuntamenti d’affari. Si abbia perciò la bontà di perdonare gli indugi, giustificare i ritardi e tener per buone le lunghe discussioni con funzionari e altrettali intendenti, e anzi di voler considerare tutto ciò con benevolenza, quale contributo e apporto allo svago. Per tutte le lungaggini, divagazioni e prolissità che ne derivano, chiedo in anticipo umilmente scusa”.
Laddove indugiare senza scopo e perdersi nel tempo perso è proprio quel che vuole, ammesso che qualcosa voglia.
Non è poco per l’uomo che scrisse: “Nessuno è giustificato a comportarsi nei miei riguardi come se mi conoscesse”.