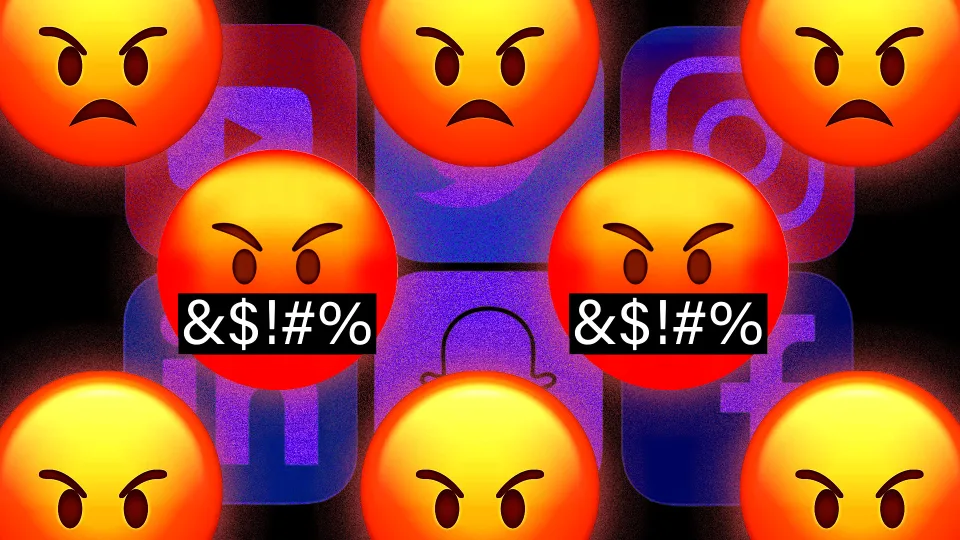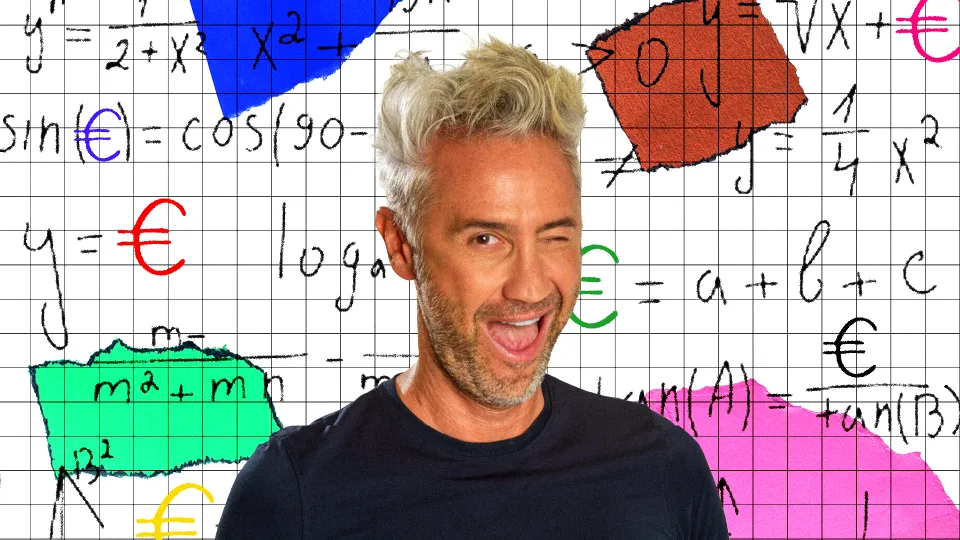Rita De Crescenzo ha molti follower ma altrettanti detrattori, che la guardano con snobismo, spaesamento quando non con aperto disprezzo. Ma la sua storia e la vita difficile che ha vissuto sollevano delle domande importanti anche su di noi.
Rita De Crescenzo è un fenomeno social allucinatorio. Si definisce “tiktokana” perché, dice, le piace inventare nuove parole. Intrattiene senza soluzione di continuità milioni di utenti con i suoi video dove talvolta balla e canta, ma più spesso semplicemente parla, grida, sproloquia, pubblicizza esercizi commerciali di varia natura – dal concessionario al ristorante, passando per la boutique. Lo smartphone come prolungamento del sé, con il quale si fa riprendere in ogni momento della sua vita. Ciò che dice è meno importante di come lo dice: senza giri di parole. D’altronde il napoletano, la sua lingua madre, i giri di parole non li contempla. Una lingua, la sua, sguaiata, accompagnata da una gestualità eccessiva, come eccessivo in De Crescenzo è l’abbigliamento, il trucco, e i lineamenti del viso, alterati dalla chirurgia estetica. Ma qual è il canone rispetto al quale l’influencer napoletana eccede? Quando Francesca Fagnani, che l’ha intervistata nella sua trasmissione Belve, le chiede se le dispiaccia essere etichettata come trash, De Crescenzo risponde di no: “Quando loro dicono trash intendono questo”, e si tocca i grandi orecchini pendenti dorati. “L’oro che luccica. Questo è il trash per loro”: l’eccesso. Interessante questo “loro”: a chi si fa riferimento? E a quale “noi” si contrappone? Forse è sempre l’alterità a definirci, il diverso da noi. Ma quando quell’altro che ha il potere di definirci è anche quello che ha il potere – il potere di scrivere sui giornali, di dare un nome alle cose, di regolare il canone estetico ed etico dominante –, allora l’unica emancipazione possibile, stando alle regole del sistema che impone una rigida e inscalfibile gerarchia sociale, è quella economica.
L’indotto economico delle attività di Rita di Crescenzo non si conosce, ma deve essere ingente. L’influencer viene pagata, oltre che dalle piattaforme che alimenta, per presenziare a cresime, comunioni, battesimi e celebrazioni varie; a Napoli ma anche nel resto d’Italia. Le ospitate alle feste non sono che il prolungamento di ciò che De Crescenzo fa sui social: “fare compagnia alla gente, farla ridere” – spiega lei stessa. I carcerati che scontano la pena in comunità per tossicodipendenti guardano insieme le sue dirette sul proiettore, le vecchiette e le casalinghe la ascoltano mentre stirano o cucinano, molti la amano e tutti gli altri (i “loro”, noi), con una punta di disprezzo e spaesamento, non si spiegano il suo successo.
Aldo Cazzullo, in un articolo citato da Fagnani, parla di “rincoglionimento di massa, elevato a stile di vita da parte di personaggi come De Crescenzo”. De Crescenzo non capisce la parola “rincoglionimento” e durante l’intervista non sarà l’unica parola a risultarle oscura: chiede all’intervistatrice cosa significhino “divisiva”, “inconfutabile” e “incontrovertibile”, e rimane interdetta anche di fronte alla parola “pregio”.
Ma a sua discolpa racconta che sta studiando per imparare “un italiano sistemato”: vengono degli insegnanti a casa a farle scuola, a insegnarle ciò che non ha imparato da ragazza. Racconta di un’infanzia dolorosa, nel quartiere del Pallonetto, un intrico di vicoli dove il sole del buon dio non dà i suoi raggi, a cui Gianni Rodari dedicò una filastrocca in cui rimarcava, per l’appunto, l’assenza di luce: Chi farà musica e parole/ per te Napoli senza sole?/ A Marechiaro spunta la luna,/ ma il Pallonetto non ha fortuna.
De Crescenzo cresce sfortunata, con i nonni e le zie perché la madre viene ricoverata in una clinica psichiatrica in quanto schizofrenica mentre il padre, malato, si era già dileguato in Francia. Rimane incinta a dodici anni senza capirci nulla, e a metterla incinta è un ragazzo di famiglia camorrista. Al settimo mese di gravidanza il padre, richiamato ai suoi doveri dalle sorelle, la porta dal ginecologo chiedendo di farla abortire: quale abortire, risponde il medico, tra poco più di un mese la ragazzina partorisce. A tredici anni è madre, a sedici è sposata con un altro ragazzo e partorisce il secondo figlio. Ma di quel periodo ricorda poco, perché per trent’anni ha abusato di cocaina e psicofarmaci che le hanno “scombussolato il cervello”. I figli crescono senza andare a scuola: “Ero malata, non stavo bene”. Dopo una notte infernale in cui venne violentata da tre uomini e si ritrovò nuda nei pressi della stazione, senza ricordare come ci fosse arrivata, De Crescenzo ha smesso di fare uso di sostanze. Da allora sono passati sette anni, gli unici che lei senta di aver vissuto davvero, dal momento che per il resto della sua vita non era in sé, non rispondeva di sé, era, come dice, malata. Sono anche gli anni della fama e del riscatto economico, gli anni delle dirette quotidiane su Tiktok e dell’inaugurazione del suo negozio a Napoli, vestita da sposa, corona in testa, folle acclamanti a stento contenute dalla polizia.
“L’indotto economico delle attività di Rita di Crescenzo non si conosce, ma deve essere ingente. L’influencer viene pagata, oltre che dalle piattaforme che alimenta, per presenziare a cresime, comunioni, battesimi e celebrazioni varie”.
Ci sono molte cose difficili da comprendere nel personaggio di Rita De Crescenzo se non si tiene conto della sua biografia e dell’ambiente di provenienza, delle condizioni economiche, culturali, sociali nelle quali una parte per nulla insignificante della popolazione di questo Paese vive. Lo dice lei stessa, quando Fagnani la incalza su un suo possibile impegno in politica. Dice qualcosa di molto essenziale che solleva una questione effettivamente politica, se politica significa ancora partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita in comune“. C’è tanta gente come me che non ha mai votato, gente come me che non conosce nemmeno cosa vuol dire politica, perché io non conosco cosa vuol dire politica. La mia intenzione è portare la gente del popolo, la gente dei vicoli, povera come me, a votare. Fare dei pullman, andando a prendere casa per casa la gente”. De Crescenzo non sa che non servono pullman, che si vota nei pressi di casa, che per fare politica serve un programma politico, sul quale interrogata non sa rispondere. Ma mette l’accento su una questione che forse prima di intimorirci – entrare in politica con che partito? Portare la gente povera a votare che cosa? – dovrebbe farci riflettere sui meccanismi di esclusione di cui De Crescenzo è cosciente, perché li vive, li vivono le persone con le quali è cresciuta, e che oggi la seguono, la ammirano, e che, come lei, sentono una distanza abissale dallo Stato.
I quaranta minuti di questa intervista ci riguardano, devono aiutarci a porci le domande giuste su povertà, margini e su cosa significhi non parlare la “lingua del padrone”. Mi permetto di usare questo termine che richiama un Novecento ormai dismesso, perché di questo si tratta: esiste una fetta di popolazione, in Italia, che non ha alcun rapporto con lo Stato che non sia di estraneità e sospetto, quando non di vera e propria rivalità. Non parlare la lingua del padrone significa, a mio avviso, in primo luogo non parlare la lingua dello Stato: l’italiano. De Crescenzo lo parla a stento, lo storpia, non lo comprende se non nelle sue formulazioni più basilari, di livello elementare. In un video pubblicato sul suo canale dice che un tempo l’italiano lo sapeva, quando era bambina, perché con il padre ascoltava le canzoni italiane di Venditti, Morandi, Celentano. È la stessa cosa che si dice in altri ambienti – più altolocati – ’ dell’inglese: “l’ho imparato ascoltando la musica e guardando i film”. Ma che cosa significa? Che l’italiano è per De Crescenzo – e per le persone di cui si fa portavoce – una lingua straniera di cui non ha avuto bisogno per sopravvivere, almeno fino al suo ingresso tardivo e chiassoso nella società del lavoro e del consumo, travalicando il limitato raggio d’azione del vicolo. Perché lo Stato, in molte periferie sociali del Paese, non interviene e non esiste se non come ente vessatorio. E allora si cresce soli, senza genitori. Si rimane incinte a dodici anni senza sapere cosa significhi, si viene portate ad abortire senza sapere cosa significhi, si conosce la cocaina prima di conoscere le scuole superiori, gli ospedali, i consultori, lo sport, i libri, l’italiano. Si subiscono (e arrecano) violenze su base quotidiana, senza essere nemmeno in grado di riconoscerle come tali, considerandole il normale decorrere della vita, come un fiume di cui non si conosce l’origine né la direzione, ma che tutto sbatacchia e inghiotte nella sua corrente misteriosa e secolare.
Torna in mente la scena meravigliosa, di Cristo si è fermato a Eboli, nella quale Carlo Levi descrive l’incontro con l’esattore delle tasse, nella Lucania povera e contadina degli anni ‘30, dove nessuno ha il denaro che Roma esige, e dunque si paga – si viene derubati – quel che c’è: una capra, dell’olio, del formaggio. L’esattore è un omuncolo ai servizi di uno Stato che non fa nulla nemmeno per lui, ma che, come sempre accade, finisce per odiare i contadini che odiano lui, senza riconoscere che l’opposizione sarebbe piuttosto da riservare, appunto, ai padroni dell’uno e degli altri: i vertici della società, i ricchi.
“Per la gente di Lucania, Roma non è nulla: è la capitale dei signori, il centro di uno Stato straniero e malefico” scrive Levi. Allo stesso modo De Crescenzo dice di non sapere cosa sia la politica, perché per saperlo è necessario appartenere a una classe sociale che la politica tenga in considerazione, e il sottoproletariato non è tenuto in considerazione da una politica più interessata al mercato che ai diritti. Chi non ha potere d’acquisto non ha potere e il suo destino è spesso il carcere, la tossicodipendenza, la criminalità, la malattia mentale, la morte precoce. In carcere Rita De Crescenzo ci è finita con l’accusa di spaccio. Si dichiara innocente, e sostiene che il suo consumo di sostanze fosse tale da guadagnarsi erroneamente l’accusa di aver venduto a sua volta droghe, coinvolgendo anche i propri figli nell’attività. Non sappiamo quale sia la verità, e forse per un momento potremmo sospendere il giudizio. Non perché i poveri non abbiano colpe, ma perché quasi sempre la colpa individuale chiama in causa una responsabilità collettiva: ogni esclusione genera dolore, e il dolore di chi sta ai margini riguarda tutte e tutti, è un dolore politico, che andrebbe affrontato con gli strumenti della politica, non con quelli dello snobismo, del disprezzo o della derisione.
Frequento e mi occupo di carcere come giornalista da quattro anni, e le domande che mi sono posta di fronte all’intervista di De Crescenzo sono le stesse che solleva in me il confronto con i detenuti. La prima domanda da porsi riguarda le traiettorie biografiche che conducono a quella discarica sociale che è la prigione, un sottomondo reietto dove la violenza o l’illecito sono spesso frutto di violenze subite e illiceità sistemiche nel mondo di provenienza. Non sappiamo nulla su chi non parla italiano perché, con queste persone, non abbiamo una lingua comune. E non abbiamo una lingua comune perché ci affatica cercarla: ci richiederebbe di recarci nei luoghi dell’esclusione, i ghetti dei migranti, i vicoli di Napoli o Palermo o ancora la periferia di Torino, di Milano, di Roma. E recarsi lì con ottime intenzioni nemmeno basterebbe: necessario sarebbe un ascolto sincero di cosa significhi spendere la vita altrimenti, non aver mai letto un giornale, bramare l’arricchimento senza vergogna, contare i soldi senza vergogna, come scriveva Pasolini ne Le ceneri di Gramsci: andare duri e pronti nella ressa/ delle strade, rivolgersi a un altro uomo/ senza tremare, non vergognarsi/ di guardare il denaro contato.
Del denaro si vergogna solo chi l’ha sempre avuto. Di chi non l’ha avuto e non si vergogna di contarlo abbiamo paura o tenerezza. Ho detto queste cose a un amico che stimo e con cui mi sono confrontata prima di scrivere questo pezzo. Mi ha detto: “stai attenta, suona classista.” Credo invece che la politica si nutra anche di sentimenti e la tenerezza non significhi necessariamente guardare dall’alto, ma riconoscere all’altro la propria irriducibile umanità. E da qui, cercando una lingua comune, ripartire.