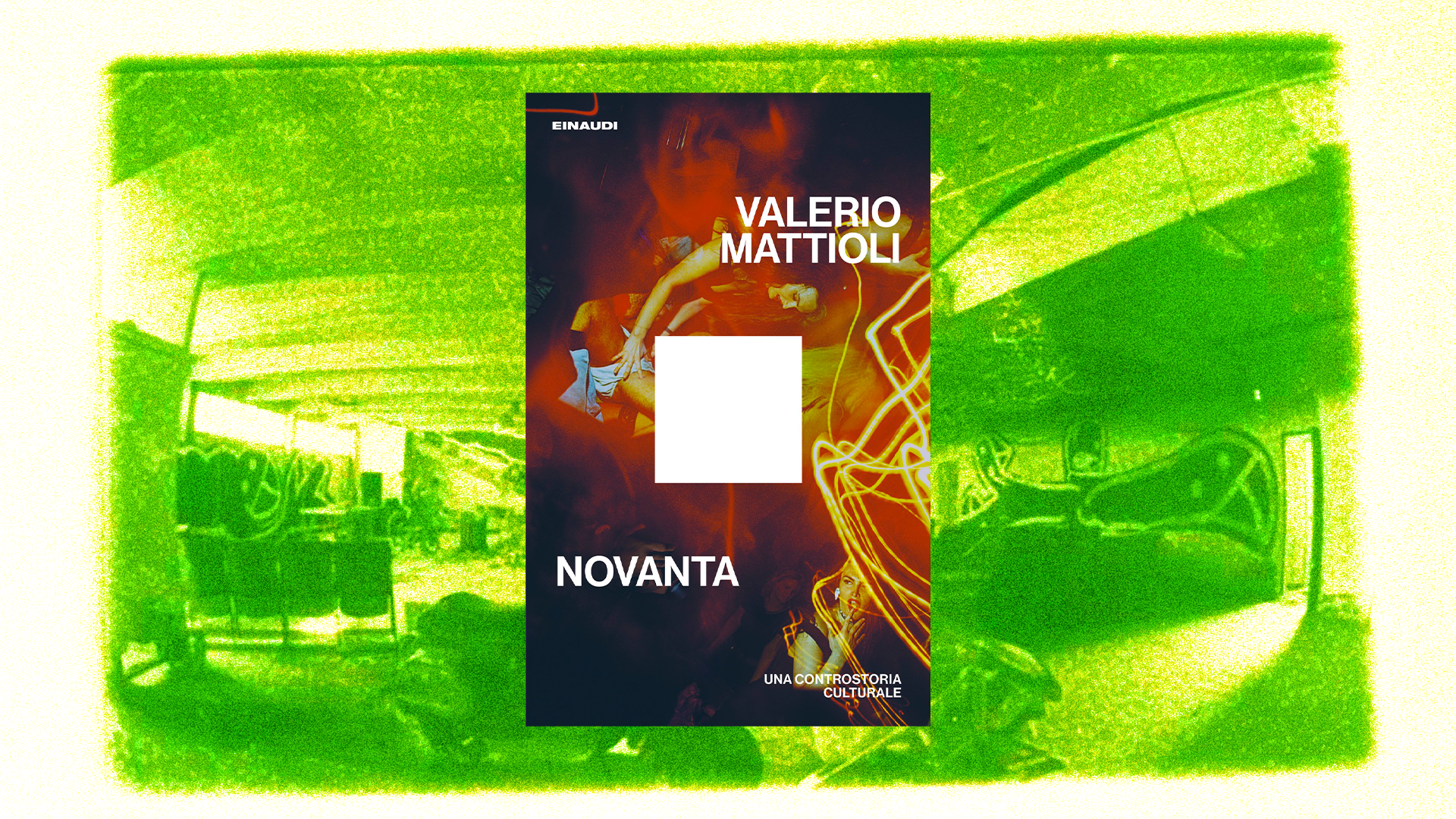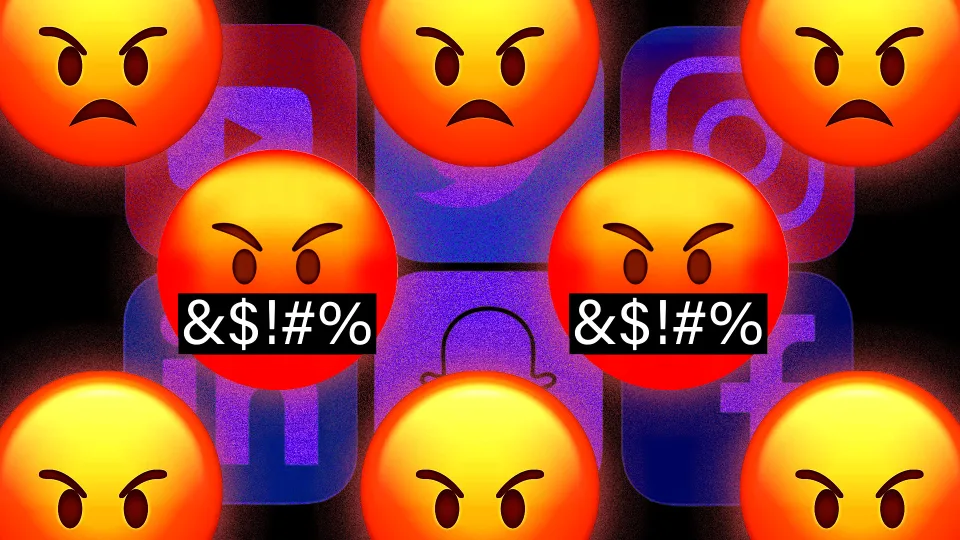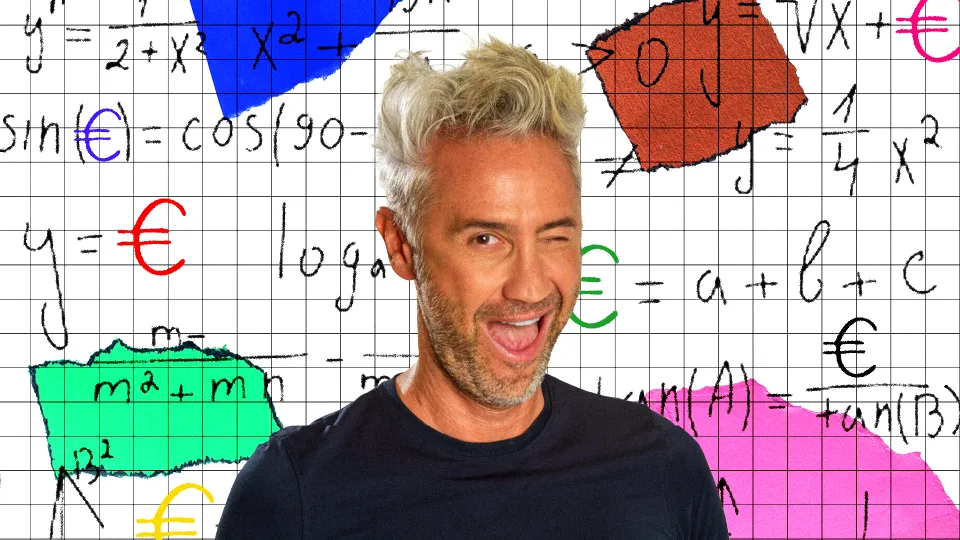C’è stato un decennio in cui in quasi ogni città italiana poteva trovarsi un centro sociale. Il nuovo libro di Valerio Mattioli, "Novanta", da poco uscito per Einaudi, ripercorre quell’esperienza: una stagione in cui luoghi come il Link a Bologna o il Leoncavallo a Milano davano spazio, senza steccati o snobismi, al meglio della nostra cultura alternativa.
Quando nella seconda metà degli anni Novanta volevi uscire con gli amici e si decideva insieme non tanto se andare in un centro sociale, ma in quale centro sociale andare; e quando per decidere dove andare guardavi le ultime pagine de il manifesto, dov’erano diligentemente elencate le varie attività dei suddetti centri sociali; o quando ancora ci si trovava in giro per l’Italia e la prima cosa che si faceva era cercare il centro sociale del posto, perché, per quanto piccola e provinciale potesse essere la città in questione, era praticamente certo che almeno un centro sociale lo si sarebbe trovato; e quando finalmente si andavano a vedere le band che suonavano in questi centri sociali dietro offerta di cifre commisurate a un portafogli adolescenziale (cifra che potevi perfino ridurre versando un obolo cumulativo con la cordata di amici), o i cineforum o le feste dove si ballava, o il teatro, o gli infoshop, o anche semplicemente per bere una birra alla spina e fumarsi una canna (o magari un chilum, che all’epoca andava per la maggiore): quando si viveva in questo modo non ci si rendeva propriamente conto del fatto che quello che stava accadendo era una straordinaria eccezione, che nella maggior parte degli altri Paesi del mondo non esisteva nulla di simile e che comunque, anche in Italia, ci si trovava nel cuore di una stagione unica, iniziata con la fine del “tempo della disperazione e del riflusso, dell’eroina e della Milano da bere” e che nel giro di pochi anni sarebbe finita, o comunque si sarebbe drasticamente ridimensionata, con “la catastrofe” del G8 di Genova. E tutto il resto a venire.
A storicizzare una volta per tutte l’eccezionalismo della controcultura centrosocialara italiana di quegli anni ci ha pensato Valerio Mattioli con il suo Novanta. Una controstoria culturale, lungo racconto, fitto di luoghi e persone, che ricostruisce con piglio narrativo e uno stile allo stesso tempo svelto e raffinato la “scena” della cultura underground in Italia. Se pure non coincideva completamente con quella dei centri sociali, tale scena era infatti profondamente condizionata e in buona parte incubata da questi luoghi, dove cresceva una generazione dalla “qualità sovversiva subliminale. Istintiva. Con una comunicazione che si basava sui gesti e corpi e non sull’espressione di un pensiero compiuto. Con un’identità che si nutriva di comportamenti immediati più che di consapevolezza. […] Una generazione che non si poneva come obiettivo, nemmeno nel lungo periodo, una prospettiva politica di presa del potere. Lo combatteva e punto”. Sono parole di Miltant A, storico cantante degli Assalti frontali abbondantemente citato nel libro di Mattioli.
Dopo più idiosincratiche fatiche (“Remoria”, una fantasiosa storia alchemica della borgata romana, e “Ex Machina”, una specie di trattatello critico-filosofico sulla trimurti della musica elettronica Autechre/Aphex/Boards of Canada) Mattioli torna a quasi dieci anni di distanza sulla strada che aveva già intrapreso con “Superonda” (Baldini&Castoldi), di cui quest’ultimo lavoro può ben considerarsi, mi sembra, la prosecuzione. Se infatti “Superonda” imbastiva una storia della cultura underground italiana a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, “Novanta” prende la rincorsa di un centinaio di pagine muovendo dal ’77 e dagli Ottanta, prima di passare all’eponimo decennio, che l’autore fa iniziare con il movimento della Pantera e finire con i fatti del G8.
Il confronto con il ’77 è un motivo piuttosto ricorrente nel libro: la riabilitazione di quegli anni troppo frettolosamente liquidati nella condanna della lotta armata, ma rimasti vivi nella memoria, nelle pratiche e nello stile dell’antagonismo dei decenni a seguire (oltre alle conquiste ormai si spera universalmente riconosciute come i referendum su aborto e divorzio, la legge Basaglia, lo statuto dei lavoratori): “In fondo, i centri sociali degli anni Novanta possono essere letti come singolo capitolo di un continuum sotterraneo tutto italiano: una sorta di controstoria nella quale gli anni Settanta assumono di volta in volta il ruolo di mito di fondazione o di ingombrante eredità da cui sembra impossibile liberarsi, ma che in qualche modo va affrontata, senz’altro rivendicata”, scrive Mattioli.
Allo stesso modo di Superonda, anche Novanta narra di come gli ambienti underground, le scene più eretiche e clandestine del periodo, hanno occultamente irrorato il panorama culturale mainstream fino a determinarlo, almeno nelle sue manifestazioni più interessanti. Se in “Superonda” gli eroi assoluti erano Battiato e Morricone in quanto creature anfibie, capaci di muoversi con disinvoltura tra sopra e sotto, tra pop e avanguardia, tra sperimentazione e grandi successi, in Novanta la situazione è più complessa e il rapporto tra la scena off di squat e CSO e resto del mondo è sviscerata da molti più punti di vista, e più problematizzata.
Riflessioni politiche, ricostruzioni ambientali, gruppi, gruppetti, meticolose cronache di “affinità-divergenze” tra i compagni di diverso orientamento sono il cuore di questo libro dove, in un arco che va dall’intransigenza squatter alle “sussunzioni mainstream” dell’overground, la polarità fondamentale è forse rappresentata dall’antagonismo controculturale di posti come il romano Forte Prenestino e le colte sperimentazioni di laboratori come il bolognese Link.
La storia di come dalle “semplici” occupazioni abitative degli anni precedenti si è arrivati a quei laboratori di pratiche militanti e creazioni artistiche che sono (stati) i centri sociali in senso stretto inizia più o meno con il milanese Leoncavallo, nato nel 1975 (e come sappiamo assurdamente sgomberato questa estate), ma si concretizza alla fine degli anni Ottanta e cristallizza nei Novanta in un modello rizomatico, come si sarebbe detto allora, dove luoghi come il Forte Prenestino (o il Cox 18 di Milano, il CPA di Firenze, il Livello 57 ancora a Bologna) rappresentavano il versante più sotterraneo e militante, mentre il Link mostrava il lato più pulito, inclusivo e stiloso dell’”underground radicale”, secondo la definizione di Mattioli.
Intuiamo tra le righe l’ammirazione dell’autore per la versione meno dogmatica della controcultura, quando in posti come l’Isola nel Kantiere (centro sociale bolognese al centro di molte vicende qui raccontate) riconosce “una lezione destinata ad avere ripercussioni decisive su un immaginario che non poteva più accontentarsi di retoriche barricadere e antagonismo a muso duro: la convinzione cioè che, quali che ne fossero le espressioni, quel mondo aveva il dovere morale di aprirsi e misurarsi col meglio dei linguaggi partoriti dalla contemporaneità, spingersi sempre un passo oltre, osare dove nessuno aveva ancora messo il naso senza timore di apparire degli esteti snob”.
Su questa scia, proprio il Link, che pure non era un centro sociale (ma che spesso veniva impropriamente definito tale) è stato insomma capace di intercettare alcune delle tendenze più aggiornate che irradiavano l’Europa e perfino di crearne a sua volta: “La stessa ricercatezza della sua programmazione era un unicum nel panorama italiano, e non solo in ambito underground: il suo modello verrà replicato, scopiazzato, e infine pervertito da innumerevoli tentativi di dare una patina di rispettabilità istituzionale alla nuova avanguardia “multidisciplinare”, e se si dovesse stilare una lista degli enti, dei teatri, dei musei la cui mission è ancora oggi una copia sbiadita di posti come il Link e il suo fratello elettivo Interzona, non si finirebbe più”.
“La storia di come dalle ‘semplici’ occupazioni abitative degli anni precedenti si è arrivati a quei laboratori di pratiche militanti e creazioni artistiche che sono (stati) i centri sociali in senso stretto inizia più o meno con il milanese Leoncavallo”.
Ad ogni modo, la tesi di fondo, che vale per il Link come per ogni altro centro sociale dell’epoca, nonché per i più torvi e aggressivi squat torinesi, è quella secondo cui, nel corso degli anni Novanta, il meglio della cultura italiana è passata da lì, anzi: il meglio della cultura italiana non sarebbe proprio esistita se non ci fossero state queste realtà a dargli spazio.
La lista degli esempi di come dai movimenti underground vicini ai centri sociali sono emersi pezzi importanti della cultura di massa sarebbe lunga: dalle band rock-pop e reggae come Subsonica, Afterhours, Marlene Kuntz, 99 posse, Sud Sound System, Africa Unite, passando per la riflessione sulle nuove tecnologie e le prime aspirazioni cyber e post-umane, in particolare con il gruppo della rivista milanese «Decoder» e con personaggi come il Ermanno “Gomma” Guarnieri che finiranno a scrivere per, o a parlare in, televisione, e giù fino alla proliferazione dell’editoria indipendente, che all’epoca dava filo da torcere ai grandi editori storici. Se volevano mantenere un profilo appena intellettualmente credibile, alle case editrici italiane convenivano allora due strade: o imitare gli indipendenti nell’offerta, o cooptare figure provenienti da questa scena. Un esempio è il duo Repetti/Cesari che con Einaudi stile libero e, in particolare, con libri come Gioventù Cannibale e Q di Luther Blisset saranno l’emblema controverso dell’underground che sfonda nei circuiti commerciali. Ma parliamo di marchi come Shake (nata da «Decoder»), Castelvecchi, Theoria, DeriveApprodi, o le più accademiche Mimesis e Meltemi, e poi Minimum Fax, Fanucci, Fazi: la dinamicissima piccola editoria dell’epoca aveva radici profonde nella fertile fanga dei centri sociali.
L’affresco di Mattioli ha l’ambizione di essere quanto più possibile completo: molte pagine sono dedicate alle arti visive, al teatro d’avanguardia di compagnie come la Societas Raffaello Sanzio, Motus, Valdoca, ai fumetti, alle attività di smanettoni e hacker, e alla complicata geografia di quella che qualche anno dopo si comincerà a chiamare cultura “queer”, e che ben prima di diventare priorità nell’agenda politica della sinistra parlamentare si è faticosamente aperta una strada nella pur maschiocentrica ed eternomormativa (almeno fino a un certo punto del decennio) cultura antagonista.
Molte pagine sono inevitabilmente dedicate ai free party e alle feste illegali che del decennio e della sua vocazione underground sono state quasi un emblema. La porosità socioculturale in questo caso muoveva verso il basso, più che verso l’alto: “la formidabile accoppiata techno & droga riuscì dove le vetuste pratiche dell’’antifascismo militante’ avevano finora fallito, ovvero a “strappare al ‘muretto fascista’ il ragazzo di periferia”. Ai rave si presentavano i coatti di borgata e come racconta il Duka, figura storica dell’underground romano: “lo capivi subito che tipi erano. Ma anziché cacciarli a calci in culo (…) gli si diceva: va bene, puoi entrare. Ma se vuoi entrare, tieni bene a mente questo: non rompere il cazzo; non atteggiarti a violento; non scandalizzarti se due maschi si baciano”.
Il discorso sulle musiche è preponderante in Novanta e non solo perché Mattioli è di formazione critico musicale. La musica era un pilastro dei centri sociali, e il suo impatto “fu tale da mandare in crisi l’intera industria discografica mainstream, che per qualche tempo parve davvero capitolare dinanzi a tanta energia sprigionata dal basso”. La musica rap, su tutte, è la protagonista assoluta di queste pagine, e giustamente, se pensiamo alle dimensioni colossali (infestanti?) che la creatura germogliata in quegli anni e in quegli spazi finirà per assumere nella futura (e presente) cultura musicale nazionale. È stato con il rap, più di tutto il resto, che la cultura underground “esondò come un fiume in piena gli scrostati recinti dei centri sociali per diventare la colonna sonora di un intero periodo storico”, e lo fece “alterando la scala di valori che storicamente separava underground e mainstream, e ribaltando le consolidate gerarchie tra periferia e centro, con il secondo che soccombeva alla potenza creativa della prima”.
Mattioli sembra particolarmente interessato ad approfondire le complicate influenze interne ed esterne ai centri sociali tra cui il genere è nato, ha preso sostanza e si è infine emancipato dai goffi complessi di inferiorità rispetto agli originali americani. Da una parte i “b-boys”, i puristi dell’hiphop per cui qualsiasi forma di politicizzazione era una perversione dell’ortodossia made in USA, dall’altra le cosiddette Posse, un termine “che Militant A recupera dallo slang giamaicano e afroamericano e che indica un drappello di uomini armati o più in generale una banda, un gruppo”. Quasi ogni centro sociale all’epoca esprimeva le sue Posse che, se pure non avevano la finezza produttiva dei puristi, definivano una via italiana al genere, elaborando un linguaggio più spontaneo e meno mimetico.
La singolarità di posti ibridi come il Link trova in questo senso un suo riflesso nel rap di artisti come Dj Gruff o Sangue Misto, capaci di tenere con naturalezza un piede nella “galassia antagonista” e l’altro nel purismo disimpegnato della cultura hip hop. È, d’altronde, questa postura dialettica, inscritta nel progetto stesso del libro di Mattioli. Novanta non soltanto è una controstoria capace di restituire all’underground l’onore di essere stato la base da cui si è costruito “l’overground”, ma è anche una controstoria pubblicata da un editore come Einaudi, l’approdo privilegiato di qualsiasi scrittore che ambisca al riconoscimento mainstream. D’altronde l’autore conferma una vocazione al mainstream anche nella sua attività di editor presso NERO, casa editrice che si colloca abbastanza precisamente sul crinale tra under e over. Insomma, Mattioli, che pure a suo tempo ha collaborato a una rivista assolutamente estrema e facinorosa come “Torazine”, non sembra credere molto ai vecchi discorsi sulla “sussunzione”: al contrario, esibisce una strategia più pragmatica e smaliziata di conquista dell'”egemonia”, la stessa che nel decennio in questione è sembrata effettivamente a portata di mano.
L’arma retorica di cui si serve lo scrittore romano per “riposizionare” nella storia ufficiale l’underground dei novanta – come già in “Superonda” (e in maniera addirittura ipertrofica in Remoria) – è il mito. Mattioli è bravissimo nel creare un’aura leggendaria intorno alle gesta dei suoi personaggi. Tutto ciò che racconta questo autore sembra spolverato di epopea, immerso in una patina di sgargiante utopismo. L’impressione può sembrare a tratti quella di una celebrazione indiscriminata, come se tra i nomi che ribollono in questo calderone i personaggi davvero importanti si trovassero sullo stesso piano di quelli secondari e fenomeni effimeri fossero costretti a condividere il piedistallo con altri che un posto nella storia l’hanno ottenuto senz’altro. Mettiamolo in conto alla dimensione sociale e alla vocazione politica della storia narrata. In ogni caso, se l’intenzione era di smontare le gerarchie ufficiali, nuovi miti dovranno prendere il posto dei vecchi. E ciò valga anche per il sentore passatista, nostalgico e un po’”boomer” del genere “io alla tua età saltavo i fossi per il lungo” che rischia di arrivare ai ventenni che si troveranno, speriamo, di fronte a queste pagine.