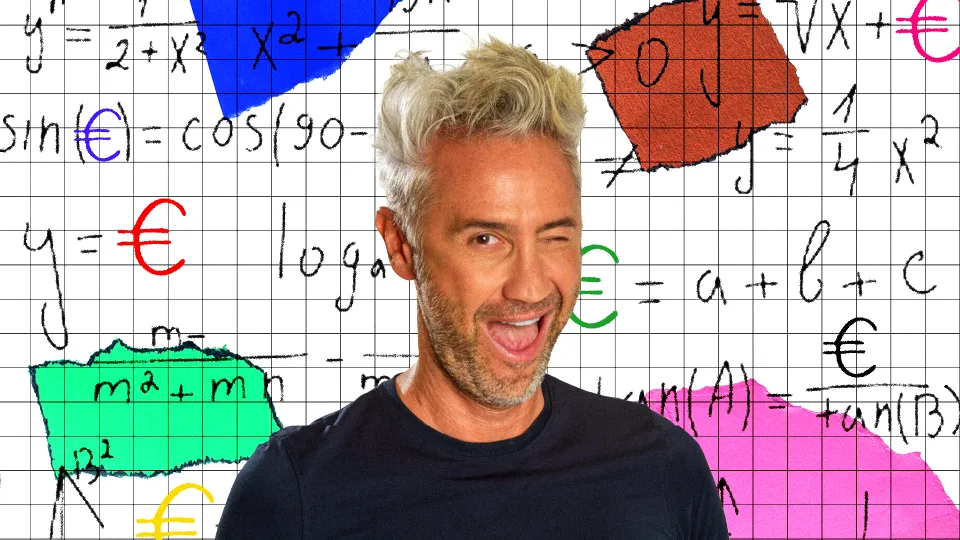Lasciarsi dopo anni di relazione è dolorosissimo. E per chi resta nella casa un tempo condivisa lo è ancora di più, perché ogni oggetto racconta dell'amore finito.
Contenitore di spille sagomato stile barocco a fiore blu e panna, porta ciondoli in ceramica a forma di cuore, salvadanaio panciuto del Maghreb azzurro e bianco, portaoggetti africano oro e nero, di dubbio gusto, contenente anelli, polsini, ciondolo Tiffany, bracciali a polsino, in pelle, d’argento e in legno, rotondi, piccoli e grandi, collane choker e girocollo, buste con inviti, lettere, banconote turche e thailandesi, collane di perle, gli orecchini arancioni che le ho regalato (mai piaciuti, mai indossati), la Montblanc che mi ha regalato (mai piaciuta, mai usata), un metro da sarta arrotolato, una mazzetta di illustrazioni di nudo 13×17 dono di chissà chi, un borsellino in tela bianco e nero per monete (vuoto), foto di lei in Sudafrica, foto di noi in Giordania, foto di lei in Marocco, foto di noi in Algeria, foto di lei con le amiche, foto di noi con i gatti.
Il comò della camera da letto è un altare di ricordi a cui da tempo non badavo – i ricordi con l’abitudine perdono voce e fascino; oggi è un sacrario doloroso perché sempre in vista, sotto lo specchio che ora riflette solo e sempre me.
Poco più in là lo scompiglio di abiti tuttora sparsi nella stanza del piccolo ma accogliente appartamento; vista sulla vallata, dalle finestre ogni tipo di verde, ogni sfumatura di azzurro del cielo. Accogliente per me. Abbassando leggermente la mia prospettiva che stagna nell’infinito tempo trascorso sul letto a fissare due crepe del soffitto, nell’imminente trovo sulla sedia i suoi jeans corti usurati, la camicetta bianca con rouches, mutande e reggiseno neri impiccati alla manopola del termosifone; nell’armadio ancora aperto giacciono in penombra le sagome di gonne, giacche, pantaloni, ogni abito rianima una serata, un giorno, l’essenza di una promessa esausta. Ogni oggetto è un superstite. Ogni superstite, un testimone d’accusa.
Sembra la camera da letto ancora calda di una narco colombiana scappata da una retata della DEA. Io sono la DEA.
Nella doccia, dal portaoggetti esce obliqua come la capoccia di una lucertola una lametta Wilkinson, come un ragno sul bordo in metallo si aggrappa una pinza nera per capelli, la cuffia doccia maculata gialla e nera è la sensuale testa di un leopardo, gli shampoo buoni scomparsi. Nello scaffale in legno davanti al water, oltre alla bonaria baraonda dei prodotti per le pulizie scorgo due bare rettangolari (vuote) di piastre professionali, sotto due parallelepipedi di plastica trasparenti, a custodire un tetris scompigliato di flaconcini, creme, terra L’Oréal, oli, balsami, assorbenti, barattoli colorati di cui non so nulla. Sul vetro orizzontale sopra al lavandino spariti profumi ed eyeliner, mi commuovo per la solitudine del rocchetto di filo interdentale, abbandonato nell’angolo dove prima torreggiavano profumi e spray. In un cassetto scopro un forziere di campioncini Chanel, forcine, olio per le labbra, raschietto per i piedi, pinzette per le sopracciglia, rossetti e due differenti lime per le unghie. Mi domando dove io fossi quando tutti questi oggetti si intrufolavano nei 58 metri quadri dell’appartamento.
Dalla cassa wi-fi che le ho regalato dopo un pagamento insperato suona Les mots d’amour di Edith Piaf cantata però da Mayra Andrade, interprete capoverdiana, la sua voce come una stanza buia zeppa di carillon, ci entri e non sai se vuoi restarci o fuggire. Devo restarci nella casa, e voglio fuggire quando noto, faccio caso, è sparita la vestaglia di seta nera trasparente, quella delle serate speciali; noto, faccio caso, come la mia mente diventi un dispositivo del complotto, inizia a ricamare, prende dettagli veri, minuscoli, e li lega uno all’altro fino a cucire un’immagine precisa, un disegno chiarissimo, dolorosissimo, sul prossimo impiego della vestaglia di seta nera trasparente. Sono trascorsi pochi giorni, non è possibile uno stravolgimento così radicale, penso. Altri pochi giorni e scopro di non essere un complottista.
Gli oggetti che fino a qualche giorno fa sembravano spenti, inermi, si fanno motore che spinge al massimo memoria e ipersensibilità. Un motore che non ha nessuna intenzione di sbiellare, che preme con i suoi pistoni sulla colpa della mia indifferenza, restituendomi un’acida, ineluttabile (ri)comprensione del mondo. Allora mi viene in mente la pratica che in svedese si chiama döstädning, pulizia della morte, eliminare il superfluo prima della dipartita per non lasciare ai familiari il peso del decesso. La psicologia (e quindi la psicoterapia) tratta l’abbandono al pari del lutto. In questo appartamento con le finestre affacciate sul verde e l’azzurro della valle, nessun decesso annunciato: l’operazione di pulizia deve essere compiuta per forza di cose a posteriori. Il punto allora è eliminare, per mitigare, subito, oggi e domani, il carico di simboli e di abitudini che ancora impregnano muri e porte, pensili e piante, la maledetta libreria su cui dovremo obbligatoriamente ragionare insieme. Nessuno dei miei libri deve lasciare la casa. Come Rob, il protagonista di Alta fedeltà di Nick Hornby, che dopo essere stato lasciato da Laura si dedica freneticamente a un nuovo sistema di archiviazione dei dischi che non preveda più l’ordine alfabetico, altresì io dovrei rimestare i libri a mio sentire, magari come erano al principio, inseriti per nazionalità/genere/epoca, un ordine caotico che appagava solo me, di cui io solo conoscevo la teoria. Lei decise di cambiare, incoraggiando una promiscua fusione con i suoi tanti titoli, fiduciosa che non ci saremmo mai lasciati. Una disposizione che non ho mai gradito, che mi ha scompigliato, generando una confusione emotiva, forse la stessa per cui sono stato biasimato negli ultimi mesi. Ecco, forse ho trovato il bandolo della vicenda: la causa di tutto è la libreria. Mi contento.
Oggetti caduti nell’indifferenza dopo un breve attimo di notorietà sono rimasti a guardarci: osservavano noi silenziosamente, ci hanno spiati, ci hanno visti superare crisi e problemi, guarire da malattie. Con impeto maniacale dovrei inscatolare ogni piccolo frammento di questi traditori, segni del suo passaggio, cartone e scotch, lo consigliano anche gli amici, abbandona tutto al bar, sul marciapiede, pure se piove, il compare più partigiano suggerisce: appicchiamoci il fuoco.
Se dall’aldilà non si torna, nella separazione il tempo non procede più in avanti, non è più lineare, si avvita su sé stesso. Diventa l’Uroboro, il serpente che si morde la coda, cerchio chiuso che fa credere nella rigenerazione. È lì che nasce la fantasia più ingannevole: pensare che si possa tornare indietro, pensare che si possa tornare insieme.
Se le sue cose sono ancora qui, deve esserci un motivo, una promessa implicita che qualcosa, un giorno, possa ancora muoversi. Mi aggrappo alla forza magnetica degli oggetti, a quella in virtù della quale li abbiamo acquistati, e quella che hanno acquisito grazie al tempo che li ha intrisi di ricordi, abitudini, significati. Spero la richiamino, seducendola al posto mio. Allo stesso tempo mi sento come Gloria che aspetta Edmundo in Grazie per il fuoco di Mario Benedetti: io sono meno importante dell’armadio o delle sedie. So di camminare sulla ripida cresta della montagna, il vento cambia direzione, l’aria sa di pioggia. Fuori dalla mia finestra risplende però un sole accecante.
“Dalla cassa wi-fi che le ho regalato dopo un pagamento insperato suona ‘Les mots d’amour’ di Edith Piaf cantata però da Mayra Andrade, interprete capoverdiana, la sua voce come una stanza buia zeppa di carillon, ci entri e non sai se vuoi restarci o fuggire”.
Sole che si rispecchia sui miei dispositivi, che hanno registrato il mio passare inquieto da un social all’altro e hanno già capito tutto. Si mettono all’opera: Sei stato lasciato? La vuoi recuperare? Mi chiede l’uomo piacente, barbetta e occhiali, protagonista di un reel pubblicitario. Non le scrivere, non la chiamare, mi ordina una donna dai capelli lunghi e le unghie rosse. L’algoritmo sa che sono un maschio etero.
Questi signori per lo meno mi distraggono. Quattro minuti buoni di sproloqui digitali sullo strazio dell’abbandono e sulla dignità da non perdere, o da recuperare, ammesso che ne sia rimasta.
E poi, ecco finalmente i reel che promettono la formula per farla tornare. C’è un metodo, dicono lui e lei, studiato, quasi scientifico, infallibile. Compaiono le testimonianze: mail sgrammaticate di uomini risorti dal loro patimento. Se ce l’hanno fatta loro puoi farcela anche tu. Quando i testimoni compaiono in video parlano dalle loro cucine rustiche, occhi pieni di entusiasmo, magliette o troppo strette o troppo larghe. “Grazie ad Alberto, ai suoi consigli, alle sue tecniche, lei è tornata.” Un uomo nerboruto annuncia tronfio: “Stiamo per sposarci.” Lei non compare mai.
Si va al sodo, il metodo si configura principalmente in tre moduli che si riassumono in: cosa fare intanto, cosa scrivere, come invitarla e cosa dirle. Moduli che non vengono rivelati, accessibili solo a delle prevedibili condizioni e noi che stiamo qui col cuore a pezzi iniziamo a vacillare: perso per perso, spendere qualcosina può significare ritrovare la pace, mica la felicità, ma almeno un po’ di pace. Pure il sollievo è merce in fin dei conti. Prezzi non sovraesposti, basta inviare una mail o telefonare per un preventivo. Mi piacerebbe andare a fondo, capire su cosa basano il preventivo. Non lo faccio. Spengo lo schermo del pc, attivo la modalità aereo del telefono, rimango con le cose intorno a me e, solo per un istante, penso che bel dolore, pieno, totale. Per un istante solo, il dolore mi conforta, sono ancora vivo proprio grazie agli oggetti che segnano un tempo che non c’è più.
Ci sono anche attrezzi, oggetti, che sono indispensabili. Via la televisione, se la vuole, ma la lavatrice o la lavastoviglie? Per un attimo mi rimprovero per il mio egocentrismo: guerre, alluvioni, solo in Italia 5,7 milioni di persone vivono nella povertà e io penso alla lavatrice. Questa constatazione dovrebbe ridimensionarmi e invece no, il mio dolore non accenna a farsi da parte. È in cima a tutte le sciagure del mondo, il solo con diritto di precedenza.
Così come Mazzarò di Verga ricomincio a fare i conti: scopro che pentole, padelle e i piatti con arzigogoli celesti, riposti in ordine nei pensili, malgrado li abbia acquistati lei, non parlano. Solo loro sembrano fregarsene e li ringrazio con un rispettoso inchino preso in prestito da qualche film sull’antico oriente. La voce dello spremiagrumi la sento eccome: rievoca le domeniche in cui mi alzavo presto e preparavo la colazione per entrambi.
Sul mobile in soggiorno due custodie (vuote) di occhiali da sole di marca, un astuccio in stoffa colorata con le sue penne e le sue matite: prima di uscire lasciavamo Post-it gialli, con un pensiero, una presa in giro, semplicemente “passa una buona giornata amore mio”. Sono silenziosi pure i quadri nel soggiorno, più miei che suoi. Stacco invece dalla parete, con delicatezza, le fotografie, spolverandole affinché il ricordo non venga offuscato, pure se le sto per chiudere nel buio di un cassetto.
Con lo scopo di anticiparla, emergo dal torpore, mi decido e come Rob metto mano a una delle librerie. Obiettivo: farle trovare il lavoro compiuto affinché non possa replicare; ma cado nell’ovvia trappola. Sfilo il primo, apro a caso, paragrafo a caso, ma non sembra un caso, di Karl-Markus Gauss: “L’io del passato è sempre più grande e più ricco di quello del presente che subisce un processo continuo di rinuncia, di abbandono, di liberazione e di fuga, frutto della riduzione delle molte possibilità di cui disponeva, come pure l’io di domani scaturirà dalle limitazioni di quello di oggi”. In questo bordello di libri tanto valeva mettersi a caccia di Cioran e disperarsi comodamente sul divano (divano di nessun valore e quindi inoppugnabilmente mio).
Ecco come funziona, ogni materia o significato si declina, si piega, si contorce all’istanza dell’abbandono. Un amico dice: se resti rintanato lì dentro ogni cosa e ogni tua azione ti parlerà di lei. Iscriviti a shiatsu, yoga, un corso di cucina, macramè se necessario. Il compare più partigiano consiglia: fatti un profilo Tinder. E invece mi rifugio nel sicuro, riapro il suo di armadio, è fresco del suo odore, dei suoi profumi (come si fa a farli sparire?), trovo un kimono che le avevo regalato dopo uno dei miei viaggi, cerco di indossarlo, le mie spalle non sono le sue.
Concentrati su te stesso dicono gli amici, il compare più partigiano mi intima: andiamo a bere. Nel mio armadio sbuca senza motivo, senza cercarla, la mia di vestaglia di seta, nera e oro lunga fino alle caviglie. La indosso con Converse e pantaloncini colorati da running. Giro per casa, fumo, danzo meglio che posso con il fantasma di lei sulle note di Cold-Blooded Old Times di Bill Callahan, vado allo specchio sperando di rinvenire un accenno di bello, fuori e dentro di me. Che la buriana mi attraversi, che le cose tornino cose.
Finalmente, dopo giorni, mi viene voglia di cucinare: del resto con pentole e piatti avevamo già acceso il calumet della pace.