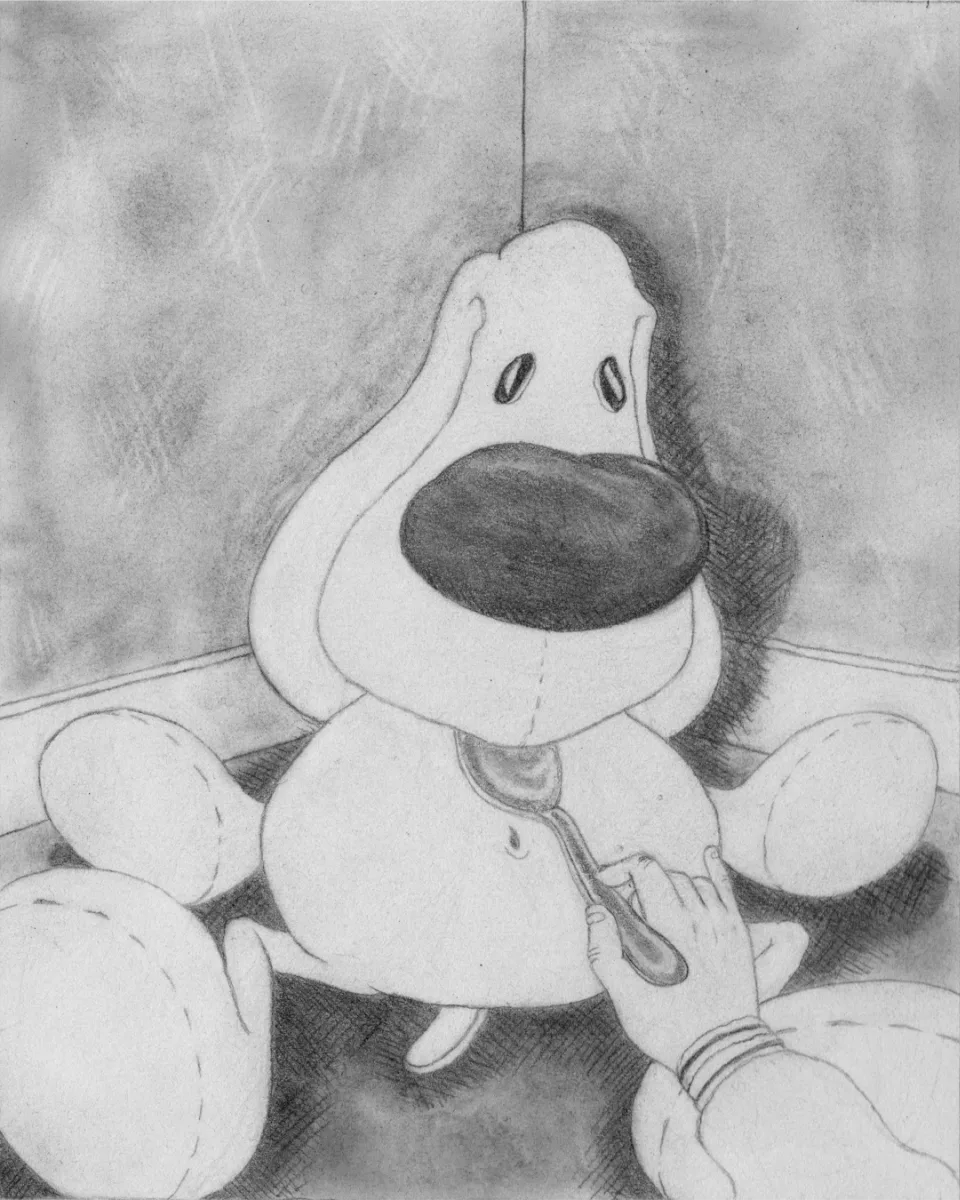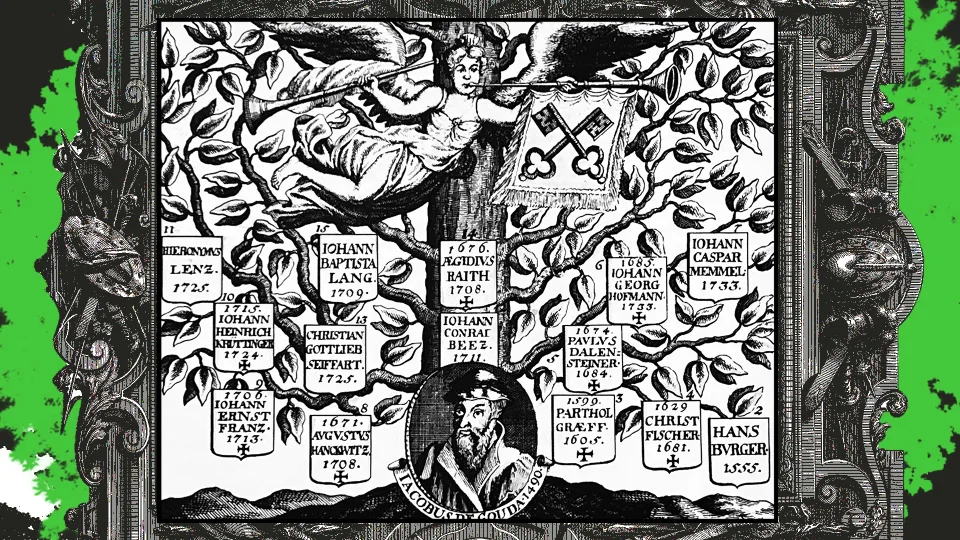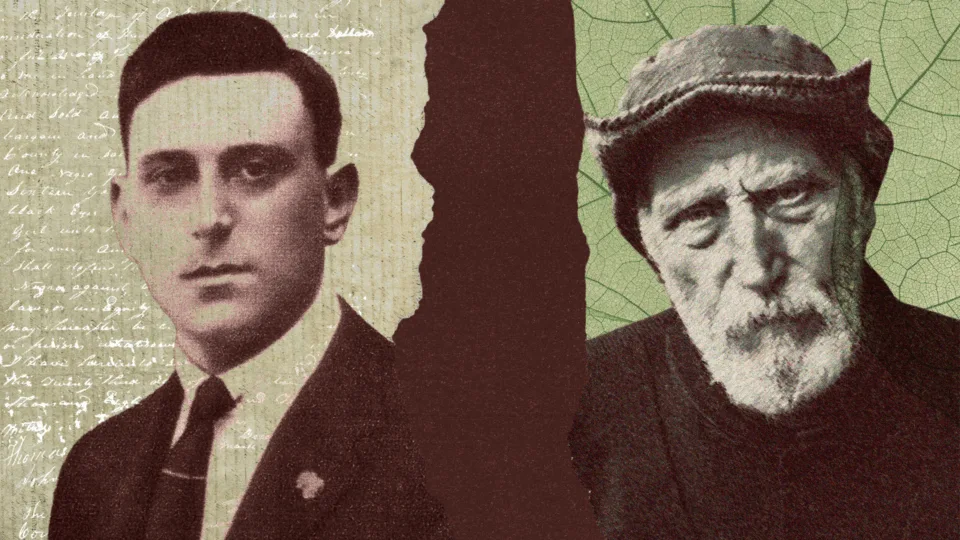La percezione del “momento giusto” per avere figli oscilla tra limiti biologici, pressioni sociali e trasformazioni culturali che ridefiniscono il concetto stesso di giovinezza. Così, in un’epoca in cui si diventa genitori sempre più tardi, il tempo è una variabile da negoziare con i propri desideri, le possibilità reali e le nuove tecnologie riproduttive.
La mezza età, sospetto, arriva subito dopo la maternità: così Rachel Cusk in un articolo di ormai diversi anni fa. È seduta sulla poltrona di un salone da parrucchiera. È andata con sua figlia. Lei ha trentacinque anni, sua figlia tre, la parrucchiera che lavora alle sue spalle venti. Nello specchio, Cusk vede sparire se stessa, occultata dal viso tondo come una ciliegia di sua figlia, per poi riapparire appena la figlia si allontana dall’inquadratura. Donna e madre a intermittenza. Donna di mezza età, al di là del dato anagrafico: come se il conteggio degli anni non progredisse più in modo lineare dopo aver avuto un figlio; potrei essere più giovane, dice, ma probabilmente mi sentirei comunque così. La frase può apparire innocua, persino banale (ah, le fatiche e le responsabilità dell’essere genitore!), ma in quell’istante in cui la donna, la madre, la scrittrice, si guardano allo specchio rincorrendosi e perdendosi e poi ritrovandosi ancora, c’è di più: di sicuro c’è la pressione del tempo non solo sul volto e sulla pelle – la mia faccia, ci dice Cusk, è cubista, fatta di pezzi caduti e poi mal assemblati – ma, soprattutto, la pressione del tempo sull’intera esperienza di vita.
Mi sono sentita così dopo il primo figlio. Invecchiata. E non avevo nemmeno trentacinque anni. Ma il tempo, mi pareva, aveva iniziato a scorrere diversamente per me e per quelli senza figli. Loro correvano, io rallentavo. Flashforward: qualche anno dopo, intorno a me, amici e conoscenti quarantenni alle prese con la prima esperienza di genitorialità. Li guardo con stupore e ammirazione: come riescono ad affrontare le faticose fasi iniziali della vita di un figlio alla nostra età? Non dormire, allattare, vivere in funzione del ritmo del neonato… Sarà caduto loro addosso lo stesso ammontare esorbitante e incongruo di tempo che ho sentito io? Oppure la loro esperienza, a un’età diversa, non è più paragonabile alla mia? La domanda in sé probabilmente è sbagliata: non è più possibile porsi di fronte alla maternità con purezza primigenia. Voglio dire: un conto è avere il primo figlio, un altro è pensarci avendone due relativamente cresciuti. Nel passaggio tra una cosa e l’altra sei già un’altra persona.
E poi non so più che significa vecchio o giovane. Sussulto ogni volta che mi danno della signora, se parlo di una persona della mia età dico ragazzo e ragazza, nessuno sa più dire da quale momento, di preciso, si comincia a essere vecchi. Anche perché, e questo vale specialmente per le donne, sono estinte le anziane signore senza pretese estetiche che si nascondevano in ampi vestiti neri e nelle pieghe del loro ruolo di grandi matriarche. Seppure in molte famiglie resista ancora la memoria di quella nonna che, negli anni Quaranta o Cinquanta, fece la fuitina – termine con cui si indicava la fuga di una giovane coppia la cui unione era osteggiata – o di quella nonna (talvolta la stessa) che nelle foto dimostra 75 anni anche se ne ha 58, si tratta ormai di figure del passato. Il panorama del femminile è totalmente cambiato – e per fortuna.
Negli ultimi decenni, il mito – o, meglio, quel che ancora resisteva del mito – della maternità perfetta, armonica, idealizzata, è stato sottoposto a ulteriori smitizzazioni, smontato, ripensato. La questione dell’età, della biologia che ci ingabbia, non poteva non comparire in queste riflessioni. Il lavoro di una vita, il racconto lucido di Cusk della sua esperienza di madre suscitò, alla sua uscita nei primi anni Duemila, reazioni molto animate, e, come ha raccontato la stessa scrittrice, spesso persino violente, perché le crepe arrecate all’immagine sacrale della madre non erano tollerate da tutti. Maternità di Sheila Heti parte dagli interrogativi di una voce narrante ormai prossima ai quarant’anni che prova a riflettere “impolitely”, dice lei, sui condizionamenti e tabù che ruotano intorno alla maternità. Nel recente Un’altra vita. Fare un figlio nell’era digitale, Amanda Hess conduce il lettore nel suo percorso genitoriale e lo fa, come dice il sottotitolo, occupandosi della maternità al tempo delle app e degli influencer (non a caso, nelle pagine iniziali Hess racconta l’utilizzo dell’app Flo per il monitoraggio del flusso mestruale e come questo strumento, subdolamente e benevolmente, l’abbia portata a considerare anche i giorni fertili e dunque la possibilità di rimanere incinta in tutta naturalezza): “A cena contavo gli anni con le dita sotto il tavolo, calcolando quanti ne avrei avuti una volta che fossimo arrivati al concepimento di questo bambino, alla sua nascita, al suo diploma delle superiori. Non era stata Flo a indurmi a volere figli, né a provarci subito. Però aveva messo a fuoco le mie fantasie su come sarebbe potuto succedere”. E ancora: “M’infastidiva il luogo comune per cui, avvicinandomi ai trentacinque, avrei perso la testa per via dell’orologio biologico; ma ora pareva che fosse proprio l’app a ticchettare in sottofondo ovunque andassi”.
È forse banale ripetere che la dialettica tra le donne e il tempo, nelle sue molteplici manifestazioni, è da sempre oggetto di speculazione. Questo avviene nella riflessione teorica del femminismo – per esempio quando si analizza il ruolo della donna nel tempo, nella storia; o quando si ragiona intorno alla possibilità di uno scardinamento della nozione di tempo lineare, intesa come costrutto tipicamente maschile. Avviene, come detto, nella narrativa; ma avviene anche all’interno di battaglie ed esperienze molto concrete in cui il fattore tempo esiste sempre come un’implicita precondizione. La pillola contraccettiva? Serve a rimandare, o cancellare, il tempo della gravidanza. L’aborto ad annullare l’evento nascita. La cosmesi? La chirurgia estetica? Ad attenuare la rude mano del tempo sui lineamenti del viso e sulle più svariate porzioni anatomiche. La crioconservazione ovarica, la procreazione medicalmente assistita? A riportare indietro il tempo.
(Ovviamente, siamo tutti, indipendentemente dal genere, in lotta con la nostra caducità, ma bisogna ammettere che per le donne è un po’ peggio. Se non altro per la già citata faccenda della biologia che, malevola, ci soffia nell’orecchio per ricordarci che la nostra fertilità ha una scadenza, e che costringe pure quelle che di figli non ne vogliono a chiedersi, a un certo punto della loro vita, e anche a darsi marzullianamente una risposta: davvero non li voglio? Perché poi non potrò più).
Il problema è che è sempre troppo presto. O troppo tardi. Al liceo avevo una compagna che aveva deciso di portare avanti la gravidanza indesiderata: la osservavo dal mio banco con stupore e terrore; provavo un senso quasi di incredulità all’idea che una coetanea avesse scelto di varcare quella soglia. Nella mia percezione di allora, probabilmente amplificata dal contesto della provincia, era un vicolo cieco; uno stigma che quella ragazza si sarebbe portata appresso per il resto dell’esistenza; la pietra tombale su qualunque progettualità futura. Avendo avuto figli al di qua e al di là della soglia critica dei 35 anni, quella delle “primipare attempate”, non ho più una visione così apocalittica della gravidanza precoce, mi viene anzi voglia di guardarla con occhi diversi. Per esempio, immaginando come sia stato diverso avere vent’anni con un bambino piccolo, con una forza fisica e una leggerezza mentale che mai più torneranno; e come sia diverso essere una donna di mezz’età con un figlio che è già adulto; o, ancora di più, cosa significherà diventare un’anziana senza che i tuoi figli dipendano ancora da te, fisicamente ed economicamente.
Oggi il tema delle madri ragazzine trova sempre meno interesse. Perché l’Italia, che pure ha una storia di spose giovani, risulta il paese con le madri più vecchie d’Europa e presenta la più alta incidenza di nascite da donne over 40, sia per il primo figlio che per i successivi. Tuttavia, la gravidanza precoce, ovvero quella tra i 10 e 19 anni, è ritenuta dall’Oms un fenomeno cui prestare particolare attenzione, perché può comportare effetti negativi a livello di salute nonché conseguenze sul piano sociale e culturale. Le adolescenti corrono maggiori rischi correlati al puerperio, come l’eclampsia o le infezioni sistemiche, così come i loro neonati; ed è alta la percentuale di coloro che si trovano obbligate a un matrimonio, o stigmatizzate, o costrette ad abbandonare la scuola e di veder dunque ridotte le proprie possibilità educative. Benché il tasso di nascita da madri adolescenti sia in costante declino a livello globale restano significative differenze tra le varie regioni del mondo. Nel continente europeo i numeri sono esigui, e così pure in Italia (nel 2023 su 1.000 nascite solo 3 riguardavano ragazze tra i 15 e i 19 anni).

Dunque si parla sempre più di gravidanze tardive. Improvvisamente sono spuntate molteplici definizioni, per lo più non gradevoli, per descrivere le donne over 35 alle prese con la prima maternità: mamme-nonne, primipare attempate, gravidanza tardiva.
Si tratta di un trend generale ma da noi si è saldato al tema della bassa fecondità e della denatalità: una storia che sentiamo da decenni visto che l’ultima generazione ad aver raggiunto la cosiddetta “soglia di ricambio generazionale” è addirittura quella delle nate nel 1947. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia, l’età media delle madri per il primo figlio è cresciuta dai 28,1 anni del 1995 ai quasi 31,9 di oggi. Quasi quattro anni. Può sembrare una differenza trascurabile, ma, come sottolinea il report, lo slittamento in avanti dell’età indica un progressivo contrarsi dei progetti genitoriali, perché se il primogenito arriva alla soglia dei 32 anni le possibilità di avere altri figli si vanno assottigliando. Vale anche per i neo-papà: in Italia mediamente si diventa padri per la prima volta intorno ai 36 anni, sempre secondo dati Istat.
L’attenzione all’età dei neo-genitori – al solito, soprattutto quella delle donne – talvolta si mostra benevolmente curiosa, talvolta può avere effetti perniciosi. Nei casi migliori si è manifestata con i titoli dei rotocalchi quando le madri erano famose e magari over 50 (per citarne un paio: Gianna Nannini, che ha avuto una figlia a 56 anni, e Brigitte Nielsen a 54); in quelli più sfortunati si è finiti in tribunale. Qualche anno fa fece clamore la storia di una bimba nata tramite fecondazione eterologa da una donna di 57 anni e un uomo di 69. I due – prontamente rinominati “genitori-nonni” – si videro sottrarre la custodia della bambina in seguito alla denuncia di un vicino, secondo il quale la neonata era stata lasciata in auto senza supervisione. Nel corso delle varie fasi processuali emerse che la neonata era stata lasciata in macchina per pochi minuti e sempre sotto il controllo visivo del padre, il quale fu poi assolto dal reato di abbandono di minore. Nonostante ciò, la bambina fu affidata a un’altra famiglia, che in seguito la adottò, e i giudici sostennero la non idoneità al ruolo dei due genitori – che hanno dunque perso ogni legame con la figlia. Eppure è piuttosto frequente, nel nostro paese, il caso di bambini sostanzialmente cresciuti dai nonni. Nonni che si trovano obbligati a reinventarsi genitori quando magari non ne hanno più voglia ma ai quali, in assenza di un welfare che garantisca totale assistenza alle famiglie, è demandata gran parte dell’accudimento. E nessuno si sogna di mettere in discussione queste figure così cruciali anche allorché sostituiscono di fatto i (più giovani) genitori.
Se c’è un ambito in cui non esistono molti dubbi circa il momento giusto in cui avere figli è quello della medicina: non proprio un’età precisa, ma un arco temporale all’interno del quale la possibilità di averli in modo naturale è più alta. Ne parlo con Egidio Fino, uno dei presidenti della Siru, Società italiana della riproduzione umana. Fino è tranchant; mi dice che per la medicina non c’è grosso dibattito: “una donna è già fertile a partire dai 15-16 anni ma è dai 35 anni in poi che inizia seriamente la discesa della riserva ovarica. La nostra non è più – e per fortuna – una società in cui le donne hanno figli a 15-20 anni, però sarebbe meglio evitare di arrivare a 35-40 anni. Ci vuole consapevolezza: sia per la donna che per l’uomo”. Mi spiega che anche gli uomini devono preoccuparsi della loro fertilità: “L’Organizzazione Mondiale della Sanità fissa dei parametri di normalità per la concentrazione di spermatozoi: circa 20 anni fa una condizione normale era quella uguale o superiore a 60 milioni per millilitro, oggi invece il parametro è uguale o superiore a 15 milioni per millilitro: è chiaro che c’è stato un peggioramento”.
Se per le donne la questione è sempre la stessa, cioè il fatto che la riserva ovarica è determinata fin dalla nascita, per gli uomini la produzione di spermatozoi è costante e dunque, mi spiega Fino, “il maschio ha una potenzialità di fertilità almeno di 10 anni maggiore alla partner”, ma ciò che allarma chi si occupa di riproduzione è l’impatto negativo dell’inquinamento ambientale e degli stili di vita: “per fare un esempio ci sono studi che mostrano una preoccupante condizione di oligospermia nella Terra dei Fuochi, in Campania”. Per la Siru l’educazione è fondamentale: quando, come organizzazione, vanno a parlare nelle scuole riscontrano una totale carenza di consapevolezza sul tema della fertilità da parte degli studenti (del resto, non c’è nemmeno la possibilità di impartire l’educazione sessuale…). Secondo Fino, è importante sensibilizzare, in modo da poter agire preventivamente, come attraverso la crioconservazione dei gameti. Quando gli chiedo se, in quanto medico ma anche come semplice osservatore, riesce a vedere qualche lato positivo nell’avere un figlio più avanti negli anni, diciamo dopo i 35, la sua risposta è un desolato: no.
Però non tutti la pensano così. Intanto, bisogna dire, sulla scorta di molti altri che si sono espressi sul tema in passato, che l’efficacia delle campagne per la fertilità è discutibile. Qualche anno fa il cosiddetto Fertility Day e le campagne pubblicitarie che lo accompagnarono suscitarono enormi polemiche, in quanto accusate di sessismo nonché di razzismo. In uno dei manifesti si mostrava una ragazza con in mano una clessidra e accanto la scritta: “La bellezza non ha età. La fertilità sì”: per dire la delicatezza.
Michela Murgia, che combatteva tutti gli impedimenti e i vincoli derivanti da biologia e sangue, centrava il punto quando scriveva: “Le campagne paternaliste come l’indimenticato Fertility Day, che scaricano sulle donne la responsabilità delle culle vuote, non solo non servono a nulla, ma sono offensive e umilianti. Le donne italiane ricominceranno a dare la vita quando per farla venire al mondo e crescerla non sarà più necessario amputare la propria”.
Perché il rischio è sempre quello di anteporre il bene collettivo (l’aumento demografico) al benessere e alla realizzazione della donna. Vengono in soccorso, per quanto relativo, altri punti di vista. Per esempio, sono diverse le ricerche che trovano una correlazione positiva tra l’essere genitori più maturi e la salute della prole. Nel 2016 uno studio dell’University college of London provò a indagare meglio i possibili benefici sfidando il tradizionale punto di vista “punitivo” rispetto alla gravidanza in età avanzata. Risultò che madri più anziane avevano un livello più elevato di istruzione e questo a sua volta aveva un impatto positivo sulle performance scolastiche dei figli. Così come gli effetti erano positivi anche a livello di salute. Chiaramente lo studio, che partiva dall’analisi di dati svedesi, sottolineava come questi risultati erano correlati a un complessivo miglioramento socio-economico, culturale e di salute pubblica della società svedese nel corso degli ultimi sessant’anni; un’eventuale inversione potrebbe rimettere in discussione i vantaggi di una maternità avanzata. Un’altra ricerca più recente – è del 2024 – suggerisce che “le madri più anziane hanno una maggiore maturità emotiva e si sentono più preparate alla maternità; inoltre, l’età materna avanzata sembra esercitare un’influenza protettiva sul funzionamento comportamentale, sociale ed emotivo dei bambini, compensando i rischi biologici”. Non solo: secondo un altro studio, avere figli sarebbe utile per i genitori stessi, anche se avanti con l’età, perché la genitorialità proteggerebbe dall’invecchiamento funzionale del cervello.
“Il problema è che è sempre troppo presto. O troppo tardi. Al liceo avevo una compagna che aveva deciso di portare avanti la gravidanza indesiderata: la osservavo dal mio banco con stupore e terrore; provavo un senso quasi di incredulità all’idea che una coetanea avesse scelto di varcare quella soglia”.
Insomma, non dimentichiamo cosa dice la medicina, ma ben vengano gli studi che guardano la realtà sotto più profili. Anche perché è un fatto ormai che molte persone rimandano la procreazione consapevolmente (e non colpevolmente!). Ed è lecito supporre che all’aumentare del numero di genitori over 35 o over 40 corrisponda una riduzione del pregiudizio. Lo conferma un sondaggio Pew condotto in America nel 2025, secondo il quale per il 40% degli intervistati non esiste un’età giusta in astratto per avere figli. Magari non uniformemente e magari non sempre, ma le società si stanno adattando alle primipare attempate, ai padri brizzolati, e ai loro figli. Devono farlo. Perché, è inutile girarci intorno, per moltissime persone il momento in cui si decide di dar vita a una famiglia ha più a che fare con la libertà individuale che con le indicazioni mediche.
Inoltre, se è vero che la dinamica della fertilità non è sostanzialmente cambiata nel tempo, è pure vero che lo sviluppo medico ci ha offerto i mezzi per avere figli in momenti successivi. E di questo, come di tutte le innovazioni che incidono sulla nostra supposta naturalità, bisogna tener conto. E dunque semmai agire affinché, in Italia, il ricorso alle tecniche di Pma non riproduca le differenze socio-economiche e le discriminazioni che già esistono nella società.
Forse questo potrebbe riportare un po’ di serenità e rendere il famoso “orologio biologico” meno simile a una bomba a orologeria.