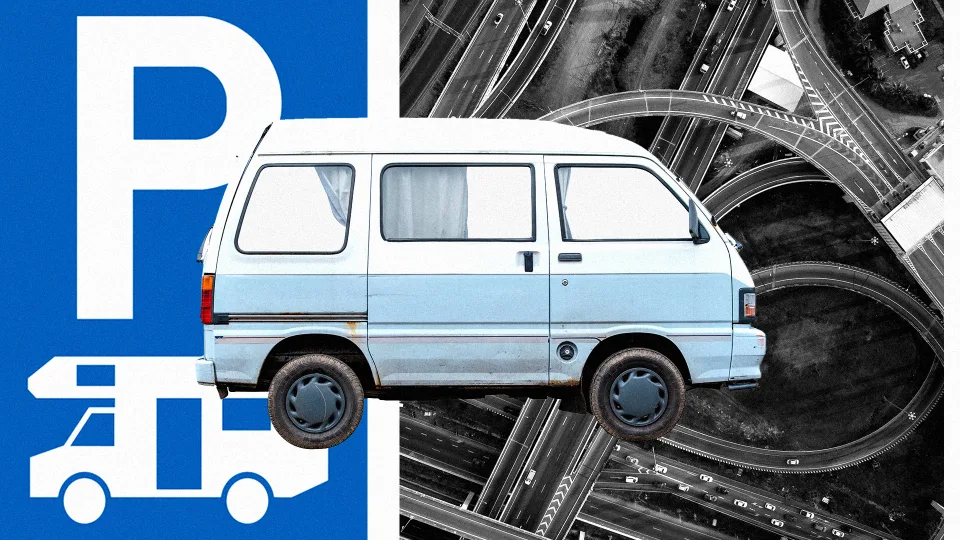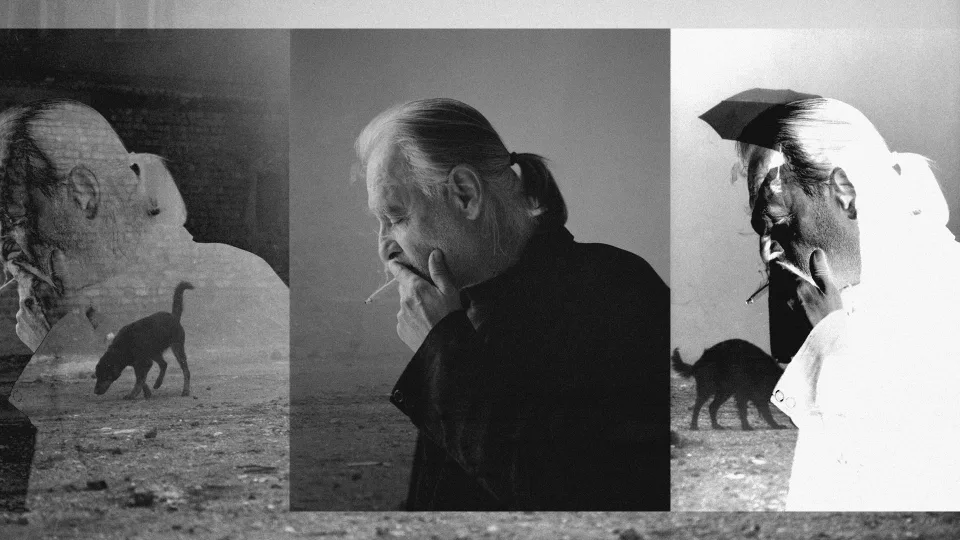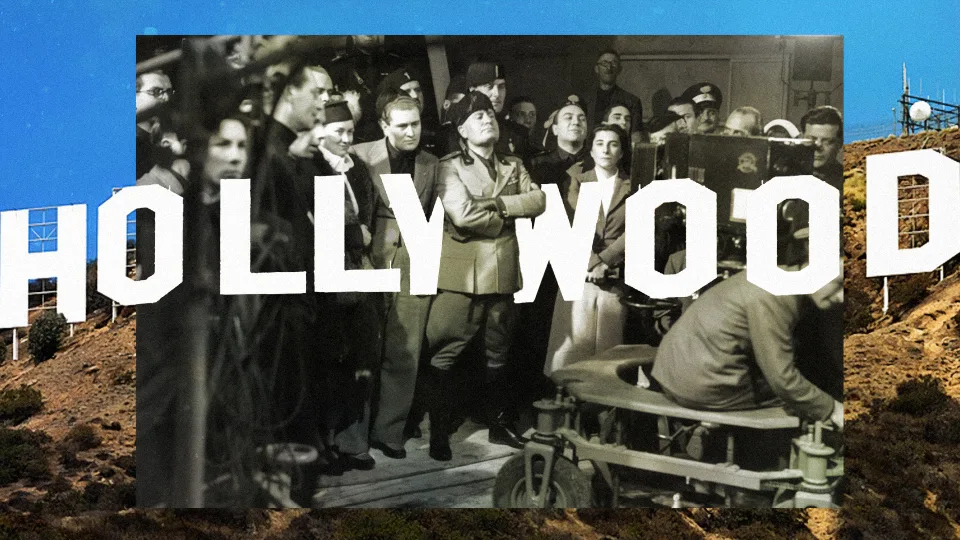Sorto in poco tempo nel quartiere universitario di Roma, "The Social Hub" è uno strano ibrido: un po’ residence, un po’ spazio di socialità, molto albergo di lusso. Di certo pochissimi studenti potranno permetterselo: a chi conviene, allora?
La Cattedrale nella Giungla
La mattina che hanno tolto le impalcature ho avuto un secondo di disorientamento. Me ne stavo fermo in Tangenziale, bloccato dietro al posteriore di un Fiorino troppo grosso per il traffico delle otto. Cercavo di calcolare i mesi passati da quando la piazza d’armi del mega cantiere aveva sventrato l’area dell’antico scalo merci di San Lorenzo.
Pochi – pochissimi – se confrontati con i lavori che avevano scandito i miei trent’anni di vita romana. Roba che quando li dichiaravano conclusi era già tempo di tirare su un’altra impalcatura, per intervenire sui quindici anni passati dalla posa del primo ponteggio. In questo caso invece il palazzone, cattedrale hi-tech con rooftop piscinato, è sembrato sorgere con la velocità di una pianta di fagioli in time lapse.
Le insegne le hanno tenute coperte qualche altro giorno. Il palazzo-quartiere sembrava pronto, ma i fregi distintivi rimanevano celati sotto quelli che somigliavano a sacchi dell’immondizia, come a voler ritardare ai pendolari l’identità del mastodonte. Poi finalmente il fiore – una specie di garofano in silhouette – è sbocciato, e con esso le enormi scritte affacciate sull’asfalto della Sopraelevata: THE SOCIAL HUB.
Storia della Cattedrale
Al centro del dibattito cittadino fin dal suo annuncio del 2016, il complesso sorto sulle ceneri dell’Ex-Dogana rappresenta oggi l’ultimo arrivo nella famiglia delle soluzioni abitative ibride: un po’ residence, un po’ spazio di socialità, molto albergo di lusso.
21.000 metri quadri per cinque piani per 396 stanze da dividere tra turisti, nomadi digitali e studenti. Palestra, piscina, coworking e i 10.000 metri quadri di parco la cui apertura al pubblico resta la sola concessione che, nel 2023, l’ex assessore all’Urbanistica Montuori poteva presentare al portale «RomaToday» come “buon punto di atterraggio della trattativa con la società proprietaria”. Poche righe dopo, Montuori si abbandonava alla descrizione di una San Lorenzo “investita dal Piano Casa, che ha fatto sorgere hotel esclusivi e lo studentato”. Studentato su cui, secondo l’assessore, “Si doveva forse far pesare di più il ruolo del pubblico”.
Pubblico che, dal canto suo, non è rimasto in silenzio. Solamente nell’ultimo anno, decine di manifestazioni hanno espresso il dissenso di universitari e residenti nei confronti di The Social Hub, che al momento conta già quattro strutture tra Bologna, Firenze e Roma, e degli altri marchi dell’accoglienza di lusso per studenti. Striscioni, tende e finte lapidi a segnalare la trasversale insofferenza verso un sistema convinto da anni di trovare nell’operato dei privati la sola risposta alle esigenze abitative della collettività.
Uno dei punti di maggior dibattito è relativo ai costi da sostenere per alloggiare presso questo tipo di strutture. Nella sezione “Cost of living in Rome” della loro Study in Rome: a guide for international students, i copywriter di TSH raccontano di un mercato immobiliare stretto in una forchetta dai cinquecento ai milleduecento euro al mese più le spese, a seconda del grado di rispettabilità dell’alloggio.
La soluzione del gruppo, al momento, è offrire stanze singole da 19 metri quadri, bagno privato e cucina condivisa a 1482 euro al mese. “I costi degli alloggi potrebbero essere alti? Capisco non sia un modello consueto, ma attrae varie tipologie di studenti, non per forza fuori sede” dichiarava ancora a «RomaToday» nel 2023 la presidente del II Municipio Francesca Del Bello, in netta contrapposizione con i continui appelli studenteschi all’urgenza di posti letto a prezzi abbordabili.

Tra le voci che si sono maggiormente occupate del fenomeno del social housing c’è quella di
Sarah Gainsforth, ricercatrice, autrice e attivista in ambito urbanistico. “The Social Hub non rientra nella definizione di ‘social housing’ – mi spiega – quel termine implica convenzioni con il pubblico e, nel caso degli studentati, la garanzia da parte dell’investitore di una quota di posti letto a uso studentato. TSH, al contrario, è un’operazione completamente privata e libera da vincoli sulla destinazione d’uso dei suoi alloggi, in cui la comunicazione rivolta agli studenti è fondamentalmente marketing”. Alla categoria appartengono invece realtà presenti nelle principali città italiane come Camplus e Campus X, marchi di accoglienza ibrida che nelle loro strutture sono tenuti a riservare una parte dei posti agli studenti.
Le chiedo se negli anni abbia notato un miglioramento della crisi abitativa studentesca. “Non è cambiato nulla. I posti finanziati sono pochi: a oggi Roma conta appena tremila posti letto per studenti, di cui circa duemila in strutture private convenzionate”. Nel solo a.a. 2023/24, la Sapienza contava un totale di 111.960 iscritti.
Poi finalmente il fiore – una specie di garofano in silhouette – è sbocciato, e con esso le enormi scritte affacciate sull’asfalto della Sopraelevata: THE SOCIAL HUB”.
“È il modello in sè a essere fallato: i gestori degli studentati che percepiscono i fondi non hanno interesse a realizzare offerte in diretta competizione con le loro, più costose, e così finiamo col ritrovarci con un albergo di lusso parzialmente finanziato dalla collettività in cui un paio di posti per studenti fungono da foglia di fico legale”.
Ci dovranno pur essere degli studenti interessati a una simile offerta. “Quando non sono profili internazionali dall’alta capacità monetaria, provengono tendenzialmente da famiglie medio-abbienti coinvolte nel fenomeno della migrazione studentesca da sud a nord. I genitori sono disposti a investire grosse somme nell’inserimento dei figli in contesti protetti e, soprattutto nel caso di Milano e Bologna, teorici facilitatori di relazioni lavorative strategiche. Ciò che succede però è che a valle delle ingenti spese di sostentamento, quando gli studenti raggiungono il mondo del lavoro non possono permettersi il costo della vita delle grandi città italiane, e quindi emigrano. La realtà dello studentato di lusso si inserisce così in un più ampio quadro di impoverimento del paese”.

Colpisce in particolare la facilità di sviluppo di simili progetti immobiliari in un paese proverbialmente noto per la lentezza delle opere pubbliche. ”Come nel caso dell’ormai celebre ‘modello Milano’, ai privati è garantito un ampio spazio di manovra a fronte di impegni verso la collettività quasi nulli. Ora a Milano il meccanismo sembra aver raggiunto il punto di rottura, con le casse comunali vuote nonostante i capitali globali attratti. A Roma la strategia, pubblicizzata dall’amministrazione come ‘rigenerazione urbana’, rimane tuttavia la medesima: tempi di sviluppo certi e facilità di cambio della destinazione d’uso, motori essenziali per la messa a frutto privata del suolo pubblico. Anche la discussa pratica delle edificazioni presentate come ristrutturazioni, al centro dello scandalo milanese, a Roma è permessa proprio dalle norme del Piano Casa”.
Tale scenario, secondo Gainsforth, sta accelerando la polarizzazione di ricchezza e stile di vita dei nostri quartieri. “In un articolo del 2024, l’architetto Pedro Levi Bismark parla di ‘finanziarizzazione delle città’, ossia dello sviluppo di narrative architettoniche altamente individuali che escludono ogni possibilità di progetto coerente con il resto del tessuto urbano e sociale. Lo vediamo in città come San Francisco, divise tra l’esperienza di una manciata di miliardari e le lotte dei poverissimi, e sempre più spesso anche da noi. La modernità di The Social Hub e, accanto, i senza tetto che abitano il sottopassaggio di Porta Maggiore. Il muro di cinta di Villa Mercede, in macerie dal 2018, e i murales sui palazzi in rovina finanziati dal gruppo immobiliare della Soho House – albergo di lusso alfiere della gentrificazione di San Lorenzo – per dare un tocco di ‘creatività’ alla zona. Negli anni ci è stato raccontato che delle operazioni di ‘rigenerazione urbana’ affidate ai privati avremmo beneficiato tutti. Oggi però possiamo legittimamente chiederci dove siano questi benefici”.
Appare in effetti lecito domandarsi, nel caso di The Social Hub così come in quello di simili progetti di sviluppo, come gli ideatori di tali pachidermi socio-architettonici immaginano il loro incastro con il territorio circostante. In tal senso trovo esplicative le parole con cui Francesco Naldi, Real Estate Development Manager per la catena di hotel olandese, raccontava nel 2024 la visione di TSH Roma al portale di architettura promiselands.it.
Naldi si sofferma in particolare sulla “forma dell’edificio, che si articola orizzontalmente, quasi a voler rappresentare una cortina, utile a nascondere il ponte della circonvallazione Tiburtina”.

Il brutto per eccellenza dell’area, una delle sue arterie più essenziali e riconoscibili, nascosto dietro il sipario del bello e del nuovo, polvere sotto al tappeto della realtà problematica che amministrazione e pubblico di The Social Hub non vogliono respirare. “Per il parco, stiamo pensando ora di coinvolgere la comunità di San Lorenzo, non solo per raccogliere suggerimenti ma anche per valutare future sinergie”.
Per il momento però, tolta la collaborazione con l’istituto di moda ospitato a sua volta nel complesso dell’Ex Dogana, la cui retta minima per un corso triennale è di ottomila euro, le “sinergie” di cui si abbia traccia esplorando sito e profilo Instagram di The Social Hub sono quelle – per citarne alcune – con una nota catena di pizzerie, uno studio di floral design in zona San Pietro e uno spazio eventi a Castel Sant’Angelo.
Il punto di maggior contatto con San Lorenzo sembra essere una presentazione organizzata con la Libreria Antigone. Per il resto, del rapporto con le realtà del quartiere ancora non si hanno notizie.
Se tuttavia, come sostenuto dalla Presidente Del Bello, la struttura è destinata ad attrarre “varie tipologie di studenti”, resta da vedere quanto questo nuovo tipo di consumatore si rivelerà interessato a sperimentare la realtà caotica e contraddittoria del quartiere, o se piuttosto non pretenderà una porzione della Roma da cartolina vendutagli dalla stessa comunicazione di The Social Hub.

Una gita a Spocco Square
C’è sempre il sole a Spocco Square, grandi sorrisi ovunque ti giri. Qui la missione è una: divertirsi. Amici in tenuta sportiva si spostano da un chiosco di frullati all’hangar convertito in stadio del badminton, più tardi li attende il bowling. Le architetture avveniristiche si fondono con la vegetazione nelle forme immacolate di un club che promette solo giornate fantastiche. Sport, merende, shopping. I problemi li lasciamo tra i palazzi sullo sfondo, quelli della città senza nome.
“Abbiamo pensato di progettare un impianto che le persone potessero frequentare senza impegno, in un ambiente alla moda che invogliasse chiunque a fare un salto” dice Junji Morii, sviluppatore, parlando delle scelte di design dietro l’ambientazione di Nintendo Switch Sports (2022). “È un luogo che vorresti facesse parte della tua vita.”
Ripenso a queste parole mentre giro per i vialetti di The Social Hub. La ghiaia che crocchia sotto le scarpe riflette la luce del sole arrostendo me e le poche persone che vedo in giro. Tutto attorno i cantieri ancora in corso sono recintati da banner che recitano i claim aziendali: “learn stay work play”, “for the thinkers and doers”, “18 proprietà in Europa, e molte altre in arrivo”. Sopra ogni cosa si erge l’immensa mole dell’albergo, che dal vivo rende ancora più complesso l’esercizio percettivo di integrazione con l’ambiente circostante.


L’umanità che incontro al mio ingresso nella cattedrale ha i tratti marcati della satira di costume. Un gruppo di ragazze e ragazzi del nord Italia stanno parlando di uno shooting. Snelli e alla moda, vestiti come in un servizio di Vogue sulle tendenze giovanili. Ai tavoli del bar, centro gravitazionale del grande open space del piano terra, quattro cosplayer di Tony Effe sono nel pieno di una sessione di trading azionario.
“M’è entrata frate’, m’è entrata” esulta uno mostrando l’iPhone ai colleghi.
“Qui il mood è da paura” dice un altro al telefono “quand’è che scendete anche voi a Roma?”
Il cammino di gruppi di turisti anziani e ben vestiti si incrocia con quello di giovani dall’aria di stagisti. Tesserino al collo, cartelline e frenesia. È in pieno svolgimento quella che sui cartelloni è indicata come “ongoing conversation”. Sotto, col pennarello, qualcuno ha indicato l’argomento del giorno: “il talento”.
Superato un gruppo di cinquantenni di lusso scortati in giro da un responsabile – mi immagino l’ipotetico tour di potenziali investitori – ho modo di dare un’occhiata ai tavoli occupati da chi è lì per lavorare. L’idea che mi faccio è quella di quarantenni attivi in settori creativi. Al termine della mia visita resto con l’impressione di non aver incontrato nemmeno uno studente universitario.
Sarà la deformazione mentale di chi è cresciuto di pari passo con l’evoluzione del concetto di metaverso, dai pixel di Habbo Hotel ai concerti di Travis Scott su “Fortnite”, ma non riesco a togliermi l’impressione che i parametri esperienziali di The Social Hub – spazi futuristici, gamificazione dell’esperienza, collaborazioni temporanee con brand noti, vita frictionless – siano gli stessi della piazza virtuale di un MMORPG. “Il paragone più calzante è probabilmente quello con Horizon Worlds di Meta” dice Priscilla De Pace, esperta di spazi virtuali e templi del capitalismo, autrice per Einaudi di Al centro dei desideri, saggio su evoluzione e impronta culturale del Centro Commerciale come luogo di liturgia del consumo.
“La pianificazione degli spazi e la possibilità di costruire ambienti al servizio di gruppi sociali diversi diventa problematica – tanto online quanto offline – quando segue le logiche di una gated community o di un centro commerciale, esattamente il modello tentato da Zuckerberg negli ultimi anni.”
Se però la storia del web ci mostra come – a oggi – gli ambienti eccessivamente amministrati ed escludenti hanno fallito, nel contesto urbano l’impatto di questi progetti è ben più concreto e potenzialmente dannoso. “Si finisce per sostituire uno spazio al servizio del quartiere con un ambiente privatizzato, che sfrutta concetti come “comunità” e “casa” piegandoli a logiche commerciali ed esclusive, fondate sulla costruzione di reti sociali chiuse basate su affinità predefinite.”


Nel suo saggio, De Pace si sofferma sulle idee di Ray Bradbury per la creazione di town plaza che conciliassero la dimensione commerciale con quella di una socialità intensa. Un progetto che, a prima vista, potrebbe ritrovarsi nella proposta di realtà come The Social Hub. “Sono visioni che nascono da contesti diversi, ma c’è un filo rosso che le accomuna. L’idea di Bradbury, ad esempio, nasce dalla sua nostalgia per la cittadina dell’Illinois dove crebbe tra gli anni Venti e Trenta, un luogo in cui lo spazio del commercio coincideva con quello della socialità, un territorio aperto all’incontro con l’altro. Oggi, quelle immagini nostalgiche vengono utilizzate come cavallo di Troia per giustificare un’idea distorta di comunità. Una visione che esclude la complessità delle relazioni reali, riducendo la socialità a una forma addomesticata, funzionale alle sole logiche del consumo.”
La contraddizione principale potrebbe dunque risiedere nel fatto che studentati di lusso e operatori del tempo libero – penso a aziende come WeRoad – abbiano fatto della “socialità” un prodotto da vendere.
“Le leve su cui si fondano questi progetti mi sembrano essere la solitudine e la difficoltà che abbiamo oggi a confrontarci con essa. È l’ennesimo aspetto della vita che vogliono convincerci a gestire attraverso un abbonamento”.
Proprio questo approccio, per De Pace, rischia di renderci meno capaci di affrontarla quella solitudine, di scoprire “quegli spazi e quelle esperienze che ci permettono di metterla in pausa insieme agli altri”, ed è tanto più inquietante quanto più è concreta la dimensione che investe, come nel caso di quella urbana.
“Il modo in cui abitiamo le città è condizionato da fattori che rendono difficile esercitare libertà individuale o costruire forme di resistenza, cosa che invece riusciamo ancora a fare negli spazi virtuali. Proprio per questo è fondamentale non accettare passivamente modelli come quello di The Social Hub, per evitare che gli spazi urbani del futuro si trasformino in una costellazione di comunità chiuse, accessibili solo a pagamento e sempre più isolate le une dalle altre”.