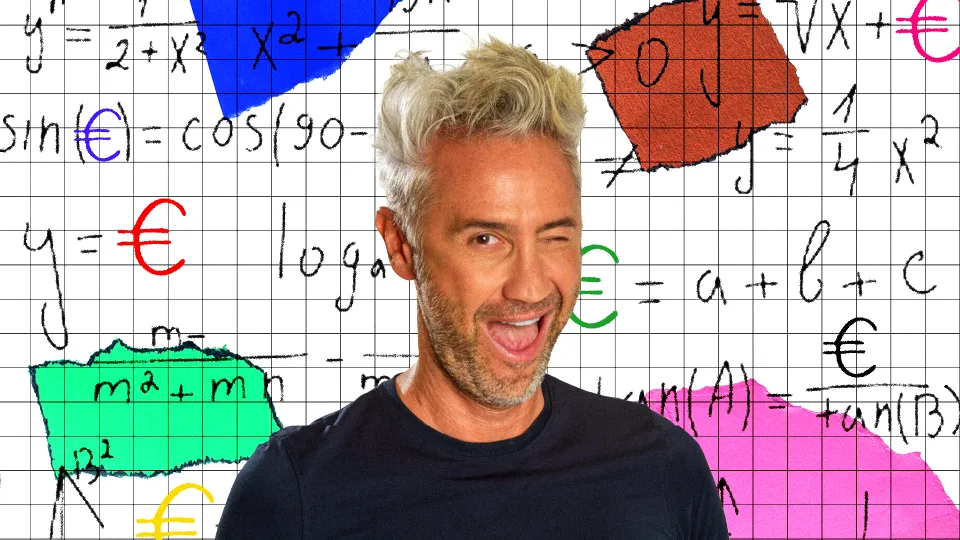Le immagini del cibo dominano social e riviste, sollecitando non solo il nostro appetito ma anche le nostre più intime aspirazioni. Ne sono una prova i moderni libri di cucina, i quali – equiparabili a cataloghi d'arte – più che dirci come cucinare ci mostrano come vorremmo vivere.
Nel suo libro In principio era la tavola, Adam Gopnik ricorre al concetto di consumo vistoso formulato da Thorstein Veblen e agli studi di Gary Becker su gusto, tempo e denaro per mostrare quanto i nostri desideri alimentari seguano traiettorie accidentate e non lineari. Ed è proprio questa loro instabilità a rendere labile il confine tra ciò che consideriamo una moda effimera e ciò che, invece, percepiamo come un valore alimentare stabile, quasi universale.
Queste tensioni emergono con particolare evidenza nella rappresentazione fotografica del cibo. Nell’iconosfera contemporanea – soprattutto sulle piattaforme social – le immagini di cibo sono ovunque, e la loro presenza pervasiva rivela quanto queste partecipino alla costruzione della nostra vita simbolica. La creazione del contenuto influenza le decisioni in fatto di cibo di tutti i soggetti coinvolti: tanto degli chef che devono tener conto di come il piatto apparirà sugli schermi dei telefoni, quanto di noi consumatori che spesso finiamo per ordinare i piatti che significano il ristorante, lo riassumono, lo identificano in modo trasparente, così che chi guarda le nostre storie non possa avere dubbi sul posto in cui ci troviamo. Se il cibo fotografato è veicolo di apparati simbolici, generatore di metafore, la foto del piatto signature di un ristorante funziona come la parte per il tutto.
Le conseguenze di questa ipertrofia iconica sono di segno diverso. Oltre a una prevedibile standardizzazione dei contenuti, e a una altrettanto prevedibile assuefazione a questo tipo di fotografie, la loro proliferazione ci spinge a interrogarle, sollecitando l’urgenza di alcune riflessioni intorno all’agency di queste immagini. Che siamo tutti, se non consumatori, quantomeno produttori di fotografia di cibo è evidente, tanto che anche la guida Michelin, riconoscendo l’inarrestabile diffusione del fenomeno “Camera eats first”, segnala sul suo sito suggerimenti e trucchi per trasformare il cibo in immagine nel modo più accattivante. Abituati come siamo a guardare le foto di cibo sugli schermi, tendiamo a pensare alle estetiche della food photography come qualcosa di nato con Internet, mettendo in secondo piano il ruolo dei libri di cucina nei fenomeni di messa in immagine del cibo – mangiato, preparato, desiderato. I libri di cucina sono dispositivi che agiscono secondo una duplice direttrice: da una parte intercettano, cristallizzano e raffigurano i mutamenti del gusto, delle tendenze e delle sensibilità, dall’altra dirigono la curiosità, influenzano quello che cuciniamo, il modo in cui pensiamo al cibo, come ne parliamo e, soprattutto, come lo fotografiamo.
“Nell’iconosfera contemporanea – soprattutto sulle piattaforme social – le immagini di cibo sono ovunque, e la loro presenza pervasiva rivela quanto queste partecipino alla costruzione della nostra vita simbolica”.
Una lettura dei libri di cucina che ne riconosca la natura di artefatti culturali, in cui la dimensione iconografica, narrativa e simbolica è centrale quanto quella culinaria, deve tener conto del fatto che questi non si limitano a riflettere in modo trasparente le caratteristiche della società che li ha prodotti. In particolare occorre ricordare che la loro funzione ha più a che fare con lo storytelling che non con la pedissequa documentazione. È vero che registrano cambiamenti – nei confini di ciò che è considerato commestibile, nella logica dei pasti e che rivelano i rapporti sempre mutevoli e storicamente determinati tra persone, cibo e valori – ma è altrettanto vero che sono soprattutto dispositivi di costruzione del desiderio. Sfogliare un libro di cucina non rivela soltanto quello che si mangia o si mangiava in un dato momento o in una data cultura. Rivela piuttosto quello che si è desiderato mangiare. Dice molto anche delle fantasie costruite a partire dal cibo che coinvolgono temi più ampi: l’idea del femminile, quella delle identità e delle culture nazionali, gli immaginari culturali, la tensione tra tradizione e modernità, tra repulsione e piacere, l’ostentazione di uno status economico, sociale e culturale, gli stessi temi con cui la food photography si è sempre confrontata.
Il libro di cucina stesso, nella sua materialità patinata e nella sua costruzione visiva, è diventato a sua volta un oggetto del desiderio.
Un tempo era uno strumento d’uso, un contenitore di ricette; ma l’evoluzione delle tecniche di stampa, l’ascesa dei celebrity chef e l’ingresso dei ristoranti in un nuovo regime discorsivo lo hanno trasformato nel coffee table book definitivo, capace di superare persino i cataloghi delle mostre e i volumi di design. Nessuno immagina davvero di cucinare dal French Laundry Cookbook di Thomas Keller: averlo in casa, esposto, visibile, significa piuttosto adottare un oggetto che veicola un intero apparato di simboli – sociali, economici e culturali – da cui ci lasciamo volentieri rappresentare.
Questo discorso è rilevante soprattutto oggi, considerando che le ricette di pressoché qualsiasi piatto del repertorio alimentare mondiale sono disponibili online, con siti come Mob, Epicurious, Allrecipes, per citare i più famosi, che sono generatori potenzialmente infiniti di ricette, quasi tutte nate dalla combinazione di elementi crunchy e juicy, in cui non manca mai il chili oil. Nonostante questa concorrenza, i libri di cucina continuano a essere acquistati e ostentati sui social, in ragione della svolta memorialistica da cui sono stati attraversati, per cui si leggono come fossero romanzi – da qualche anno sembrano essere diventati memoir, coi ricordi di famiglia alternati alle ricette, e hanno titoli come Salt Sugar MSG: Recipes and Stories from a Cantonese American Home – e del sontuoso apparato iconografico che dispiegano sulle loro pagine.
Questi libri di cucina-memoir molte volte sono la forma compiuta di ricette postate sulle newsletter di Substack (Something from Nothing di Alison Roman, What to Cook When You Don’t Feel Like Cooking di Caroline Chambers), tutti incentrati su un’idea di cucina confortevole, con piatti che si possono preparare anche senza un’attrezzatura professionale, nel calore disordinato – ma controllato – di appartamenti perfetti. È sulle immagini che si misura il patto di fiducia tra chi scrive la ricetta e chi la legge e magari la replica. Per questo motivo c’è una probabilità molto bassa che le ricette che non sono accompagnate da foto vengano poi effettivamente riprodotte o persino lette.
Perché ci fidiamo delle immagini. Perché quello che vorremmo acquisire dalle fotografie non è soltanto la resa del piatto. Pasticciando un po’ il solito adagio di Brillat-Savarin “Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei” e collocandolo nell’epoca dei lifestyle cookbook, si potrebbe dire che la vitalità di queste immagini sta nella loro luccicante capacità di esplicitare l’equazione: se mangi come me, potrai essere come me. Per consentire questa immedesimazione, dalla fine degli anni Novanta-inizio anni Duemila nelle foto dei libri di cuina sono entrate sempre di più porzioni del corpo di chi cucina, un corpo che viene evocato anche in forma fantasmatica: i piatti non sono più perfetti e completi, ci sono briciole, gocce di olio, forchette che sembrano essere state appena posate. Ci sono i segni dei morsi, il cibo è già stato consumato e ora è meno intimidatorio. Anche l’inquadratura dall’alto favorisce questo avvicinamento, il piatto è totalmente a disposizione dell’osservatore. Con questa apparente e rassicurante casualità le fotografie mirano a suscitare appetiti che trascendono quelli alimentari e che riguardano beni più intangibili: i piatti, le posate, i tavoli, le parti della casa che finiscono nell’inquadratura sono l’estensione di una soggettività con cui l’osservatore vorrebbe mimeticamente identificarsi. Per essere finalmente una persona che ha il tempo e le possibilità economiche di preparare stufati che cuociono tutta la notte nel Dutch oven (anche essere una persona che ha uno o più Duch oven); una persona che ha una casa spaziosa, con un bancone su cui appoggiare libri di cucina e bottiglie di vino a cui attingere durante la preparazione, un tavolo molto ampio, per otto-dieci persone, su cui adagiare le portate usando piatti e salsiere vintage; soprattutto, una persona che ha un gruppo di amici che apprezza il cibo cucinato con perizia e che accoglie con entusiasmo il risultato di un giorno in cucina.
I libri di cucina, nella loro intersezione tra autobiografia e storia, tra pubblico e privato, hanno sempre comunicato più uno stile di vita che non soltanto un elenco di ricette.
Gli stessi cambiamenti, iconografici e stilistici, che si sono succeduti nei diversi decenni nella food photography, si possono leggere come strategie finalizzate alla codificazione di un orizzonte di attese e di desideri che spesso trascende il cibo e occupa i territori ben più estesi del lifestyle. I libri di cucina degli anni Cinquanta, soprattutto americani, penso in modo particolare a Betty Crocker’s Picture Cookbook, si sono strutturati intorno all’utopia di abbondanza e di esuberanza consumistica di cui si sostanzia l’american way of living nel secondo dopoguerra, espressa attraverso immagini gloriose e teatrali di torte ricoperte di frosting, cosciotti glassati e abbelliti con fette di ananas. Le fotografie sono spettacolari, sono sontuosi tableaux in cui l’horror vacui viene scongiurato riempiendo tutto lo spazio disponibile oltre che con i piatti con decorazioni floreali e oggetti d’arredo – i prodromi del food styling – , una cornucopia in technicolor di cibo che non si vorrebbe davvero mangiare, ma che restituisce la modernità e la grandiosità a cui può aspirare la nuova casalinga americana (gran parte delle ricette prevede l’utilizzo di prodotti in scatola). Negli anni Sessanta e Settanta i libri di cucina allargano i confini delle culture alimentari conosciute, iniziando a introdurre nell’orizzonte del visibile ingredienti e piatti che sono il risultato di incursioni nella cucina mondiale. Di questo orientamento è emblematica la serie di Time-Life Foods of the World, uscita tra il 1968 e il 1978, con foto di tono reportagistico-umanista, stile The Family of Man. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta irrompono i celebrity chef come nuovi personaggi divistici. Lo sguardo fotografico abbraccia sempre di più lo spazio dei ristoranti, delle cucine in cui i cuochi si muovono come eleganti demiurghi. Le immagini sono al tempo stesso ruvide e mitizzanti, granulose, in movimento. Il caso più noto è quello di White Heat di Marco Pierre White, con le foto di Bob Carlos Clarke. Nel passaggio anni Novanta-Duemila i restaurant cookbook diventano spazi di edificazione della mitologia del ristorante, territorio del racconto e per questo luoghi di stratificazione e combinazione di materiali diversi. Ci sono sempre le foto dei piatti affiancati dalle ricette, ma spesso ci sono anche le foto dei luoghi che hanno ispirato la visione dello chef (Polpo. A Venetian Cookbook (of sorts) in cui l’apparato fotografico conduce il lettore tra i bacari veneziani e gli spot più suggestivi della città); pezzi di mail (Momofuku di David Chang e Peter Meehan), pagine di appunti o del diario personale dello chef (Noma. Time and Place in Nordic Cuisine di René Redzepi); foto dello staff; foto dei cuochi al mercato (Mangal II. Stories and Recipes di Ferhat Dirik e Sertaç Dirik; The Mission Chinese Cookbook di Danny Bowien e Chris Ying); foto di libri e di dischi (Never Trust a Skinny Italian chef di Massimo Bottura); foto dell’allestimento del ristorante, del suo farsi (di nuovo Momofuku ma se ne potrebbero citare molti altri); foto delle attività giornaliere di un ristorante (The River Caffè Cookbook di Rose Gray e Ruth Rogers).
Il libro di cucina serve al ristorante per fissare e cristallizzare in immagini il suo mito fondativo, è un dispositivo di archiviazione di materiali effimeri ma anche uno strumento che dirige e orienta uno sguardo. Serve anche al lettore come protesi, come sostituzione, dell’esperienza del ristorante.
Perché se un tavolo al Noma resta qualcosa di verosimilmente irraggiungibile, il suo immaginario è pensato per circolare oltre i limiti dell’esperienza reale. Basta sfogliare i libri con le immagini liriche, calligrafiche, minuziosamente orchestrate del paesaggio danese. Oppure seguire il ristorante su Instagram, dove l’esperienza si sublima nella sua forma più trasferibile: un’estetica autosufficiente, che produce desiderio anche in chi non ne varcherà mai la soglia. Così, la democratizzazione del mito supera la disponibilità del tavolo. L’inaccessibilità reale diventa irrilevante di fronte alla persuasione delle immagini.