Paolo Pecere
Il problema della mente
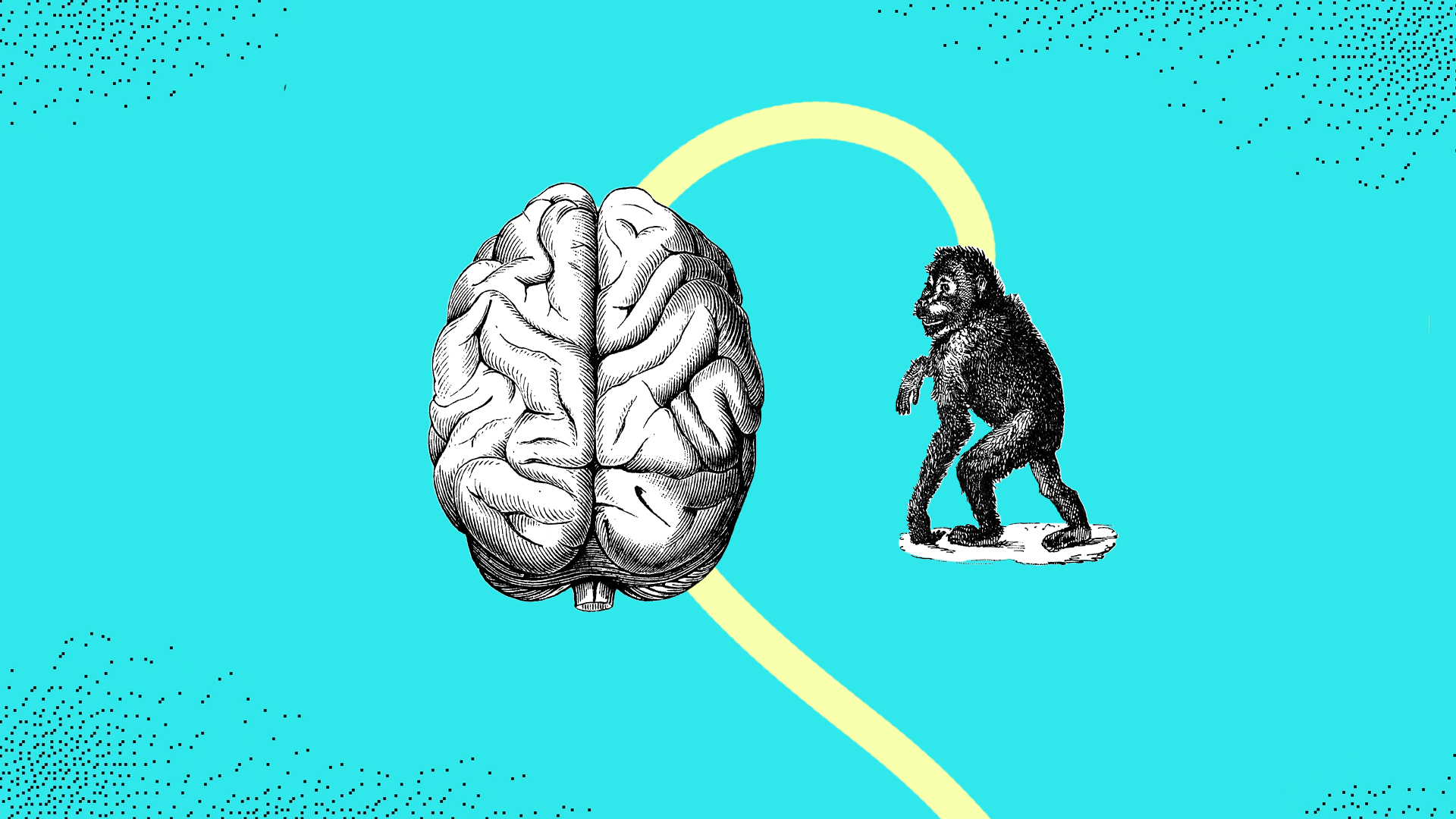
28 Giugno 2023
Come nasce il pensiero? Perché sogniamo? Cosa ci distingue dagli animali? Il mistero della mente è antico quanto l'essere umano, eppure la sua natura continua a sfuggirci.
Paolo Pecere
Paolo Pecere è filosofo e scrittore. Insegna Storia della filosofia all’Università di Roma Tre. Il suo ultimo libro è Il senso della natura. Sette sentieri per la Terra (Sellerio, 2024).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati






