Prestare soccorso in mare a chiunque si trovi in difficoltà è un dovere giuridico e morale. Eppure la storia recente del Mediterraneo centrale è dominata da interessi politici e elettorali in conflitto permanente con la legge del mare.
“Noi operiamo nel rispetto delle leggi del mare. Prestiamo soccorso ai natanti in difficoltà”.
Così parlava l’ammiraglio Filippo Maria Foffi, capo del Comando della squadra navale della Marina militare italiana, nell’estate del 2014. Era l’epoca di Mare Nostrum, la più grande missione di salvataggio in mare dalla Seconda guerra mondiale, lanciata dal governo di Enrico Letta dopo il terribile naufragio del 3 ottobre 2013 a largo di Lampedusa (368 morti).
Il dispositivo dispiegato era mastodontico: tra i 700 e i 1000 militari, cinque unità continuativamente in mare, elicotteri, aerei e reti radar. Nei dodici mesi in cui è rimasta in funzione, Mare Nostrum ha tratto in salvo circa 190mila persone. Foffi era a capo delle operazioni.
Lo intervistai nella sede della Marina militare a Roma per il documentario Maybe tomorrow, che stavo girando insieme a Mario Poeta per conto del Consiglio Italiano Rifugiati (CIR). L’ammiraglio snocciolava con orgoglio le cifre delle operazioni di salvataggio. Finita l’intervista ufficiale e nel chiuso del suo ufficio, gli feci notare che quelle stesse navi che ora portavano in Italia i migranti erano state impiegate pochi anni prima per respingerli forzatamente in Libia. Foffi mi guardò, si abbandonò sulla poltrona e mi disse: “Ci hanno fatto fare cose di cui ci vergogneremo per sempre”.
Quella dei respingimenti in mare verso la Libia è una delle pagine più buie della storia della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale. Tra il 2009 e il 2010, più di mille tra uomini, donne e bambini sono stati prelevati in alto mare da unità militari italiane e riportati indietro con l’inganno. Nel febbraio del 2012, l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per questa pratica, in quanto aveva violato diversi diritti fondamentali, tra cui il divieto di sottoporre a tortura e il divieto di espulsioni collettive.
Quando, pochi mesi prima della sentenza, avevo incontrato insieme ad Andrea Segre i migranti respinti – per il documentario Mare chiuso – mi avevano raccontato quelle violazioni: di come era stato assicurato loro che stavano navigando verso la Sicilia e di come si erano accorti che stavano invece andando in Libia dalla posizione del sole, che era sorto a sinistra e non a destra. Di come avessero chiesto spiegazioni all’equipaggio. E di come i militari all’improvviso avessero cambiato atteggiamento, li avessero ammanettati e chiusi a chiave sottocoperta fino all’arrivo a Tripoli.

Il racconto successivo era un crescendo di orrori: la consegna alle autorità libiche, la detenzione in centri di raccolta malsani e sovraffollati, le violenze di ogni tipo. Solo lo scoppio della guerra in Libia aveva permesso loro di fuggire e trovare riparo in Tunisia, in un campo che le Nazioni Unite avevano allestito alla frontiera tra i due paesi. Era qui che li avevamo incontrati e ricostruito insieme a loro il respingimento.
Del salvataggio avevano conservato un video: si vedeva un enorme pattugliatore avvicinarsi al loro barchino. Era la nave Orione, una delle più imponenti della nostra marina militare. Dalla nave era partito un gommone, che li aveva raggiunti e provveduto alle operazioni di trasbordo. Nel descrivere minuziosamente ogni fase, alcuni ancora ribollivano di rabbia per quello che ritenevano un vero e proprio tradimento. “Quando mi hanno consegnato ai torturatori libici, gli ho detto: grazie Italia per quello che ci stai facendo”, ricordava sdegnato uno di loro. Il paradosso è che, se fossero partiti quattro anni dopo, la stessa nave li avrebbe portati in Italia e i militari non li avrebbero ammanettati, ma assistiti e rifocillati.
Nel 2013, dopo la condanna dell’Italia ma soprattutto dopo la strage di Lampedusa, le disposizioni erano, appunto, cambiate: con il lancio di Mare Nostrum, gli uomini della marina militare erano impegnati in una massiccia missione di salvataggio, anche in aree molto vicine alle coste del Nord Africa. Foffi ne parlava con compiaciuta soddisfazione, quasi che questa operazione potesse lavare l’onta di quel periodo fosco in cui le nostre navi avevano operato in violazione del diritto internazionale.
Sarebbe stata tuttavia una breve parentesi. Interrotta dopo appena dodici mesi, l’operazione Mare Nostrum è stata una soluzione di continuità in una linea dritta e implacabile che ha portato alla progressiva chiusura del Mediterraneo nel tentativo, peraltro sempre fallito, di ridurre la consistenza dei flussi in partenza. Una politica portata avanti dai governi di ogni colore, che è stata accompagnata dalla graduale colpevolizzazione di quanti, intenzionalmente o casualmente, prestano soccorso alle barche dei migranti.
“Tra il 2009 e il 2010, più di mille tra uomini, donne e bambini sono stati prelevati in alto mare da unità militari italiane e riportati indietro con l’inganno”.
Il canale di Sicilia è da anni al centro di una guerra a bassa intensità tra la politica e il diritto del mare, tra i governanti a terra che vogliono piegare leggi e convenzioni internazionali ai loro domestici interessi elettorali e uomini e donne di mare che rispondono al dovere giuridico ma anche morale di prestare soccorso a chiunque si trova in difficoltà e di portarlo nel porto sicuro più vicino.
La storia del Mediterraneo centrale degli ultimi trent’anni è segnata indelebilmente da questo conflitto. Un conflitto permanente, sempre presente sottotraccia, che ha prodotto un numero elevatissimo di vittime. I morti nel Mediterraneo negli ultimi dieci anni sono stimati dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) intorno ai 28mila. Una stima al ribasso, per stessa ammissione dell’organizzazione, perché molti naufragi semplicemente non si conoscono. La domanda è: sono vittime collaterali di un conflitto tra attori che operano intorno a una frontiera chiusa, o sono vittime deliberate di una politica che considera queste perdite un’accettabile misura deterrente nei confronti di altri candidati all’emigrazione?
Per restituire una dimensione storica a questa guerra, bisogna individuarne le cause e definirne lo svolgimento. La data di inizio del conflitto si colloca ai primi anni Novanta: per entrare a far parte dell’area di libera circolazione europea definita dall’accordo di Schengen, l’Italia inserisce l’obbligo dei visti d’ingresso per i cittadini degli stati rivieraschi. Come fa notare il giornalista Gabriele Del Grande, che ha ricostruito questa storia nel libro Il secolo mobile (Mondadori, 2023), fino ad allora i marocchini, i tunisini, gli egiziani, arrivavano in aereo con il solo passaporto.
L’introduzione del visto trasforma il Mediterraneo in un mare chiuso, una frontiera impermeabile legalmente, in cui finiscono per operare diversi attori: gli scafisti, che offrono a pagamento il servizio del passaggio irregolare; le navi militari europee, che a seconda dei momenti bloccano o soccorrono; e i guardacoste degli stati del Sud, che a seconda dei momenti anche loro facilitano o frenano le partenze.
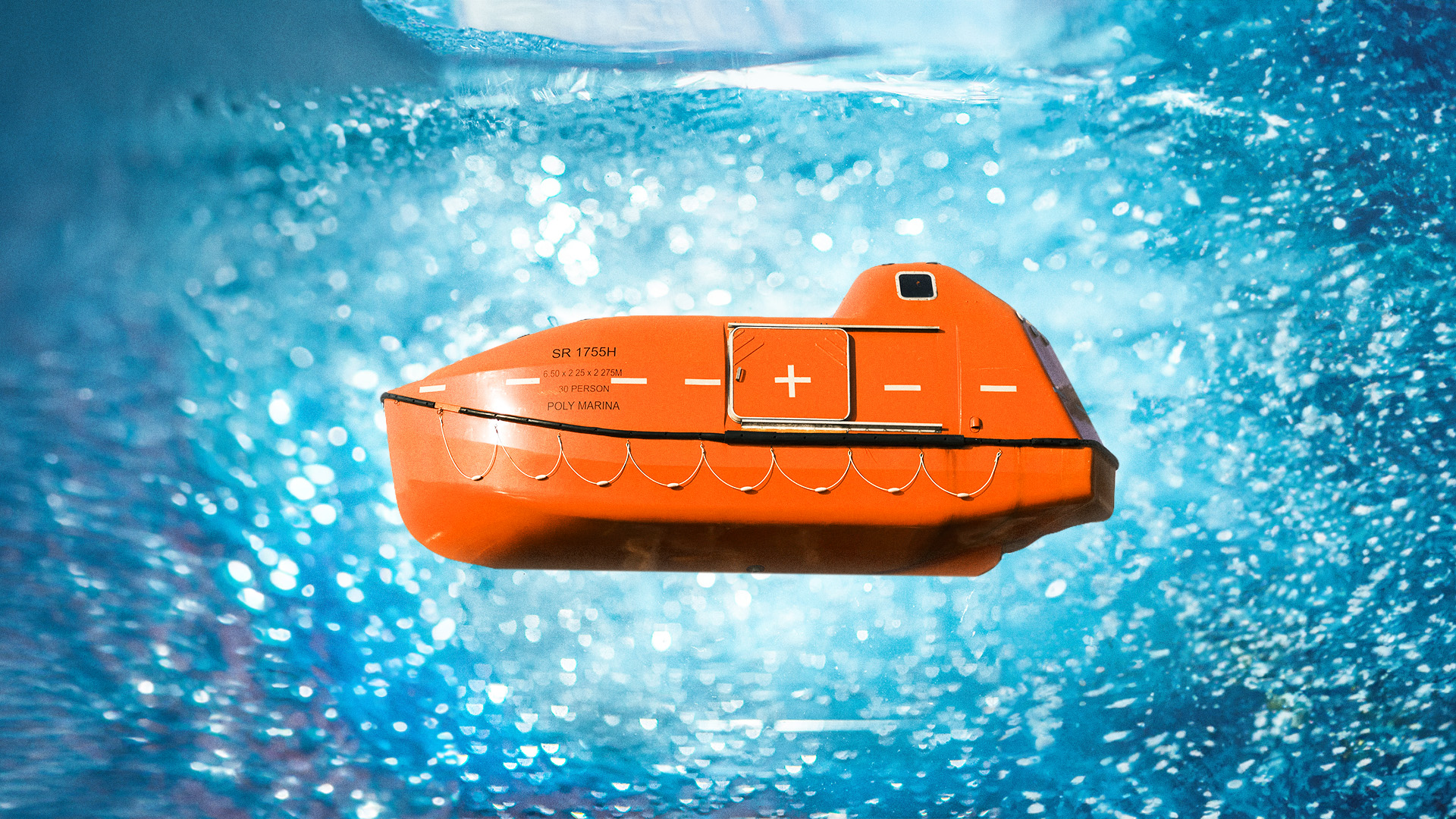
Il primo grande atto di guerra si consuma il 28 marzo 1997 nel canale di Otranto, con la cosiddetta “strage del venerdì santo”, ricostruita con maestria dal compianto giornalista Alessandro Leogrande nel libro Il naufragio (Feltrinelli, 2011). L’Albania è allora in preda a una pesante crisi economica, che sta spingendo migliaia di persone a cercare rifugio e fortuna in Italia. Come conseguenza, il governo di centro-sinistra guidato da Romano Prodi istituisce un vero e proprio blocco navale. Stabilisce misure di controllo e pattugliamento nelle acque tra i due Stati, che prevedono anche il ricorso a procedure di harassment, ovvero ‘azioni cinematiche di disturbo e di interdizione’.
Proprio queste azioni messe in atto dalla corvetta militare Sibilia portano allo speronamento e all’affondamento della Kater I Rades, una nave di fabbricazione sovietica che trasportava 120 migranti albanesi. 108 di loro moriranno nell’incidente. A seguito di un lungo processo, saranno condannati (a pene lievi) solo il comandante della Sibilla Fabrizio Laudadio, e quello della Kater I Rades, Namik Xhaferi. Nessun ufficiale di più alto grado viene coinvolto, né viene interpellata la politica che ha di fatto istigato l’azione.
Se il naufragio della Kater-I rades è un unicum, perché vede il coinvolgimento diretto in un naufragio di una nave militare italiana, la politica inaugurata dal governo Prodi fa scuola e diventa un paradigma di riferimento. Non è più richiesto di frapporsi alle navi italiane, ma a quelle degli Stati di partenza. Si fanno accordi sempre più articolati, in cui si delega alle fregate dei paesi sull’altra sponda – in accordo con le unità militari italiane ed europee e con l’ausilio di unità e strumenti ceduti ad hoc – la gestione dei flussi, con l’esplicita richiesta di bloccarli con ogni mezzo.
“La storia del Mediterraneo centrale degli ultimi trent’anni è segnata indelebilmente da questo conflitto. Un conflitto permanente, sempre presente sottotraccia, che ha prodotto un numero elevatissimo di vittime”.
Gli anni successivi, mentre aumenta la pressione migratoria dalle coste del Nord Africa, sono segnati da questa accresciuta cooperazione con gli stati di partenza – la Libia, la Tunisia, l’Egitto – per bloccare i flussi migratori in cambio di fondi, di equipaggiamento, di tecnologia. Mentre si cerca di blindare il mare con la cooperazione degli stati del Sud, le mutevoli condizioni politiche rendono questi accordi sempre meno efficaci. I guardacoste libici a cui è avocato il controllo delle partenze sono gli stessi che, mentre Gheddafi negozia e a maggior ragione dopo la sua caduta nel 2012, organizzano i viaggi. In Tunisia, la rivoluzione prima e il successivo caos politico inficiano ogni azione di controllo.
Le partenze quindi continuano. Nonostante gli annunci e i proclami, i governi sanno che non possono fare dei blocchi navali né operare dei respingimenti alla luce del sole. Quindi mettono in atto un’altra politica: l’omissione di soccorso. Dopo la fine di Mare Nostrum, le navi militari italiane si ritirano. La missione lanciata dal governo Letta viene chiusa perché ritenuta un fattore di attrazione per le partenze e sostituita con la missione europea Triton, il cui stesso mandato esplicita la diversa natura: non è più mirata al soccorso delle persone in difficoltà, ma al controllo delle frontiere esterne. Il Canale di Sicilia rimane sguarnito. Parallelamente, viene messo in atto un meccanismo di criminalizzazione di quanti soccorrono i migranti.
Gli ultimi nove anni, dalla chiusura di Mare nostrum a oggi, sono marcati da questa tendenza. Lo sanno bene i sei pescatori di Zarzis, in Tunisia, che nel 2018 hanno trascorso un mese in carcere ad Agrigento con l’infamante accusa di essere trafficanti solo per aver soccorso un barchino in difficoltà e averlo scortato a Lampedusa. Lo sanno bene gli operatori delle Organizzazioni non governative che si sono visti accusare di essere “taxi del mare”, hanno visto le proprie barche sequestrate, e i loro operatori finire sotto processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nei momenti parossistici della guerra di bassa intensità, quando la gestione è affidata alle frange più ideologiche, si consumano persino scontri fra i poteri dello stato. Accade nel 2018, quando la nave della guardia costiera Ubaldo Diciotti rimane bloccata una settimana al porto di Catania con 137 migranti salvati perché il ministro degli interni Matteo Salvini non autorizza lo sbarco. E ancora nel 2019, quando sempre Salvini impedisce l’attracco alla nave della marina militare Bruno Gregoretti, che rimane quattro giorni al largo di Augusta con 131 migranti a bordo.
Ma in generale, il governo italiano porta avanti una politica fatta di un doppio binario: accordi con gli stati di partenza per delegare loro la gestione dei flussi, in cambio di generosi fondi ed equipaggiamenti, e disimpegno dal canale di Sicilia.
“Nonostante gli annunci e i proclami, i governi sanno che non possono fare dei blocchi navali né operare dei respingimenti alla luce del sole. Quindi mettono in atto un’altra politica: l’omissione di soccorso”.
Quest’ultimo processo avviene attraverso il ritiro delle forze navali statali e l’allontanamento di tutti gli operatori privati che potrebbero portare soccorso, seguendo il teorema mai dimostrato che la presenza di operatori di salvataggio genera un aumento le partenze. I pescatori e le navi cargo che solcano il Mediterraneo sono portati a ignorare i barchini, per non incorrere nel rischio di processi o in costosi blocchi delle proprie attività. Le Ong sono scoraggiate nell’intervento, con sanzioni e misure punitive di ogni genere, non ultima l’assegnazione di porti di sbarco anche lontanissimi dal canale di Sicilia, come quelli nel Mar Ligure o nell’Adriatico settentrionale.
L’obiettivo non dichiarato è scoraggiare i soccorsi, lasciare il canale non pattugliato come forma di deterrenza alle partenze. Il risultato è quello che si legge sul sito del’OIM, Missing Migrants, che fa il conteggio dei migranti morti nel tentativo di attraversare le frontiere.
Il Mediterraneo è la rotta più mortale al mondo. Oggi, mentre scrivo queste righe, il macabro contatore indica 28.196 vittime dal 2014. Ma domani questa cifra potrebbe essere già più alta. Con buona pace delle leggi del mare e di tutti quegli uomini e donne che non vorrebbero voltarsi dall’altra parte ma che sono sempre più ostacolati e messi nell’impossibilità di mitigare le conseguenze di questo conflitto a bassa intensità che da trent’anni si combatte nel Mediterraneo.
Questo articolo è stato realizzato con la collaborazione di Indigo Film, in occasione dell’uscita del film Comandante, di Edoardo De Angelis.






