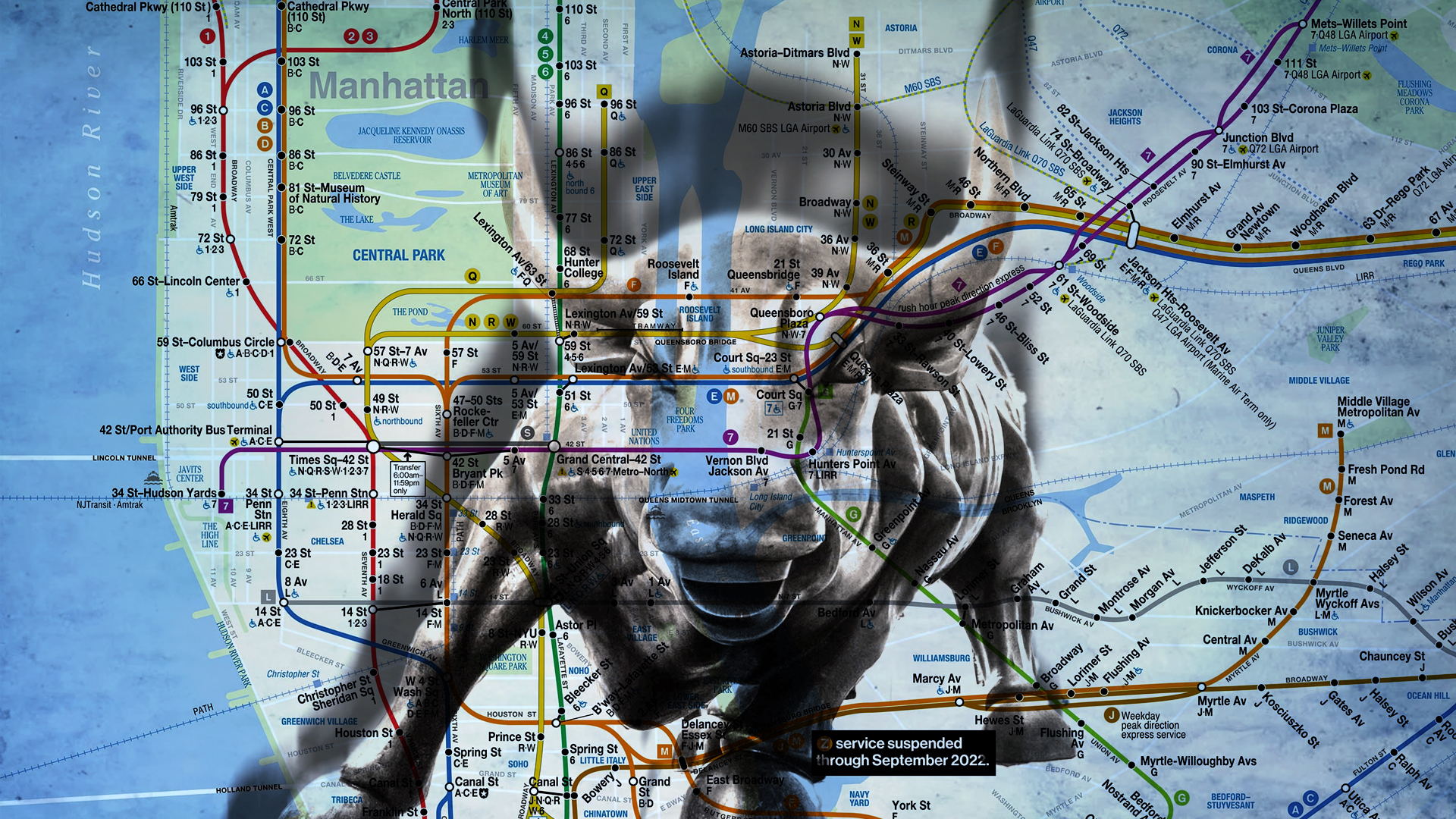
Francesco Pecoraro
La città e l’ansia
08 Settembre 2023
La forma di certe metropoli somiglia in maniera sinistra a quella della nostra psiche: è per questo, forse, che perdendoci nel delirio urbano, ci capita di essere presi dal panico e di sentirci riconosciuti.
La città e l’ansia
Francesco Pecoraro
Francesco Pecoraro è architetto, poeta, scrittore. Il suo ultimo libro si intitola Solo vera è l’estate (Ponte alle Grazie, 2023).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati






