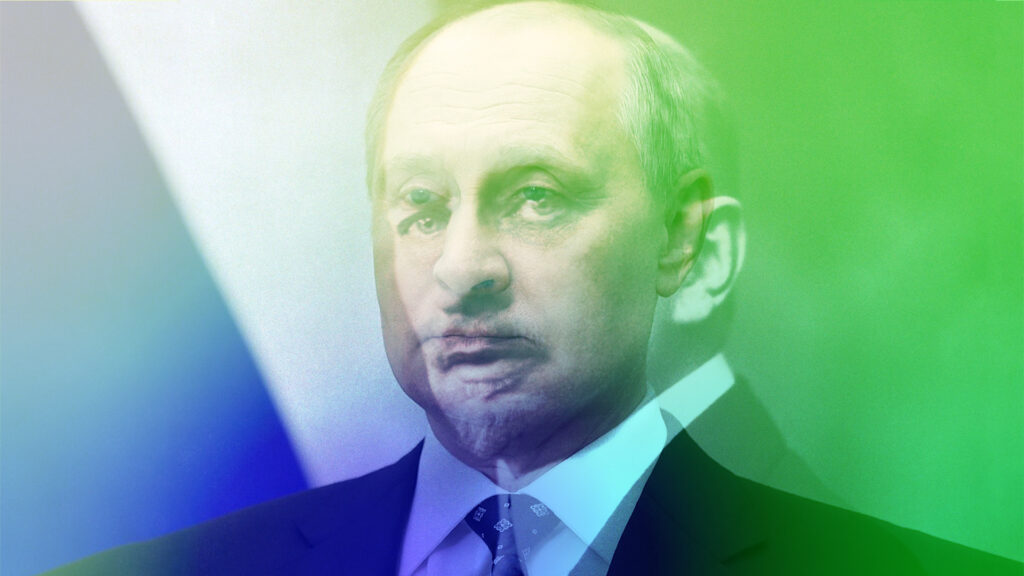Nadeesha Uyangoda
La lingua che abitiamo

Se per alcuni la lingua è un luogo accogliente, per altri è invece un terreno insidioso. Considerazioni intime e politiche di chi ha saggiato le lame di uno strumento che all’apparenza non ne possiede.
Ágota Kristóf, L’analfabeta (Edizioni Casagrande, 2005).
La guerra civile in Sri Lanka è iniziata nel 1983, tra il governo della Repubblica e l’LTTE, il gruppo separatista delle Tigri Tamil per la liberazione del Tamil Eelam (inserita nel 2006 dall’Unione Europea nella lista delle organizzazioni terroristiche). La guerra, terminata nel 2009, è stata anticipata dalle violente persecuzioni della minoranza tamil del 1956, 1958, 1977, 1981 e 1983.
L’Australia ha introdotto questi test nel 1999; la Svezia li ha messi a punto dagli anni ’80; altri paesi, come l’Olanda, la Germania e la Svizzera, conducono i propri test; la Gran Bretagna e la Nuova Zelanda ne fanno uso.
Adrienne Rich, Bruciare carta invece che bambini da Cartografie del silenzio (Crocetti Editore, 2000).
Elias Canetti, La provincia dell’uomo (Adelphi, 1978).
Nadeesha Uyangoda
Nadeesha Uyangoda è giornalista e scrittrice. Collabora con «Repubblica» e altre testate. Il suo ultimo libro è Corpi che contano (66thand2nd, 2024).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati